 È bellissimo. Leggetelo.
È bellissimo. Leggetelo.
L’udienza è tolta.
Potrebbe bastare, ma vi attaccherò comunque un piccolo pippone d’incoraggiamento. Gabrielle Zevin e il suo Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow – che trovate in libreria per Nord con la traduzione di Elisa Banfi – se lo meritano.
Nel 1995, Sam e Sadie si incontrano per caso in metropolitana. Sono entrambi arrivati a Boston dalla California per studiare – MIT e Harvard, per non smentire il percorso da bambini prodigio già ben consolidato. Si conoscono già da un’infanzia più tenera (e nel caso di Sam anche molto più impervia) ma non si parlano da anni e, senza quella zampata del destino e qualche decisione deliberata presa al momento giusto, resterebbero probabilmente degli estranei, privando il mondo di alcuni videogiochi straordinari. Giocare insieme è stato il cemento della loro amicizia, uno spazio in cui entrambi hanno accantonato maschere e paure per immaginare un posto sicuro e deporre le armi. I loro cervelli si completano, ma è sui loro cuori che si può fare meno affidamento.
Il romanzo parte da questo riavvicinamento fortuito per accompagnarci nei mondi di Sam e Sadie, quelli che hanno inventato e programmato insieme – invitando al gioco una vastissima moltitudine di altri gamer in erba – e quelli che hanno attraversato fianco a fianco vivendo, accapigliandosi e cercando di fare a meno l’uno dell’altra – fallendo sempre, come in un livello particolarmente frustrante di Donkey Kong. In mezzo troviamo genealogie che non bastano a definire un’identità, seconde generazioni di “nuovi” americani, mentori viscidi e magnetici, amicizie che sono famiglia, dispute lavorative, testardaggini creative, rivalità, bolle tecnologiche non ancora scoppiate, dilemmi etici mascherati da gioco, un piede inaffidabile – e mai accettato, nella sua fallibilità -, pizzerie coreane, attrici e attori, Macbeth e l’Iliade, successi clamorosi e cantonate.
C’è, con decisione, un impianto filosofico che unisce il gioco alla fiducia nel domani. Perché giochiamo? Per sconfiggere la morte, per convincerci che si possa sempre ricominciare da capo e fare meglio, anche se sappiamo fin troppo bene che non ci è mai davvero concesso.
“Cos’è un gioco? È domani, e domani, e domani. È la possibilità dell’eterna rinascita, dell’eterna redenzione. L’idea che, se continui a giocare, puoi vincere. Se perdi, non è per sempre, perché nulla è mai per sempre”.
Non c’è Game Over che regga, in un universo costruito per stupirti e per farti continuare a giocare: quell’infinita e inesauribile possibilità di afferrare un altro “domani”, indipendentemente da quanto tu possa aver fatto schifo nell’oggi, è una corazza confortante. Non ripara dal male, dal caso, dal caos e dal dolore – come Sam e Sadie ben sanno -, ma è un orizzonte che mantiene intatta quell’idea di potenzialità infinita, di “nessuna strada mi è ancora preclusa” che è la magia vera della giovinezza. Forse si gioca da “piccoli” con così tanta convinzione proprio perché ci si rispecchia in quell’attitudine da pioniere libero di scovare percorsi non ancora bruciati dal fallimento, dalla paura, dalle aspettative disattese. Non è una metafora d’originalità devastante, ma qua dentro funziona e trova un’anima degna – anche se le produzioni universitarie di Shakespeare non possono vantare un budget faraonico.
Ribadisco: è bellissimo.
È necessaria una vasta cultura videoludica? Secondo me no. Aiuta che v’interessi? Penso di sì. Ma non precludetevi un romanzo così meritevole e “vivo” (nonostante le ovvie licenze) per ipotetici deficit sul fronte dei giochi, specialmente se siete stati adolescenti nel primo decennio del Duemila. E se vi intrigano le storie aziendali (eccomi!), ancora meglio. Altra nota: siete da sempre team-Achille? Ne riparleremo a fine lettura. Tornate a dirmelo. 🙂



 Il lavoro dei miei genitori – che era stato “certo” e “fisso” sin da subito e da un’età precoce, per gli standard attuali – occupava da sempre una fetta importante delle loro giornate, ma produceva anche dei benefici tangibili. Lavoravano, ma pareva ne valesse la pena. Lavoravano, ma esistevano delle certezze materiali di cui tutti quanti potevamo godere, ricompensandoli dell’indubbia fatica che per anni han fatto pure loro. Mia madre, dopo un paio di mesi dall’inizio del mio stage, giudicava con manifesto scandalo la mia scarsa propensione al risparmio. Nell’universo in cui era abituata a muoversi lei, infatti, c’erano di certo dei sacrifici e delle decisioni da prendere, ma non c’erano affitti da pagare, futuri più incerti della media e bilanci stabilmente in passivo. Se lavori riuscirai a mantenerti. Se lavori riceverai in cambio il necessario per fronteggiare i tuoi bisogni e gestire oculatamente anche il tuo futuro. Il fatto che non si rendesse conto che, con un rimborso spese di 500€ mensili – o, più tardi, con uno stipendio da neoassunta di 1.100€ -, il risparmio fosse un lusso è un altro tassello del problema. Ero di sicuro io che non sapevo farmi valere o che non lavoravo abbastanza, ero io che non sapevo convertire l’istruzione che avevano profumatamente pagato in un impiego degno del mio blasonato ateneo. E il fatto che la mia azienda avesse un nome importante – uno di quelli che funzionano all’interno di un “ah, sì… siamo molto contenti, mia figlia lavora da…” – tendeva un po’ ad accrescere le dimensioni del paradosso, almeno dal mio punto di vista.
Il lavoro dei miei genitori – che era stato “certo” e “fisso” sin da subito e da un’età precoce, per gli standard attuali – occupava da sempre una fetta importante delle loro giornate, ma produceva anche dei benefici tangibili. Lavoravano, ma pareva ne valesse la pena. Lavoravano, ma esistevano delle certezze materiali di cui tutti quanti potevamo godere, ricompensandoli dell’indubbia fatica che per anni han fatto pure loro. Mia madre, dopo un paio di mesi dall’inizio del mio stage, giudicava con manifesto scandalo la mia scarsa propensione al risparmio. Nell’universo in cui era abituata a muoversi lei, infatti, c’erano di certo dei sacrifici e delle decisioni da prendere, ma non c’erano affitti da pagare, futuri più incerti della media e bilanci stabilmente in passivo. Se lavori riuscirai a mantenerti. Se lavori riceverai in cambio il necessario per fronteggiare i tuoi bisogni e gestire oculatamente anche il tuo futuro. Il fatto che non si rendesse conto che, con un rimborso spese di 500€ mensili – o, più tardi, con uno stipendio da neoassunta di 1.100€ -, il risparmio fosse un lusso è un altro tassello del problema. Ero di sicuro io che non sapevo farmi valere o che non lavoravo abbastanza, ero io che non sapevo convertire l’istruzione che avevano profumatamente pagato in un impiego degno del mio blasonato ateneo. E il fatto che la mia azienda avesse un nome importante – uno di quelli che funzionano all’interno di un “ah, sì… siamo molto contenti, mia figlia lavora da…” – tendeva un po’ ad accrescere le dimensioni del paradosso, almeno dal mio punto di vista.
 Chi era Lucia, la madre? Che vita può essere stata quella di una donna (ancora giovanissima) che sceglie di morire dopo aver creduto profondamente in un amore giudicato inammissibile? Chi si è lasciata alle spalle in Molise, a Palata? E chi era Giuseppe, l’uomo che le ha donato una parentesi di felicità?
Chi era Lucia, la madre? Che vita può essere stata quella di una donna (ancora giovanissima) che sceglie di morire dopo aver creduto profondamente in un amore giudicato inammissibile? Chi si è lasciata alle spalle in Molise, a Palata? E chi era Giuseppe, l’uomo che le ha donato una parentesi di felicità?
 Non so se si tratti di una stortura generazionale o probabilmente solo di una difficoltà molto privata e circoscritta ma, arrivata a un’età in cui non ho più motivo di scandalizzarmi se qualcuno mi si rivolge con signora, mi rendo conto di essermi trasformata in una lettrice disabituata alla poesia. Quando la poesia mi “trova” ne rimango affascinata e nutrita, ma si tratta quasi sempre di collisioni fortuite. Recupero con interesse vivissimo il lavoro poetico di autori e autrici che sono solita leggere in prosa o in un universo romanzesco, ma ho quasi sempre il timore di non essere abbastanza *sveglia* per squarciare il velo. Forse mi preoccupo ancora di dover essere interrogata alla seconda ora o di dover elencare a memoria tutte le figure retoriche che riesco a individuare in una strofa. Forse patisco un imprinting scolastico che ben poco ha fatto leva sulla meraviglia e sul potere della parola. O forse mi ritrovo a sgambettare in una bolla in cui ancora resiste il mito della poesia “difficile”, di quest’arte oscura e rarefatta che parla solo a spiriti eletti, alatissimi e immuni dai crucci del quotidiano.
Non so se si tratti di una stortura generazionale o probabilmente solo di una difficoltà molto privata e circoscritta ma, arrivata a un’età in cui non ho più motivo di scandalizzarmi se qualcuno mi si rivolge con signora, mi rendo conto di essermi trasformata in una lettrice disabituata alla poesia. Quando la poesia mi “trova” ne rimango affascinata e nutrita, ma si tratta quasi sempre di collisioni fortuite. Recupero con interesse vivissimo il lavoro poetico di autori e autrici che sono solita leggere in prosa o in un universo romanzesco, ma ho quasi sempre il timore di non essere abbastanza *sveglia* per squarciare il velo. Forse mi preoccupo ancora di dover essere interrogata alla seconda ora o di dover elencare a memoria tutte le figure retoriche che riesco a individuare in una strofa. Forse patisco un imprinting scolastico che ben poco ha fatto leva sulla meraviglia e sul potere della parola. O forse mi ritrovo a sgambettare in una bolla in cui ancora resiste il mito della poesia “difficile”, di quest’arte oscura e rarefatta che parla solo a spiriti eletti, alatissimi e immuni dai crucci del quotidiano.


 Animato da un interesse antropologico che a tratti lascia trasparire un “vi prego, fatemi scendere”, in
Animato da un interesse antropologico che a tratti lascia trasparire un “vi prego, fatemi scendere”, in 

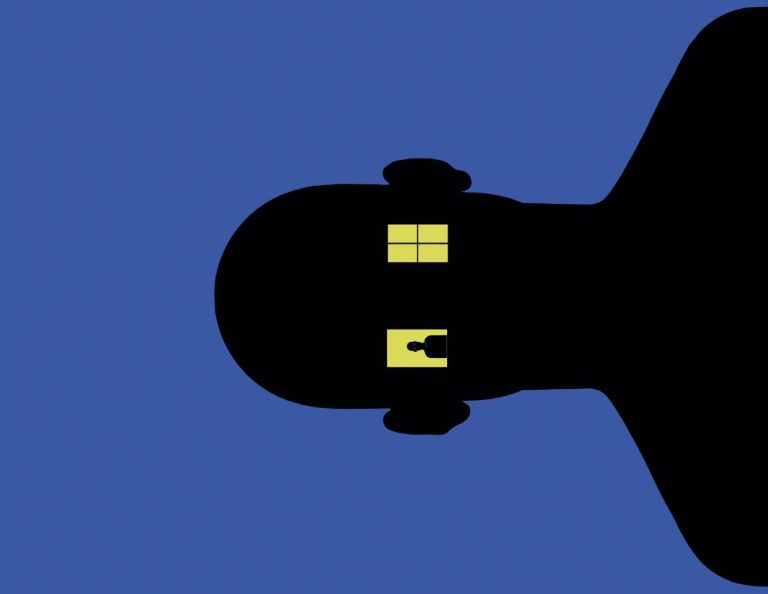


 Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.
Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.

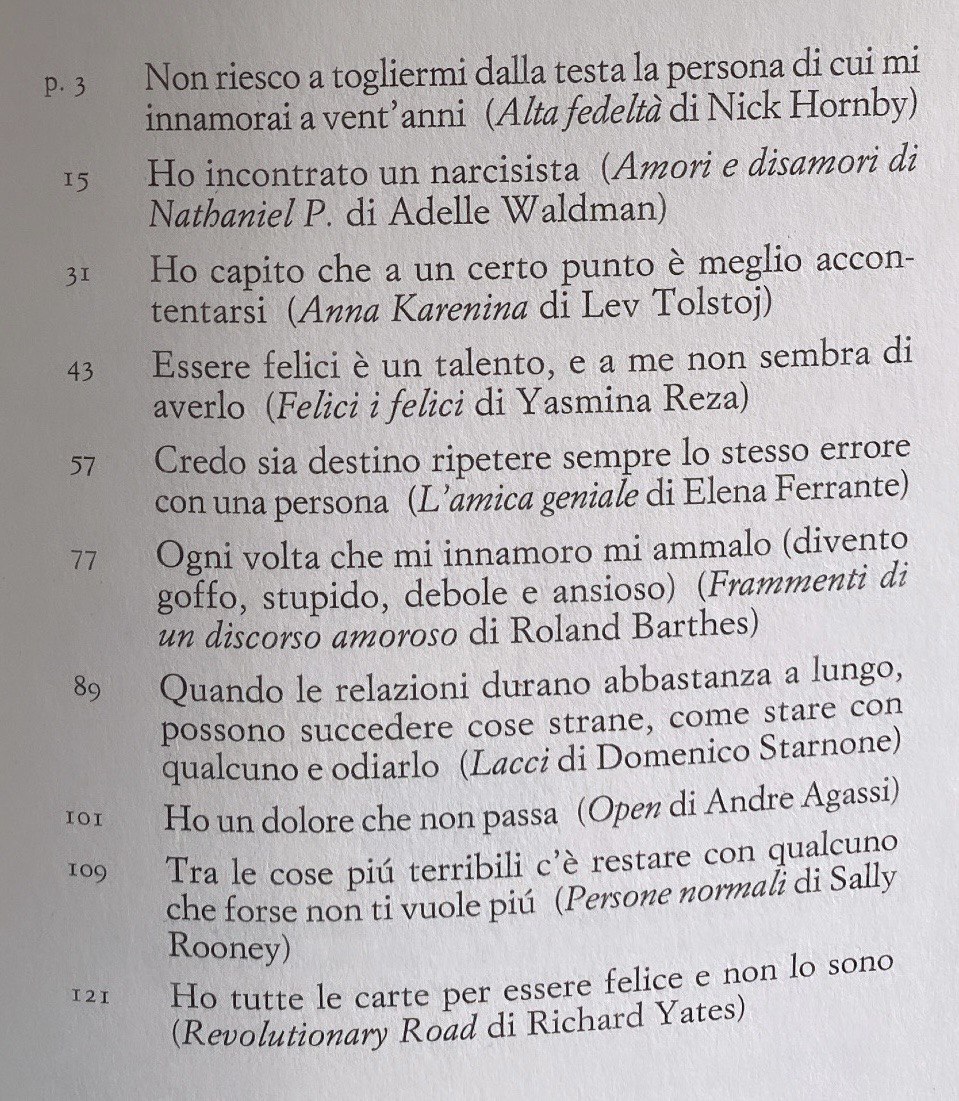


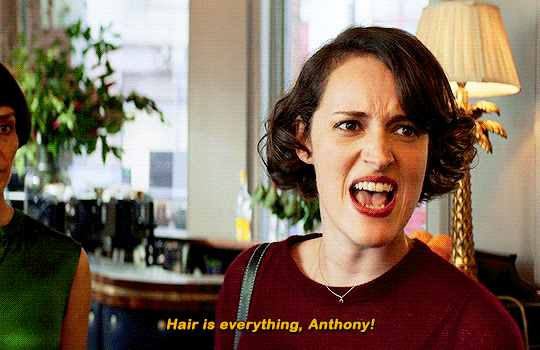
 Son solo le sfighe a schiacciarci o possono pensarci anche le fortune? Maria Cristina è un magnifico vaso di coccio in mezzo a tantissimi recipienti molto meno gradevoli alla vista ma più coriacei – e forse pure pieni di qualcosa, più capaci di orientarsi nel mondo, più duttili e scafati. Accusata spessissimo e volentieri di sapere di poco, percepita quasi universalmente come appendice muta e gradevole a vedersi di uomini importanti – dal primo marito scrittore al premier in carica – e cronicamente in cerca di un punto di riferimento che non la abbandoni in circostanze tragiche, Maria Cristina cerca di limitare i danni e di tenere in piedi le apparenze, ma avrà mai la possibilità di raccontare davvero una storia che sia sua? Il domandone si fa ineludibile quando, per un fortuito incrocio di antiche traiettorie, Maria Cristina si imbatte in una fiamma di gioventù che le gira un video “d’archivio” potenzialmente in grado di devastarle la vita. Barcollando – anche grazie a un alluce tumefatto – sul filo sottile dell’accettabilità, Maria Cristina andrà di fatto alla ricerca del suo nucleo reale, spogliandosi come una favolosa cipolla di tutte le stratificazioni, le preoccupazioni e le sovrastrutture che la spingono automaticamente a mettersi in posa per una schiera di fotografi ipotetici anche quando è da sola in mezzo a un bosco. Chi diventiamo, quando smettiamo di volercelo far dire dal riflesso che produciamo sugli altri? Che cosa serve davvero per sentirci in pace?
Son solo le sfighe a schiacciarci o possono pensarci anche le fortune? Maria Cristina è un magnifico vaso di coccio in mezzo a tantissimi recipienti molto meno gradevoli alla vista ma più coriacei – e forse pure pieni di qualcosa, più capaci di orientarsi nel mondo, più duttili e scafati. Accusata spessissimo e volentieri di sapere di poco, percepita quasi universalmente come appendice muta e gradevole a vedersi di uomini importanti – dal primo marito scrittore al premier in carica – e cronicamente in cerca di un punto di riferimento che non la abbandoni in circostanze tragiche, Maria Cristina cerca di limitare i danni e di tenere in piedi le apparenze, ma avrà mai la possibilità di raccontare davvero una storia che sia sua? Il domandone si fa ineludibile quando, per un fortuito incrocio di antiche traiettorie, Maria Cristina si imbatte in una fiamma di gioventù che le gira un video “d’archivio” potenzialmente in grado di devastarle la vita. Barcollando – anche grazie a un alluce tumefatto – sul filo sottile dell’accettabilità, Maria Cristina andrà di fatto alla ricerca del suo nucleo reale, spogliandosi come una favolosa cipolla di tutte le stratificazioni, le preoccupazioni e le sovrastrutture che la spingono automaticamente a mettersi in posa per una schiera di fotografi ipotetici anche quando è da sola in mezzo a un bosco. Chi diventiamo, quando smettiamo di volercelo far dire dal riflesso che produciamo sugli altri? Che cosa serve davvero per sentirci in pace?