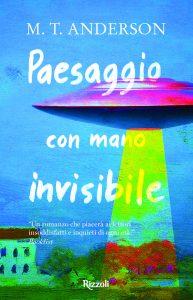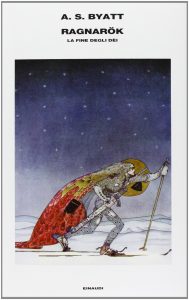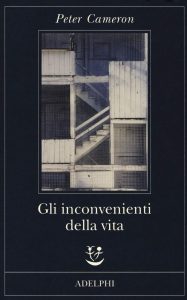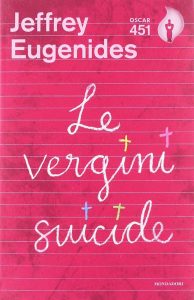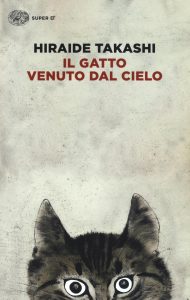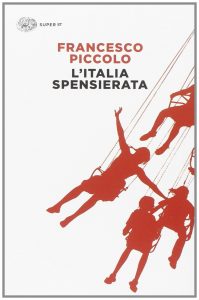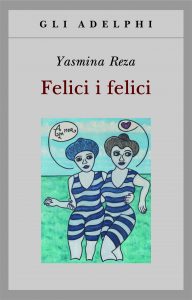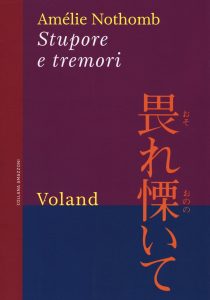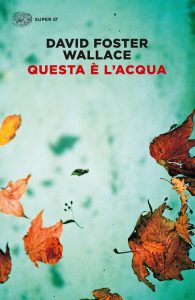[Sì, come copertina del post ho scelto un evocativo fotogramma del camino di Netflix, pietra miliare delle feste nella nostra abitazione.]
Poche tradizioni si confermano salde – almeno da queste parti – come il listone dei libri da donare e/o farvi donare a Natale.
Il consiglio metodologico è sempre lo stesso: basiamoci un po’ meno sul mero dato demografico – AKA “cosa regalo a mia figlia che ha 24 anni?” – e cerchiamo di riflettere meglio su interessi spiccati, passioni manifeste e ambizioni esplorative dei destinatari e delle destinatarie. Un dono funziona se asseconda il cuore di chi lo riceve, credo, e la vivace produzione editoriale limitrofa al Natale – la vasta schiera delle famigerate “strenne” – è qua per assisterci con gran lena.
In vista delle feste faccio del mio meglio per assemblare lenzuolate di consigli in grado di inserirsi in maniera chiara in un determinato tema o filone, privilegiando magari le edizioni un po’ più “importanti” del consueto. Troverete dunque libri di grande formato, argomenti disparatissimi e anche parecchi illustrati. L’auspicio generale è di far felice chi aprirà il pacchetto (anche se fate schifo a fare i pacchetti, tipo me) e anche di farvi fare bella figura.
Visto che i libri non scadono, per completezza vi incoraggio anche a consultare le edizioni precedenti delle guide natalizie. Trovate qua quella del 2020 e qua quella del 2019.
Procediamo? Procediamo, che nel mondo c’è scarsità di carta.
***

Mateusz Urbanowicz
Botteghe di Tokyo
(L’ippocampo)
Arrivato in Giappone nel 2016 per lavorare come illustratore di sfondi per uno studio d’animazione di Tokyo, Urbanowicz ha esplorato in lungo e in largo la città armato di macchina fotografica, catturando tanti di quelli che sulle guide turistiche che piacciono alla gente che piace tendono ad essere classificati come “posticini caratteristici”. Ha iniziato a disegnare, con poetica meticolosità, le facciate delle botteghe che più l’avevano colpito, alimentando gradualmente una collezione che nel tempo si è espansa fino a riempire questo meraviglioso volume. Diviso per quartieri, Botteghe di Tokyo è sia un esercizio visivo di rara bellezza che una guida alle numerose attività commerciali, spesso minuscole, che sembrano rievocare un’altra epoca e riportarci a una dimensione di familiare accoglienza e antiche stratificazioni.
*

Irene Cuzzaniti
La casa verde. Piante e composizioni per ogni stanza
24 Ore Cultura
Sono innegabilmente diventata una gattara delle piante. Balcone, salotto, camera da letto… non c’è ambiente che venga risparmiato dalla mia furia verdeggiante. In questo adorabile manuale illustrato – che va benone anche per chi è alle prime armi -, Irene Cuzzaniti ci fornisce le informazioni base per cominciare a fare amicizia con le piante e per scegliere quelle più adatte ai nostri spazi. Il volume è diviso per ambienti domestici e propone anche numerosi tutorial ben fotografati e spiegati per destreggiarvi tra diversi progetti ornamental-orticoli, dai centrotavola al terrario aperto per i cactus.
*

Tracy Turner & Andrew Donkin
La storia del mondo in 25 città
(Nord Sud)
Dall’antica Menfi alla San Pietroburgo degli zar (in odore di sanguinosa deposizione), diecimila anni di storia globale condensati in 25 mappe “parlanti”, per esplorare le città diventate simbolo di una precisa epoca o di un balzo “evolutivo” potenzialmente rivoluzionario per il genere umano. Un volume visivamente splendido – curato dal British Museum – che soddisfa curiosità topografiche e sintetizza con puntualità gli aspetti più salienti di civiltà, popoli e snodi geopolitici irripetibili.
*

Art Spiegelman
Maus
Cofanetto in 2 volumi
(Einaudi)
Stile Libero ospita già da lunghissimo tempo Maus nel suo ricco catalogo e, negli anni, sono usciti anche diversi materiali “extra”, che completano l’universo di Art Spiegelman aggiungendo tasselli sempre preziosi alla sua opera più emblematica. È uno di quei libri per cui vale la pena sprecare l’abusata definizione di “necessario” e, se l’idea è quella di tramandarci un’opera fondamentale e di passare il testimone della memoria a chi ancora non ha avuto occasione di leggerlo, una nuova edizione è rubricabile tra le buone notizie. Dall’immagine si intuisce poco, ma questo Maus è in due volumi – che rispettano la suddivisione originaria di Spiegelman – raccolti in un cofanetto che contiene anche un sedicesimo con disegni preparatori, un albero genealogico dell’autore (pre e post Seconda Guerra Mondiale) e due storie brevi, uscite in altri lidi ma propedeutiche a Maus.
*

Daniela Collu
Perché no? Il libro delle domande… che con le risposte sono tutti bravi
(Mondadori)
Da millenni ci rimettiamo alla presunta sapienza di oracoli di ogni genere, uscendone irrimediabilmente più confuse e confusi di prima. Perché non cominciare, dunque, a porci domande migliori invece di cercare risposte fin troppo semplici? Daniela Collu quest’anno aveva voglia di divertirsi e, prendendo ispirazione dalle surreali sessioni di Q&A che popolano le sue Instagram Stories, ha deciso di ristrutturare il tradizionale Libro delle risposte – feticcio editoriale che popola da quando ne ho memoria l’area limitrofa alla cassa del 100% delle librerie di catena che m’è capitato di frequentare nella vita – ribaltandone l’assunto di base: io non ti rispondo, anzi… son qua per proporti altri abissali quesiti. Per farsi una risata e/o per disinnescare i dubbi – spesso cretinissimi – che ci attanagliano inutilmente.
*

Wally Koval
Wes Anderson, quasi per caso
(il Saggiatore)
Pochi account Instagram riescono a pacificarmi come @accidentallywesanderson. Il fenomeno è ben presto spiegabile, perché le premesse che animano questo ormai articolatissimo progetto fotografico sono le stesse che generano quel pesante effetto ipnotico che ci coglie di fronte alle pellicole di Wes Anderson. Non è più un regista “e basta”, Wes Anderson si è tramutato in una specie di vasta e puntigliosissima esperienza estetica fatta di simmetrie, piani sequenza, prospettiva centrale, un certo gusto rétro e una precisa palette di colorini. Vedendo le sue ultime imprese cinematografiche mi viene da pensare che l’ambizione estetica stia superando quella narrativa e che Wes Anderson sia ormai diventato una macchina perfetta che replica all’infinito i suoi stessi stilemi, ma la riconoscibilità di quel che produce è immediata e affascinante – per quanto io rimpianga la famiglia Tenenbaum. Questo volumone è una collezione di scorci del mondo reale che sembrano usciti da un film di Wes Anderson – ogni “quadro” è accompagnato da precise coordinate geografiche e va a comporre una variegato e pazzissimo atlante che pare l’emanazione diretta, per quanto accidentale, di scenografie, location e scorci andersoniani.
*

Ursula K. Le Guin
La mano sinistra del buio
(Mondadori)
Ursula K. Le Guin non ha avuto in Italia una storia editoriale che grida accessibilità e facile reperibilità. Io l’ho scoperta relativamente tardi, ordinando cose qua e là in lingua originale o ascoltando in inglese su Storytel – le lacune sono ancora molte, per quanto mi riguarda, ma sono felice di registrare un’accresciuta attenzione sia per l’autrice che per il fantastico/fantascientifico. The Left Hand of Darkness è uno dei suoi romanzi più celebri e ricompare ora nella nuova traduzione di Chiara Reali per la brigata di Oscar Vault: un’ottima occasione per far capolino in un universo sterminato e per sostenere una riscoperta che spero possa dimostrarsi ampia e battagliera.
[Visto che siamo in tema “libri che tornano disponibili dopo un passato un po’ singhiozzante”, Fazi ha inglobato Jonathan Strange & il signor Norrell di Susanna Clarke, ripubblicandolo in una bella edizione. Clarke è già approdata da loro con Piranesi.]
*

Caterina Zanzi (& company)
Conosco un posto. Milano
(Magazzini Salani)
Madame Zanzi è per me un molteplice punto di riferimento. Sono una fervente frequentatrice del blog – che in questi anni si è sempre dimostrato una risorsa preziosa per orientarmi a Milano – e considero anche Caterina una specie di collega fidata. Insomma, è una di quelle persone che se fa bene una cosa, come nel caso di questa guida, mi infonde fierezza e mi suscita della sincera partecipazione. Il libro è un lavorone sia di Caterina che della redazione di Conoscounposto, una sintesi ragionata e ben organizzata dal punto di vista della consultazione – sia per zona che per “occasione” – degli indirizzi migliori dove mangiare, bere, svagarsi, fare compere e “vivere” a Milano. Abito ormai da un pezzo in questa città ma non ho ancora finito di esplorarla e tanti degli spunti più azzeccati – che hanno poi prodotto ricordi belli e momenti di gioia in compagnia – li devo a Caterina e ai suoi sodali. Insomma, che siate autoctone/autoctoni o neo-Milanesi, è un tomo utile che non mi farei scappare.
*

COSE – Spiegate bene. A proposito di libri
(Il Post feat. Iperborea)
Da operatrice editoriale ormai quasi veterana, mi trovo spesso (soprattutto su Instagram) alle prese con un vasto e anche legittimo domandone: “il mio sogno è lavorare nel mondo dell’editoria. Da dove comincio? Come si fa?”. Non è un interrogativo banale, anzi. Il mondo dell’editoria viene spesso percepito come una sorta di bolla mitologica popolata da titani della cultura, nobilissimi propositi e stanze ricolme di imperdibili manoscritti. La realtà dei fatti è di certo meno poetica, ma non per questo manca di fascino. Il Post – facendosi di volta in volta aiutare da “collaboratori” d’eccezione – ha lanciato qualche mese fa una rivista a forma di libro, ospitata da Iperborea. Il primo numero – A proposito di libri – mi sta aiutando a rispondere alla domanda di partenza: fornisce un’infarinatura sintetica su come mediamente funzionano le case editrici e offre una panoramica generale su ruoli aziendali e struttura del settore, a metà tra racconto curioso e spiegone introduttivo.
Se il progetto vi interessa, è uscito anche il secondo numero: Questioni di un certo genere.
*

Antoine Pecqueur
Atlante della cultura. Da Netflix allo yoga: il nuovo soft power
(ADD Editore)
Che diamine è il “soft power”? Il concetto è stato coniato nel 1990 da Nye – politologo americano – per definire l’uso dell’arte e dei valori culturali come leva di potere a livello geopolitico. L’Atlante della cultura di Antoine Pecqueur, in trenta capitoli o casi di studio tematici, esplora i meccanismi relazionali, politici, comunicativi ed economici che compongono il grande ingranaggio dei nuovi rapporti di forza mondiali, evidenziando come la cultura – nelle sue molteplici espressioni – si sia affermata come uno dei pezzi più importanti della scacchiera, nonostante spesso rifugga le metriche numeriche “oggettive”.
Per approfondire ulteriormente, qua il post dedicato.
*

Pokémon – L’enciclopedia
(Mondadori)
Qua siamo in realtà in possesso di un vasto catalogo editoriale a tema Pokémon, un po’ perché in questa casa abita un ex-bambino che ha vissuto l’epoca d’oro dei Pokémon e un po’ perché il bambino vero che abbiamo messo al mondo si sta godendo con grande trasporto il revival – già, sono usciti parecchi cartoni nuovi e l’universo dei Pokémon pare destinato a un’espansione infinita. Insomma, non di soli Pikachu, Charizard e Bulbasaur campano i giovani virgulti del presente e questa enciclopedia è un garrulo strumento per aggiornare le vostre antiche conoscenze o passare il testimone alle generazioni future.
*

Brooke Vitale & Teo Skaffa
I Goonies. La storia illustrata
(Nord Sud)
Mi sono infilata nel tunnel del vintage coi Pokémon, tanto vale proseguire con un’altra pietra miliare della mia infanzia: i Goonies! Anche in questo caso l’applicazione è doppia: un ottimo dono per i fan di vecchia data che non si imbattono in un’emanazione “nuova” dei Goonies da un bel pezzo, ma anche piccoli lettori da coinvolgere in un’avventura senza tempo. Ma com’è fatto? È presto detto: è la trasposizione a fumetti del film. A Cesare – anni 5 – lo stiamo leggendo noi senza riscontrare difficoltà di comprensione. Se avete bambini o bambine che leggono per conto loro è assolutamente proponibile in autonomia.
*

Beatrice Mautino
È naturale bellezza
(Mondadori)
Beatrice Mautino è una delle divulgatrici che seguo con più attenzione e gratitudine per l’opera meritoria di informazione e pacato ma inflessibile “debunking” che ogni giorno viene portata avanti sul suo account Instagram – là la trovate come @divagatrice. Tanto si parla di sostenibilità, greenwashing, plastica diabolica, creme miracolose, materie prime da ostracizzare e virtù non sindacabili del “bio”, ma quanto di quello che compriamo o che ci viene venduto come indiscutibilmente buono per la nostra faccia e per il pianeta fa davvero quel che dichiara di fare? Quanto di quello che a suon di slogan pubblicitari abbiamo imparato a considerare benefico e quasi in odore di santità produttiva può dirsi davvero tale? Anche in questo saggio e con la consueta chiarezza argomentativa, Mautino ci offre qualche strumento interpretativo in più – powered by SCIENZA, baby – per accrescere la nostra consapevolezza di consumatori/consumatrici e destreggiarci con un pizzico di razionalità in più anche nel comparto della cosmesi.
*

Angela Nicente
Atlante femminista – Alla scoperta del patriarcato
(Edizioni Clichy)
Grafica e illustratrice, Angela Nicente ha presentato una versione di questo atlante come progetto per la tesi di laurea. Ora è diventato un libro che, tappa dopo tappa – anzi, isola dopo isola – condensa i “temi caldi” del dibattito attuale su femminismo, patriarcato e questioni intersezionali limitrofe. Uno strumento sintetico e visivamente molto ben strutturato che può trasformarsi in un’efficace lettura introduttiva ai molti tasselli di tutto quello che ci fa quotidianamente arrabbiare e che varrebbe la pena demolire insieme. Per ogni isola troverete un riassunto di “cosa si dice”, chi la abita, una mappa territoriale – che in realtà è una mappa concettuale – e un testo con le doverose spiegazioni, fenomeno per fenomeno.
Intanto che siamo in quest’area tematica, vi rammento anche dell’esistenza dell’Atlante delle donne di Joni Seager, uscito per ADD Editore. Lavoro, salute, maternità, alfabetizzazione, contraccezione, diritti… una panoramica multidisciplinare che ambisce a fotografare la condizione femminile nel mondo, avvalendosi di dati assai aggiornati e di un assortimento di infografiche, cartine e grafici.
*

Vivienne Westwood. Sfilate
(L’ippocampo)
Qua scelgo Vivienne Westwood come portabandiera, perché quella delle sfilate è una collana ormai molto ricca di volumi monografici curatissimi e dedicati, di volta in volta, a una diversa casa di moda. Scelgo Vivienne Westwood anche perché mi è particolarmente cara e sono una cliente fedele – non assidua come vorrei o come mi potrebbe disegnare Ai Yazawa, ma non lamentiamoci. Il librone – rivestito di godurioso tartan – è frutto di un improbo lavoro d’archivio e recupero: contiene i look di tutte le sfilate del marchio, dal 1981 a oggi, insieme a un succulento backstage, sia “storico” che filosofico…. perché il Vivienne-pensiero è quasi più avvincente di quel che vediamo transitare in passerella.
*

Quaderno d’inverno. Giochi ed esercizi per adulti
(Blackie Edizioni)
Editori “giovani” con tradizioni ormai solide alle spalle? Eccoci! Blackie ha già sfornato con successo e spasso due eserciziari di compiti per le vacanze estive – sempre rivolti ai grandi – e questo Quaderno è il primo che promette di sostenerci anche nei mesi invernali. Lo spirito è sempre il medesimo: quiz, passatempi, rompicapi, cruciverba e zuzzurellonate varie che attingono alla cultura pop e puntano a intrattenerci con ironia.
Sempre di Blackie – visto che di zuzzurellonate stiamo parlando – segnalo volentieri anche L’arte di essere Bill Murray di Gavin Edwards. Trattasi tecnicamente di una biografia del pacioso attore ma, dato il personaggio, è più che altro un manifesto spirituale. Dagli esordi come spalla ben poco considerata del Saturday Night Live alle leggendarie incursioni alle feste di compleanno di privati cittadini ignari, Bill Murray proietta immancabilmente l’immagine di uno che si diverte moltissimo e che ha imparato a fregarsene al punto giusto. Come fa? Edwards cerca di spiegarcelo, catalogando le sue gesta e provando a restituirci un’immagine più “realistica”, ma non meno assurda e imprevedibile, del Murray che ci pare di conoscere.

*

Zerocalcare
Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia
(Bao Publishing)
Qua io la metterei giù così: c’è in libreria una cosa nuova di Zerocalcare? Perfetto, la si compra a scatola chiusa. Che altro vi serve sapere? Niente. Esatto.
Mi rendo però conto che molti “nuovi” fan, complice Strappare lungo i bordi, possano sentirsi un po’ persi nella produzione ormai molto consistente dell’ottimo Zerocalcare e che amerebbero ricevere qualche indicazione per cominciare a volergli bene non solo su Netflix ma anche leggendo. Ebbene, Bao ha già fatto i compiti per me: qua trovate una comoda guida che, tra cavalli di battaglia e lista ragionata delle gesta, mappa efficacemente il lavoro del trafelato Michele. Se volete sapere la mia, per chi parte da una base non ancora nutritissima voterei per un approccio cronologico, visto che tanto di quello che racconta Zerocalcare procede per accumulazioni autobiografiche.
*

Italia in 52 weekend. Itinerari inconsueti tra natura, arte e tradizioni
(Lonely Planet – EDT)
Ah, signora mia! Andiamo tanto lontano ma poi non apprezziamo le meraviglie della nostra splendida terra! Sembra una di quelle frasi da vecchi tromboni e trombone a cui reagire alzando con veemenza gli occhi al cielo, ma non posso negare che nasconda un fondo di verità – maledizione, quanto detesto dover dare ragione alla categoria dei tromboni. Comunque, regalare una guida di viaggio mi sembra sempre un gesto di sommo buon auspicio: vai, ti divertirai, scoprirai delle cose nuove, trascorrerai momenti spensierati. Di questi tempi – coi viaggi a lungo raggio tornati nemmeno troppo all’improvviso più impervi – una raccolta di itinerari “italiani” potrebbe rappresentare una validissima soluzione. Lonely Planet ne raccoglie qua 52 – uno a settimana per un anno intero, in pratica – occupandoci egregiamente i weekend ed esortandoci a vagare per borghi, città e luoghi relativamente vicini ma forse ancora poco battuti.
*

Leonardo Bianchi
Complotti! Da Qanon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto
(Minimum Fax)
Ho condiviso con Leonardo Bianchi un divano al Salone del Libro. Io ho espresso la mia simpatia per quell’innocuo complotto che teorizza l’immortalità di Keanu Reeves e lui, che ai complotti ha deciso di dedicare un saggio intero, mi ha raccontato come si “costruiscono” le fandonie di maggior successo e cosa può trasformarle in ostacoli veri per la convivenza civile, oltre a un potente veleno che deforma il dibattito pubblico. Dal Pizza-gate agli Illuminati, un testo per esplorare la faccia più irrazionale del nostro rapporto con la realtà, l’informazione e la scienza. Se li conosci li disinneschi, mi verrebbe da pensare… ma forse la faccenda è assai più complicata di così. Nel dubbio, vi auguro di non trovarvi a Natale seduti a tavola con una schiera di complottisti agguerriti. Voi, se potete, opponete una strenua resistenza.
*
Con la certezza di aver scordato circa l’86% dei libri che volevo segnalare, spero comunque di essere riuscita a fornire qualche spunto sfizioso per i vostri doni. Se ce la faccio, mi piacerebbe molto sfornare anche una lista focalizzata sulla narrativa. Vediamo come va. Nel caso servissero consigli miratissimi e personalizzati, mi trovate con indefessa costanza su Instagram o nel nostro bellissimo gruppo Telegram. Per frugare ulteriormente, vi indirizzerei senza indugio anche alla ricca categoria Libri qua sul blog.


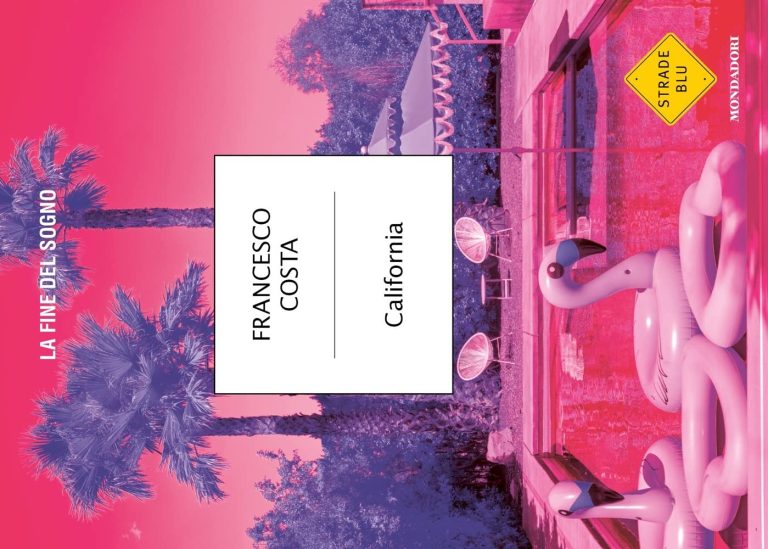

 Partirei con un piccolo cappello introduttivo da ascoltatrice dell’audiolibro – se vi interessa sentirlo,
Partirei con un piccolo cappello introduttivo da ascoltatrice dell’audiolibro – se vi interessa sentirlo, 




































 Dunque, di fronte all’enormità del reale e alla mole di stimoli che dobbiamo elaborare per orientarci e agire nel mondo, il nostro cervello tende a semplificare, raggruppare, generalizzare. In poche parole, punta a sintetizzare e ridurre al minimo gli sforzi per non dover ogni volta imparare l’universo da capo. Ridurre lo sforzo per massimizzare la resa, creando nessi e percorsi rodati. Gli stereotipi, i luoghi comuni e le credenze radicate (ma spesso infondate) sono figlie di questi meccanismi strutturali di elaborazione dati, che possono però talvolta generare inesattezze devastanti e pregiudizi distruttivi, per quanto “involontari”.
Dunque, di fronte all’enormità del reale e alla mole di stimoli che dobbiamo elaborare per orientarci e agire nel mondo, il nostro cervello tende a semplificare, raggruppare, generalizzare. In poche parole, punta a sintetizzare e ridurre al minimo gli sforzi per non dover ogni volta imparare l’universo da capo. Ridurre lo sforzo per massimizzare la resa, creando nessi e percorsi rodati. Gli stereotipi, i luoghi comuni e le credenze radicate (ma spesso infondate) sono figlie di questi meccanismi strutturali di elaborazione dati, che possono però talvolta generare inesattezze devastanti e pregiudizi distruttivi, per quanto “involontari”.
 Daniele è già stato in cura e ha sperimentato una nutrita sfilza di farmaci, ma continua a non digerire l’indifferenza con cui il mondo distribuisce sofferenza, assurdità arbitrarie, accidenti e disastri. È come se gli mancasse la pelle, quel minimo di scorza che rende sopportabile l’immagine del futuro. Vorrebbe proteggere chi ama, vorrebbe trovare un angolo di pace dove rifugiarsi quando riaffiora il pensiero che sforzarsi è inutile, perché tutto è destinato a sbriciolarsi e a svanire. Come si può gestire il presente se non vediamo altro che la polvere che resterà di noi?
Daniele è già stato in cura e ha sperimentato una nutrita sfilza di farmaci, ma continua a non digerire l’indifferenza con cui il mondo distribuisce sofferenza, assurdità arbitrarie, accidenti e disastri. È come se gli mancasse la pelle, quel minimo di scorza che rende sopportabile l’immagine del futuro. Vorrebbe proteggere chi ama, vorrebbe trovare un angolo di pace dove rifugiarsi quando riaffiora il pensiero che sforzarsi è inutile, perché tutto è destinato a sbriciolarsi e a svanire. Come si può gestire il presente se non vediamo altro che la polvere che resterà di noi?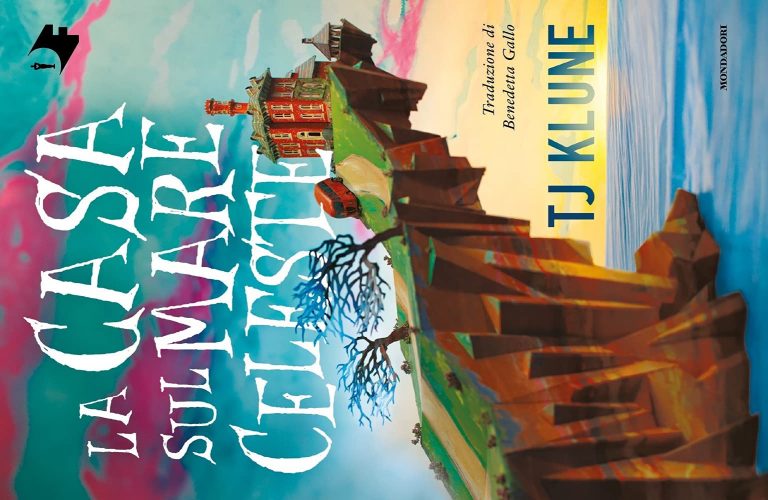
 Che accade? Un fantozziano assistente sociale stipendiato da un dipartimento statale ultra burocratizzato che ha lo scopo di monitorare l’attività della gioventù magica viene spedito su un’isola remota per un incarico segretissimo: ispezionare un orfanotrofio che ospita bambini ancora più inusuali (e potenzialmente pericolosi per la collettività) del “solito”.
Che accade? Un fantozziano assistente sociale stipendiato da un dipartimento statale ultra burocratizzato che ha lo scopo di monitorare l’attività della gioventù magica viene spedito su un’isola remota per un incarico segretissimo: ispezionare un orfanotrofio che ospita bambini ancora più inusuali (e potenzialmente pericolosi per la collettività) del “solito”.
 Benvenute e benvenuti nell’angolo della speculative fiction, un anfratto in cui la narrativa piglia una cosa del presente che fa già schifo (o comincia a puzzarci) e la sposta in una dimensione alternativa per farla degenerare fino in fondo.
Benvenute e benvenuti nell’angolo della speculative fiction, un anfratto in cui la narrativa piglia una cosa del presente che fa già schifo (o comincia a puzzarci) e la sposta in una dimensione alternativa per farla degenerare fino in fondo.