Una ragazza dagli occhi grandi abita con sua madre e un gatto in una casupola ai margini di un villaggio dell’Essex. Sono sole e non dispongono di un’indole molto malleabile. Vivono di ricami e rammendi e governano le quattro bestie in croce che possono mantenere sul loro fazzoletto di terra. La madre è altissima e irascibile, una virago che beve birra e non te la manda a dire. La figlia è innamorata dello scrivano che le sta insegnando a leggere le Scritture e ogni mattina porta una scodella di porridge a una vedova decrepita con una gamba di legno che nessuno vuole frequentare – ma che si interpella volentieri quando c’è bisogno di un prodigio.È il 1643, c’è miseria, gli uomini del re e i sostenitori del parlamento si ammazzano a vicenda, Dio latita ma il Demonio è ovunque e, aguzzando la vista, lo si può scovare anche a Manningtree. Basta interpretare i segni, dar seguito alle maldicenze, indagare i corpi con un pungolo rovente… mentre i poveri si contendono stracci e avanzi, un uomo pio arriva in città per diventare il Grande Inquisitore d’Inghilterra. Chi salverà l’anima di chi si preoccupa delle anime altrui?
 Le streghe di Manningtree di A. K. Blakemore – in libreria per Fazi – è la storia corale di un processo per stregoneria. La voce principale è quella di Rebecca West, figlia della più bellicosa tra le “donne” della contea e unica a mostrarci un punto di contatto con l’universo quasi ermetico – e di certo dotato di una maggiore autorità fattuale – degli uomini.
Le streghe di Manningtree di A. K. Blakemore – in libreria per Fazi – è la storia corale di un processo per stregoneria. La voce principale è quella di Rebecca West, figlia della più bellicosa tra le “donne” della contea e unica a mostrarci un punto di contatto con l’universo quasi ermetico – e di certo dotato di una maggiore autorità fattuale – degli uomini.
Il libro parte da una descrizione della quotidianità che precede l’arrivo di Hopkins – l’uomo timorato, il puritano che fa della caccia alle servitrici del Diavolo una missione e un vero e proprio lavoro – e ripercorre con raro dettaglio l’iter canonico di un’accusa di stregoneria. È una rielaborazione romanzesca che si basa però su fatti reali: Hopkins è esistito davvero e in un biennio d’attività fervente ha contribuito a far condannare a morte decine di donne (le stime documentate sono incerte, ci attestiamo tra le 100 e le 300). Al di là dei danni (pur notevoli) prodotti da un singolo invasato, però, l’esordio narrativo di Blakemore offre un vasto spaccato collettivo e indaga in filigrana le cause profonde dell’accanimento e del fanatismi.
Cosa occorre per trasformare una donna in una strega?
Qual è l’origine dei focolai di fervore accusatorio che culminano in torture, reclusioni disumane e disinvolte impiccagioni?
Arginare l’empietà per guadagnarsi il regno dei cieli è un “movente” sincero o è piuttosto un puro pretesto per levare di mezzo soggetti indesiderabili, scomodi, devianti?
Si parla di Dio o si parla di soldi?
A chi conviene ammazzare le streghe?
In quale vuoto di potere e in quale deserto identitario può attecchire il carisma sinistro di un inquisitore?
Blakemore individua in Manningtree il luogo adatto per rispondere narrativamente a questi interrogativi, riuscendo a buttare nel suo capiente e suggestivo calderone storia, finzione e sottotesti culturali.
La scrittura è splendida – e un applauso va a Velia Februari per la traduzione, dev’essere stato un lavoraccio infame – e conferma la mia teoria: Blakemore arriva dalla poesia e quando chi scrive poesie vira sulla narrazione il risultato è sorprendente. È un libro crudo e lirico, fatto di voci grezze e santissimi proclami. C’è una natura sapiente e ci sono i pidocchi, c’è il torbido in cui le anime nobili sguazzano con compiacimento e c’è la furbizia spiccia di chi non ha mai il coltello dalla parte del manico. Ci sono anatemi e confessioni estorte, verità di comodo e follie simulate. È una storia che fa male alle ossa, come quando cambia il tempo e tornano a galla le memorie di vecchi strappi, di fratture rimaste sghembe. Il tempo è passato e la ragione ha illuminato le tenebre della superstizione, ma sono dolori che avvertiamo comunque, perché le ossa delle streghe son state le nostre… e forse lo sono ancora.




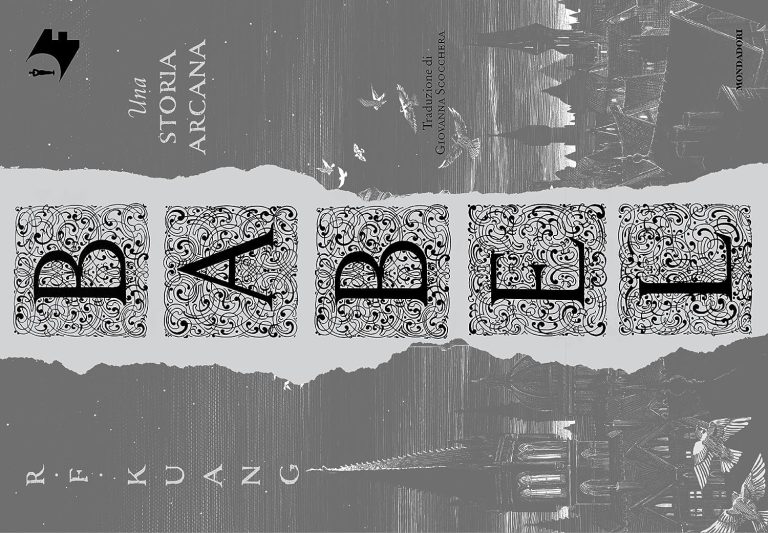
 Cosa succede?
Cosa succede?


 Gli studi che tentano di mappare il funzionamento
Gli studi che tentano di mappare il funzionamento
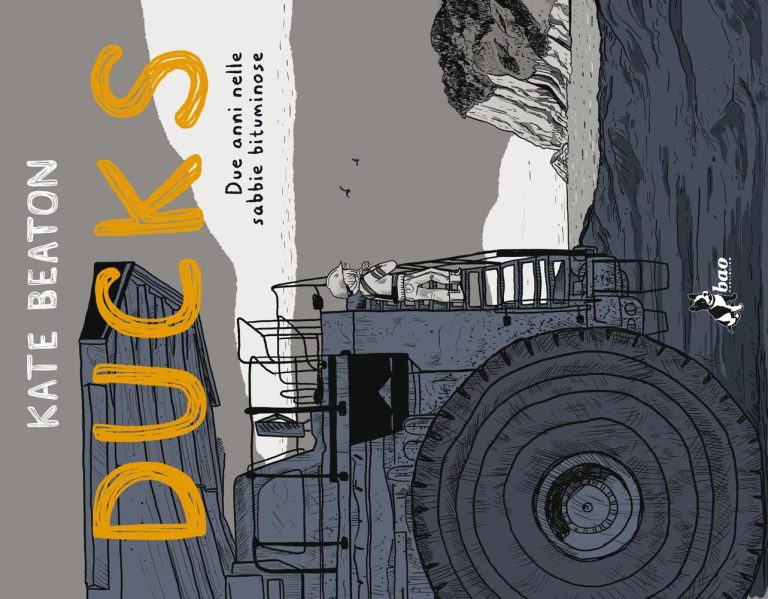
 Si sta discutendo spesso di autofiction, di preponderanza dell’autobiografia sulla narrativa d’invenzione, di presunzioni d’universalità anche quando si racconta delle proprie unghie incarnite, di che valore possano avere le minuzie individuali – vendute e ben confezionate come grandi rivelazioni – nel panorama del pensiero umano. Ecco,
Si sta discutendo spesso di autofiction, di preponderanza dell’autobiografia sulla narrativa d’invenzione, di presunzioni d’universalità anche quando si racconta delle proprie unghie incarnite, di che valore possano avere le minuzie individuali – vendute e ben confezionate come grandi rivelazioni – nel panorama del pensiero umano. Ecco, 
 La casa di campagna che fa da sfondo vivo e presentissimo a
La casa di campagna che fa da sfondo vivo e presentissimo a 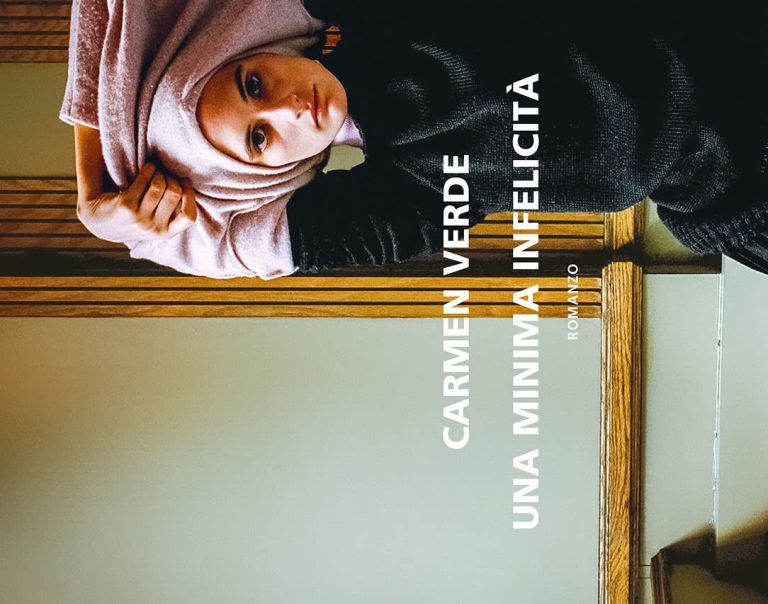
 Ogni famiglia è infelice a modo suo, abbiamo collettivamente metabolizzato.
Ogni famiglia è infelice a modo suo, abbiamo collettivamente metabolizzato. 
 I genitori le hanno fornito una rete di salvataggio – le pagano l’affitto e, da misura temporanea in vista di un lavoro che l’avrebbe aiutata a stare in piedi da sola, è diventata una scorciatoia strutturale. Millie un po’ se ne vergogna e un po’ si rifiuta di pensarci e ogni ufficio in cui ricomincia da capo è una nuova speranza, che si tira dietro una lunga lista di nobili aspirazioni. Mangiare meglio, lavarsi di più, tenere in ordine, arredare con gusto, fare sport, leggere, bere meno, volersi bene. Ma è dura costruire un castello splendente quando le fondamenta traballano di continuo e Millie tira avanti rabbiosa, sfidando il tedio in una polarizzazione di desideri: vorrebbe un contratto “vero”, ma chi è che vorrebbe fare per sempre un lavoro così mesto? E che senso ha tirare a lucido una casa piena di cianfrusaglie da quattro soldi?
I genitori le hanno fornito una rete di salvataggio – le pagano l’affitto e, da misura temporanea in vista di un lavoro che l’avrebbe aiutata a stare in piedi da sola, è diventata una scorciatoia strutturale. Millie un po’ se ne vergogna e un po’ si rifiuta di pensarci e ogni ufficio in cui ricomincia da capo è una nuova speranza, che si tira dietro una lunga lista di nobili aspirazioni. Mangiare meglio, lavarsi di più, tenere in ordine, arredare con gusto, fare sport, leggere, bere meno, volersi bene. Ma è dura costruire un castello splendente quando le fondamenta traballano di continuo e Millie tira avanti rabbiosa, sfidando il tedio in una polarizzazione di desideri: vorrebbe un contratto “vero”, ma chi è che vorrebbe fare per sempre un lavoro così mesto? E che senso ha tirare a lucido una casa piena di cianfrusaglie da quattro soldi?
