A cosa serve la storia? Dipende. Sapere da dove veniamo può indicarci con più chiarezza la strada verso il futuro, impartendoci sonore lezioni e fornendoci strumenti preziosi, nella speranza di non ripetere tragici errori. Approfondire le proprie radici collettive può rendere il presente più comprensibile, spingendoci ad affrontare il domani con solide consapevolezze e granitici punti di riferimento. Decifrare il passato per spiegare l’oggi, insomma, con l’auspicio che all’orizzonte esista un domani “migliorato”, più giusto e trasparente, più ricco e felice. Queste interpretazioni ottimistiche e speranzose non tengono però conto di molti chi. In Suoni ancestrali di Perrine Tripier – in libreria per E/O con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca – la “fonte” di un improvviso slancio collettivo verso l’approfondimento storico si rivelerà cruciale.
 Ci troviamo in un nebuloso regno marittimo governato da un imperatore teatralissimo e troppo fanciullesco per destare sospetti di particolare pericolosità. Il regno è dotato di una società ordinata, di università e di una popolazione poco incline ai colpi di testa. Non si capisce bene che cosa s’insegni a scuola, però, visto che il regno sembra non conoscere le proprie reali origini. Ci sono miti e filastrocche, ma i testi e i reperti consultabili coprono un arco temporale non troppo remoto e su cosa sia capitato prima c’è ancora del gran mistero. Il Dipartimento di Storia tormenta da anni la costa sabbiosa, cercando non si sa bene quale antenato. Un bel giorno, però, una duna ingiustamente snobbata restituisce una città… e dona un’occasione d’oro all’imperatore. Che si tratti della capitale perduta dei Morgondi, i leggendari avi del nostro popolo? I valorosi guerrieri delle fiabe sono tornati per indicarci la via!
Ci troviamo in un nebuloso regno marittimo governato da un imperatore teatralissimo e troppo fanciullesco per destare sospetti di particolare pericolosità. Il regno è dotato di una società ordinata, di università e di una popolazione poco incline ai colpi di testa. Non si capisce bene che cosa s’insegni a scuola, però, visto che il regno sembra non conoscere le proprie reali origini. Ci sono miti e filastrocche, ma i testi e i reperti consultabili coprono un arco temporale non troppo remoto e su cosa sia capitato prima c’è ancora del gran mistero. Il Dipartimento di Storia tormenta da anni la costa sabbiosa, cercando non si sa bene quale antenato. Un bel giorno, però, una duna ingiustamente snobbata restituisce una città… e dona un’occasione d’oro all’imperatore. Che si tratti della capitale perduta dei Morgondi, i leggendari avi del nostro popolo? I valorosi guerrieri delle fiabe sono tornati per indicarci la via!
L’imperatore alza le tasse, convoglia una barca di soldi agli scavi e pesca la più autorevole delle archeologhe/storiche del Dipartimento per documentare le operazioni e per riferire in regolari bollettini pubblici i progressi dello squadrone. L’imperatore desidera tantissimo che i guerrieri che hanno fin a quel momento riposato in mezzo a conchiglioni sonori, gabbie toraciche di balene immani, colonnati meravigliosi e spade cesellate siano proprio i Morgondi che intende lui – valorosi eroi, sapienti giustizieri di mostri, antichi parenti di cui andar fieri e che, col loro fulgido esempio, possano restituire ulteriore lustro al regno… e alla sua notevole persona.
Martabea, che di solito piglia seriamente il suo lavoro e che, al contrario dell’imperatore, viene dalla campagna e ha sempre sperato di potersi emancipare dal pantano delle sue origini, viene installata in un villone, spesata, servita e coccolata. Certo, ogni tanto le tocca infilare una frase goffa e pomposa dell’imperatore nelle sue cronache, ma le pare un prezzo relativamente piccolo da pagare per far parte di quell’impresa gloriosa, che tanto pare già giovare al regno e parecchio anche alla sua carriera. Il popolo gioisce di ogni scoperta, i Morgondi sono stupendi, lode all’imperatore!
C’è dell’altro, però? Purtroppo sì.
Tripier affida a Martabea un compito ingrato. La rende inevitabilmente sensibile alle lusinghe di un insperato privilegio e le sbatte poi in faccia una verità che polverizza ogni umana decenza. Non vi racconto cos’altro troveranno, nella città dei Morgondi, ma facciamoci bastare un’osservazione basilare: può capitare, nella peggiore delle ipotesi, che la storia sia di chi la scrive. In questo libro, così come spesso è capitato anche “fuori”, nel mondo che conosciamo noi, il materiale storico è interpretabile come leva di potere e di controllo. I miti sono formidabili e la nostra suggestionabilità, di fronte una “bella storia”, è una tentazione più che ghiotta e un terreno competitivo prezioso. Si sceglie cosa raccontare e a chi, si sceglie cosa omettere e cosa distorcere. Si sceglie per convenienza, compromesso, paternalismo – perché un buon imperatore sa sempre che cosa è meglio per il suo fiducioso popolo. Martabea si muove lungo il confine scivoloso che separa la verità dalla propaganda, i fatti dalle fandonie strumentali. Cosa sarà disposta a sacrificare?
Suoni ancestrali è un oggetto intrigante. Si legge alla svelta e non vi donerà particolari stupori a livello di scrittura o guizzi strutturali, ma funziona se ci si lascia interrogare. Martabea e la manciata di personaggi che la circondano sono piccoli segnaposto e “simboli”, più che esseri umani dotati di rotondità. Che siano così – e che anche il contesto sia sbozzato – può bastarci, perché il punto non è il “chi” e non è il “dove”, ma quel che conta è che la storia, morgonda o meno, possa diventare manipolabile. E che esista sempre, da qualche parte, qualcuno a cui conviene credere alla versione del più forte.









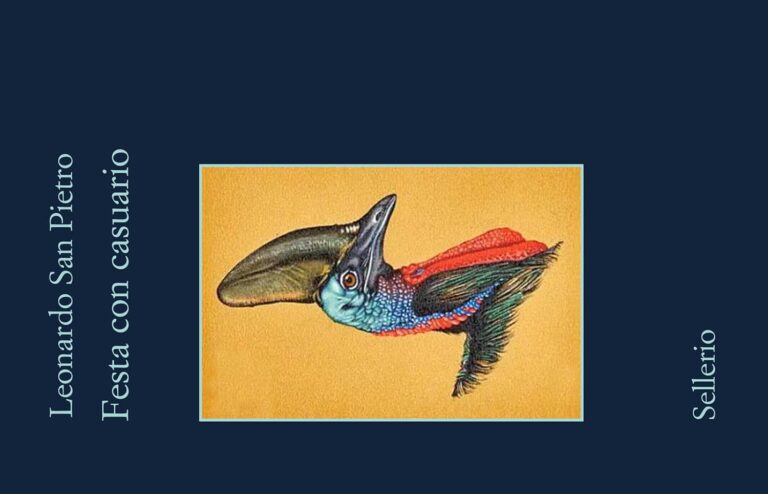
 Cosa ci fa un casuario nel
Cosa ci fa un casuario nel 




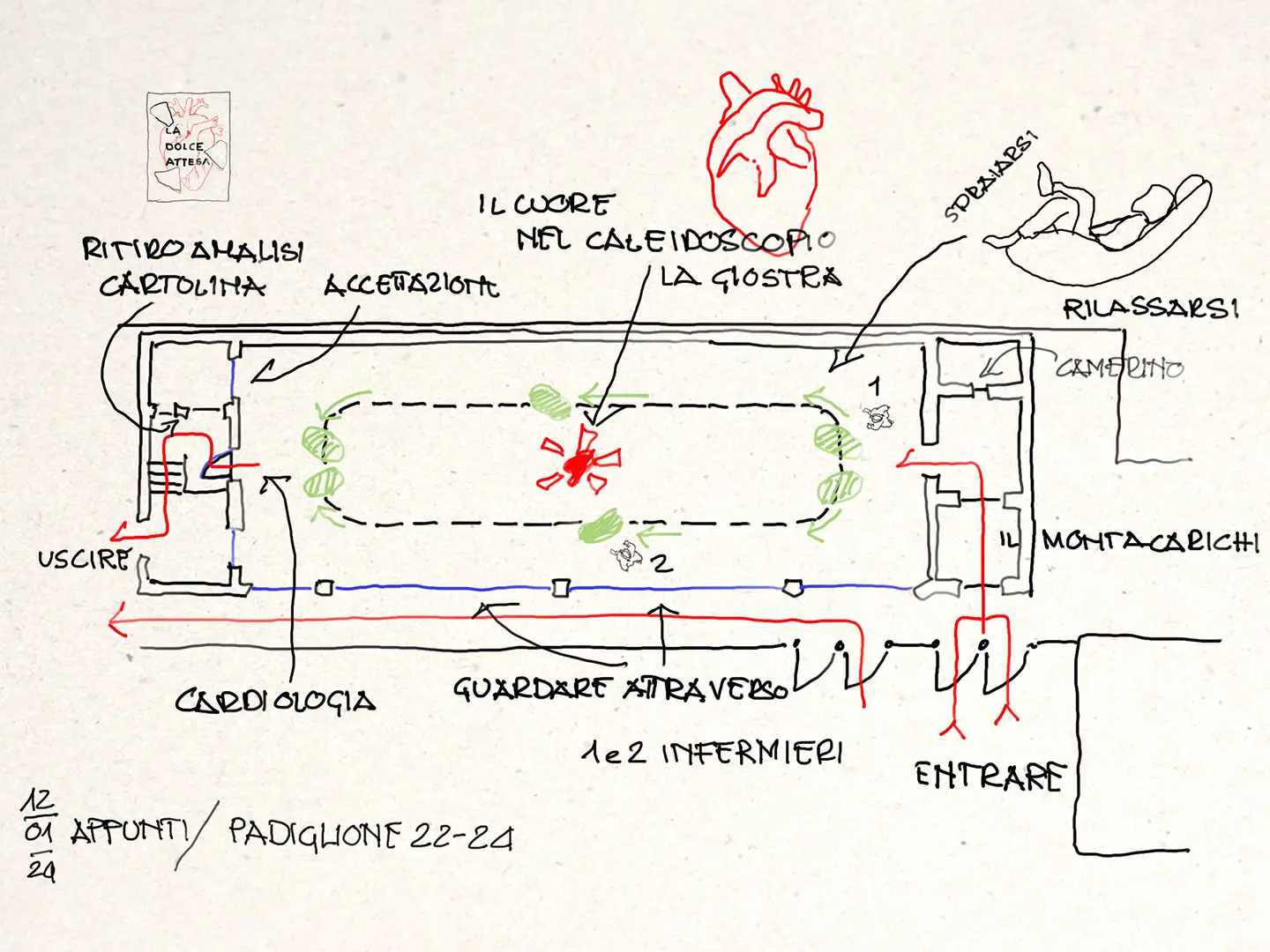





 A bordo della Drakkar c’è anche Mickey Barnes. Non è un pilota, non è un ingegnere, non è un agronomo o un militare e nemmeno un ricercatore medico. Si è offerto volontario per l’unico posto da Expendable – “Sacrificabile”, nella traduzione italiana – nella missione di colonizzazione di Niflheim, una palla di ghiaccio che non promette di lasciarsi domare agevolmente.
A bordo della Drakkar c’è anche Mickey Barnes. Non è un pilota, non è un ingegnere, non è un agronomo o un militare e nemmeno un ricercatore medico. Si è offerto volontario per l’unico posto da Expendable – “Sacrificabile”, nella traduzione italiana – nella missione di colonizzazione di Niflheim, una palla di ghiaccio che non promette di lasciarsi domare agevolmente.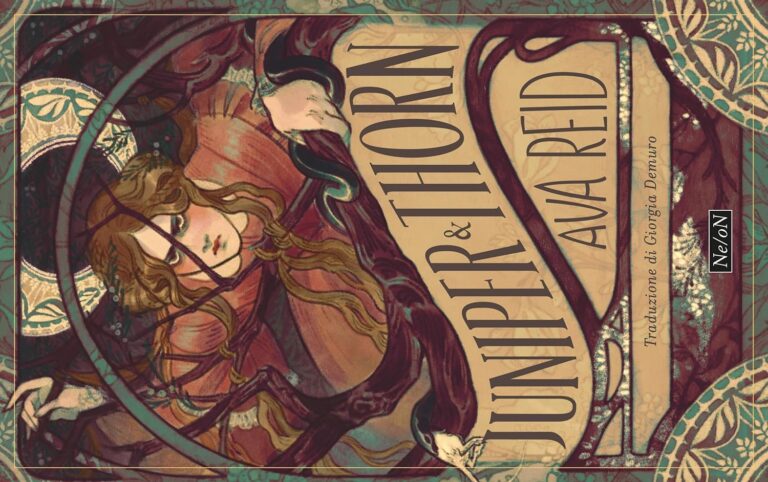
 La maledizione funziona a meraviglia e lo stregone perdurerà tra mille tormenti, asserragliato nella sua fortezza come il relitto di un universo destinato a scomparire e campando sostanzialmente alle spalle delle tre sorelle, streghe anche loro. Le maggiori sono bellissime – Undine prevede il futuro guardando in uno stagno che le restituisce il suo magnifico riflesso, mentre Rosenrot è un’erborista straordinaria – mentre l’ultima, Marlinchen, divinatrice della carne, non ha niente di speciale. Anzi, le viene continuamente ripetuto che è brutta, sgraziata, ordinaria e indegna d’amore.
La maledizione funziona a meraviglia e lo stregone perdurerà tra mille tormenti, asserragliato nella sua fortezza come il relitto di un universo destinato a scomparire e campando sostanzialmente alle spalle delle tre sorelle, streghe anche loro. Le maggiori sono bellissime – Undine prevede il futuro guardando in uno stagno che le restituisce il suo magnifico riflesso, mentre Rosenrot è un’erborista straordinaria – mentre l’ultima, Marlinchen, divinatrice della carne, non ha niente di speciale. Anzi, le viene continuamente ripetuto che è brutta, sgraziata, ordinaria e indegna d’amore.
 Ci troviamo in un nebuloso regno marittimo governato da un imperatore teatralissimo e troppo fanciullesco per destare sospetti di particolare pericolosità. Il regno è dotato di una società ordinata, di università e di una popolazione poco incline ai colpi di testa. Non si capisce bene che cosa s’insegni a scuola, però, visto che il regno sembra non conoscere le proprie reali origini. Ci sono miti e filastrocche, ma i testi e i reperti consultabili coprono un arco temporale non troppo remoto e su cosa sia capitato prima c’è ancora del gran mistero. Il Dipartimento di Storia tormenta da anni la costa sabbiosa, cercando non si sa bene quale antenato. Un bel giorno, però, una duna ingiustamente snobbata restituisce una città… e dona un’occasione d’oro all’imperatore. Che si tratti della capitale perduta dei Morgondi, i leggendari avi del nostro popolo? I valorosi guerrieri delle fiabe sono tornati per indicarci la via!
Ci troviamo in un nebuloso regno marittimo governato da un imperatore teatralissimo e troppo fanciullesco per destare sospetti di particolare pericolosità. Il regno è dotato di una società ordinata, di università e di una popolazione poco incline ai colpi di testa. Non si capisce bene che cosa s’insegni a scuola, però, visto che il regno sembra non conoscere le proprie reali origini. Ci sono miti e filastrocche, ma i testi e i reperti consultabili coprono un arco temporale non troppo remoto e su cosa sia capitato prima c’è ancora del gran mistero. Il Dipartimento di Storia tormenta da anni la costa sabbiosa, cercando non si sa bene quale antenato. Un bel giorno, però, una duna ingiustamente snobbata restituisce una città… e dona un’occasione d’oro all’imperatore. Che si tratti della capitale perduta dei Morgondi, i leggendari avi del nostro popolo? I valorosi guerrieri delle fiabe sono tornati per indicarci la via!