
Di Matrescenza di Lucy Jones abbiamo parlato, ma mi sembra più che opportuno segnalare anche il lavoro di Francesca Bubba, sia perché si concentra sul contesto della maternità in Italia e anche per come sceglie di farlo. I dati che riguardano il nostro paese diventano una chiave interpretativa per moltissimi dei crepacci in cui continuiamo a essere spinte – mentre ci dicono che è ora di spingere, signora – ma anche un punto di partenza per costruire uno scenario diverso. Se dati ed evidenze esistono – per fenomeni medici, socio-economici e lavorativi -, esistono anche per combinarci qualcosa e per aggiungere la maternità tra le molte “opzioni” a nostra disposizione, come soggetti indipendenti e realmente nelle condizioni di scegliere.
Preparati a spingere – in libreria per Rizzoli e anche ascoltabile su Storytel – è un saggio che usa il corpo (anche quello di chi scrive) per parlare del sistema in cui quei corpi sono inseriti, delle aspettative che deformano l’esperienza della maternità e la caricano opportunisticamente di nozioni produttive, d’efficienza e di nobili sacrifici che restringono il nostro orizzonte d’azione, invece di allargarlo. In questi orizzonti piccoli prosperano solitudini che diventano terreno fertile per reti di sostegno fittizie, predatorie e francamente spaventose – che Bubba indaga e mappa. Parecchie sono le pagine che vi faranno arrabbiare, ma vi ritroverete anche a maneggiare quella legittima reazione con un’accresciuta consapevolezza – e forse con un carico più leggero sulle spalle. Non perché le storture strutturali sono magicamente scomparse, ma perché chiamarle col loro nome – e trascinarle alla luce del sole perché le si possa vedere e riconoscere – è l’inizio di un sentiero che va percorso insieme.

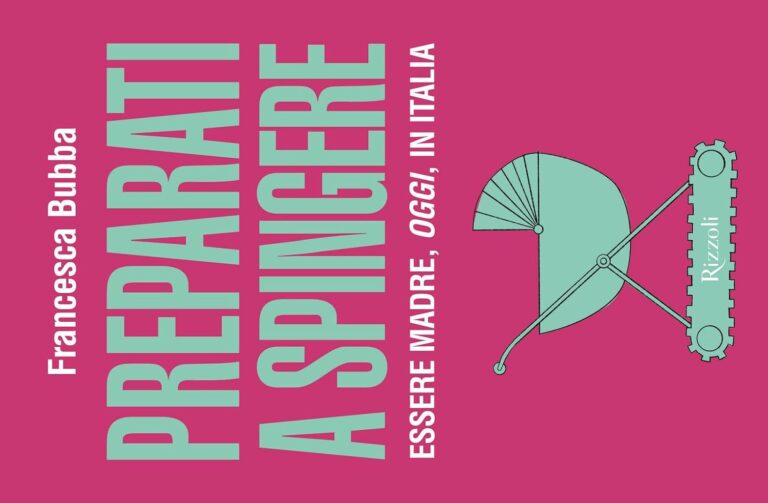
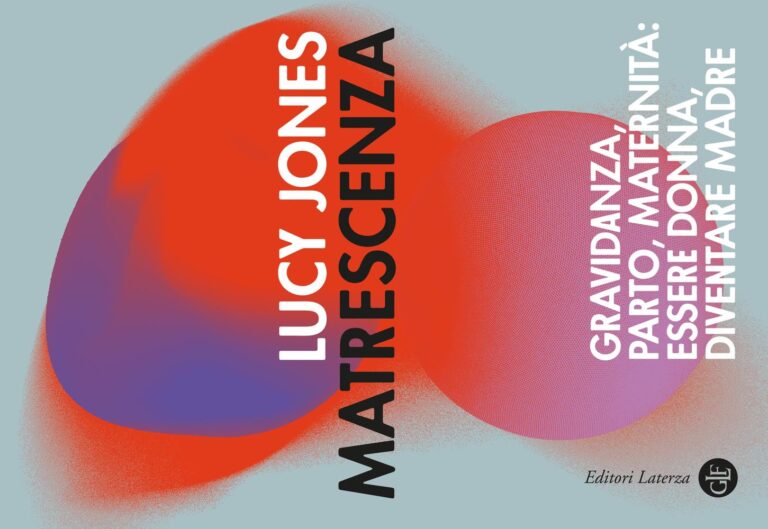




 Che l’unico vero strumento a nostra disposizione sia la predisposizione a dubitare delle circostanze che strutturano il nostro mondo? In
Che l’unico vero strumento a nostra disposizione sia la predisposizione a dubitare delle circostanze che strutturano il nostro mondo? In 
