Incredibile, si può tornare a parlare di viaggi. Non ci speravo più. Che lieta occasione, quante cose da raccontare! Partirei da una premessa pratica assai semplice per inquadrare l’avventura: noi a Ischia non ci eravamo mai stati. Per i conoscitori più scafati della ridentissima isola questo sarà sicuramente un diario di bordo che non riserverà sconvolgenti sorprese, ma come esordio direi che ce la siamo cavata benone – cullando nei nostri cuori anche la voglia di tornare. Insomma, troverete un po’ di spunti per giretti, cibarie, logistica e campo-base. Per concludere l’inquadramento, penso sia anche utile dichiarare che il nostro soggiornino è durato tre giorni pieni e che ci siamo stati a fine giugno, infante di quattro anni incluso.
Come ci si arriva, diamine?
Non volendo cimentarci in trasbordi eccessivamente macchinosi da e per gli aeroporti, siamo arrivati a Napoli Centrale in treno, siamo saltati su un taxi per arrivare al porto (c’è una tariffa fissa di 13€ e rotti che copre quella tratta, che vi porta via un quarto d’ora scarso) e abbiamo preso l’aliscafo. Potete prenotare il biglietto – cosa che tendo a consigliarvi in alta/altissima stagione – o farlo direttamente lì alla partenza. Si naviga per un’oretta e si approda a Ischia Porto. La frequenza delle partenze è piuttosto fitta, ma date sempre un occhio agli orari.
Volendo, si può fare porto-stazione e viceversa anche con la metropolitana. Sono due fermate. Al ritorno abbiamo optato per quell’opzione perché avevamo un po’ di margine, anche se con i bagagli non è agevolissimo.

Il campo-base
 Ischia è un’isolona e, data la conformazione vulcanico-impervio-montuosa, girovagare non è linearissimo. Diventa super agevole in motorino, credo, ma con un bambino al seguito la soluzione tende a dimostrarsi un po’ intricata. Eravamo assolutamente motivati a piantare le tende a Barano – costa meridionale – e a non schiodarci più dall’albergo, ma siamo stati così ben coccolati e istruiti sul da farsi che ci siamo dedicati anche a varie esplorazioni.
Ischia è un’isolona e, data la conformazione vulcanico-impervio-montuosa, girovagare non è linearissimo. Diventa super agevole in motorino, credo, ma con un bambino al seguito la soluzione tende a dimostrarsi un po’ intricata. Eravamo assolutamente motivati a piantare le tende a Barano – costa meridionale – e a non schiodarci più dall’albergo, ma siamo stati così ben coccolati e istruiti sul da farsi che ci siamo dedicati anche a varie esplorazioni.
Comunque, ad accoglierci con impareggiabile cuorosità è stato l’Hotel Parco Smeraldo Terme, che dati i lunghi trascorsi e la storia accumulata penso possa ormai essere considerato una sorta d’istituzione. A gestirlo, di generazione in generazione, è sempre la famiglia Iacono e ci tengo a ringraziare all’istante Leonilda che, fra le nuove leve, è quella che si occupa di social e comunicazione e che, per un purissimo e fortuito caso, ha visto nelle mie Instagram Stories un cartone della pizza che immortalava l’albergo e mi ha scritto per invitarmi. Giuro, è andata così. Dato lo straordinario antefatto, non potevo rifiutare e, appena è stato possibile spostarsi di nuovo con ragionevole agio, abbiamo fatto i bagagli. Leonilda, in pratica, ci ha anche fatto da mini tour-operator fornendoci tantissime indicazioni su luoghi meritevoli da visitare, ristoranti e bar, quindi praticamente tutto quello che troverete dopo ha ricevuto il bollino APPROVED DAI LOCAL. Diciamo pure che ogni volta che c’era da prenotare una cena lo staff si riuniva in sessione plenaria per ottimizzare il risultato.

Tornando a noi, l’albergo è – letteralmente – sulla spiagga dei Maronti. Tra i numerosi vantaggi riscontrati, c’è senza dubbio quello di poter scendere di sotto e andare al mare in due minuti, piazzando l’asciugamano su uno dei lettini della spiaggia privata dell’albergo. Restando in tema di abluzioni, però, le opzioni sono varie. L’hotel è anche un complesso termale e, tralasciando le piscine coperte della spa – e i vari percorsi caldo/freddo che si possono fare lì -, c’è pure la piscina esterna, altrettanto alimentata ad acqua termale piacevolmente caldina e costeggiata qua e là da una costellazione di lettini e ombrelloni. Il verde è curatissimo e molto avvincente: in pratica, vi aggirerete per un giardino subtropicale pieno di vegetali estrosissimi e rigogliosi.



Giornata-tipo? Giornata-tipo, che aiuta sempre a rendersi conto della gestione pratica del tempo. Abbiamo passato le mattine usufruendo allegramente di mare e piscina, ci siamo sempre fermati a pranzo in giardino – l’albergo ha un bistrot mediterraneo con servizio ai tavoli sotto le frasche – e, meraviglia delle meraviglie, dopo mangiato siamo tornati sempre in camera per il pisolino. Mio figlio non dorme più al pomeriggio da due anni ma a Ischia HA DORMITO. Grazie, acqua termale. Rinfrancati dal sonno, abbiamo poi dedicato la seconda parte delle nostre giornate per visite e giretti, mangiando poi qua e là. Si può cenare anche in albergo – come abbiamo fatto la sera dell’arrivo. C’è bontà e abbondanza. Mi ritenevo nutrita già al buffet degli antipasti, ma avevo sottovalutato l’esuberanza gastronomica campana.

A turno, la mattina, siamo anche andati a collaudare la spa. Il mio consorte, rengo come una seggiola, si è fatto fare un massaggio, mentre io mi sono cimentata con il trattamentone superfavola a base di fanghi. Il procedimento è avvincente. I fanghi vengono “estratti” direttamente dalle profondità del complesso e vengono anche preparati lì – prima che ve li applichino, in tutto il loro terapeutico tepore, passano otto mesi buoni. Prima dell’applicazione vi visita un medico che vi spedisce dalla vostra infangatrice di fiducia – Maria, ciao! Sei meravigliosa! – con un’indicazione di trattamento. Cioè, c’è proprio uno schemino d’applicazione, in base alle magagne che vi affliggono. Io son rigida di collo ma ho un sacco di capillari sulle gambe, quindi ho vinto un’applicazione benefica per le articolazioni evitando però cosce e polpacci, per dire. Dopo essere stata impacchettata in un bozzolo di fango – che detta così pare una roba orrenda ma in realtà è molto rilassante -, vi docciano come dei labrador e vi immergono per un altro quarto d’ora in una vasca che vi idromassaggia in vari e sofisticati modi (ozono, per me). Per non sfigurare di fronte a Cuorone, poi, anch’io ho vinto un massaggio drenante che mi ha ulteriormente rimessa al mondo. Due ore molto ben spese. CHE BENESSERE.

Avventure – vol. I | Sant’Angelo
L’orizzonte dell’albergo è scenograficamente occupato da una sorta di promontorio a forma di panettone. Ecco, quel panettone lì è Sant’Angelo, un piccolo borgo che sospetto sia stato edificato ad arte da un produttore di cartoline. Ci si può arrivare in macchina – prendendo una serpeggiante strada montana – o via mare. Peter Parker credo ci possa anche arrivare a piedi, ma lui se la cava bene con le pareti verticali e noi molto meno. Insomma, quel che vi suggerisco è di posizionarvi in riva al mare sulla spiaggia dei Maronti – la “fermata”, da quanto ho capito, si chiama DA MARIO – in corrispondenza di un eloquente cartello. Potete leggere il numero di telefono sul cartello e chiamare il vostro traghettatore o, per soluzioni più pittoresche, potete sbracciarvi e un barcaiolo arriverà e vi caricherà. Sì, vi bagnerete i piedi, quindi regolatevi con le scarpe. La “traversata” dura un quarto d’ora e costa 4€ a persona – il percorso inverso, in orario serale, costa il doppio e vi conviene portarvi un golfino. E un telescopio.



E Sant’Angelo? È un luogo incantevole. Arrampicatevi su per le stradine fino alla chiesa di San Michele, zampettate qua e là per vicoli e piccole botteghe e organizzate un campionato per eleggere il davanzale fiorito più avvenente. Mi fa strano parlare di cimiteri, ma pure il cimitero è un tripudio di colore e ceramiche smaltate.








Dove mangiare? Sul cocuzzolo del paese c’è un ristorante panoramico dall’aria epica – Villa Sirena, si chiama -, ma ci sembrava un po’ “pettinatino” per starci in tranquillità con un bambino. Siamo dunque tornati giù fino alla piazzetta centrale e ci siamo cimentati in un aperitivo al Pirata, cenando poi dal Pescatore. Sì, è uno di quei casi felici in cui non è necessario fare gli originali a tutti i costi e andarsi a cercare chissà quale chicca sperduta in mezzo a una foresta infestata dalle gorgoni. Potete mangiare in pace pure lì e godervi in serenità la piazza, il porticciolo, la spiaggina e il pontile-istmo che vi collega all’immenso panettone roccioso. Ci potete anche parzialmente salire, sullo scoglio, basta seguire la scaletta di legno.



Avventure – vol. 2 | Giardini La Mortella
Questi giardini dovrebbero essere rubricati tra le meraviglie del mondo? È possibile. Il complesso è frutto di lunghe e meticolose stratificazioni. Tutto comincia nel 1949, quando sir William Walton – compositore e musicista inglese tra i più blasonati del secolo scorso – si trasferisce a Ischia con la moglie Susana, wonderwoman di origini argentine che, a partire dal 1956, comincerà a “coltivare” i terreni vulcanici e i terrazzamenti circostanti alla casa, commissionando un ambizioso progetto strutturale all’architetto paesaggista Russell Page.



 Quello che possiamo ammirare oggi – sotto l’amministrazione della Fondazione Walton, che ha raccolto il lascito di lady Susana preservando la Mortella e trasformandola anche in un polo culturale per la musica – è una sorta di rigogliosa bolla verde che si arrampica sul fianco di una collina affacciata sulla baia di Forio e ospita un’infinità di specie vegetali dalle provenienze più disparate. Il giardino è diviso in due macro ambienti, il giardino di Valle – quello inferiore, di impronta subtropicale – e quello di Collina – un labirinto mediterraneo, assolato e arroccato sulla pendice dell’altura.
Quello che possiamo ammirare oggi – sotto l’amministrazione della Fondazione Walton, che ha raccolto il lascito di lady Susana preservando la Mortella e trasformandola anche in un polo culturale per la musica – è una sorta di rigogliosa bolla verde che si arrampica sul fianco di una collina affacciata sulla baia di Forio e ospita un’infinità di specie vegetali dalle provenienze più disparate. Il giardino è diviso in due macro ambienti, il giardino di Valle – quello inferiore, di impronta subtropicale – e quello di Collina – un labirinto mediterraneo, assolato e arroccato sulla pendice dell’altura.



 A parte l’oggettivo splendore dei vegetali che prosperano ovunque, passeggiare per la Mortella è un tributo al gusto per l’esplorazione. La sensazione è quella di trovarsi in un ambiente al contempo selvaggio e “vivo”, ma anche sapientemente orchestrato per stupirci a ogni radura. Non perdetevi il Ninfeo, il Tempio del Sole e la Cascata del Coccodrillo. Calzature comode, che un po’ c’è da scarpinare e per vedere dignitosamente tutto servono almeno un paio d’ore. Per riposini e rifocillamenti, a metà percorso c’è anche un bar provvisto di pittoreschi ombrelli con gli specchiettini.
A parte l’oggettivo splendore dei vegetali che prosperano ovunque, passeggiare per la Mortella è un tributo al gusto per l’esplorazione. La sensazione è quella di trovarsi in un ambiente al contempo selvaggio e “vivo”, ma anche sapientemente orchestrato per stupirci a ogni radura. Non perdetevi il Ninfeo, il Tempio del Sole e la Cascata del Coccodrillo. Calzature comode, che un po’ c’è da scarpinare e per vedere dignitosamente tutto servono almeno un paio d’ore. Per riposini e rifocillamenti, a metà percorso c’è anche un bar provvisto di pittoreschi ombrelli con gli specchiettini.





 Visto che i Maronti non sono vicinissimi a Forio – il centro più vicino ai Giardini, che sono un po’ fuori mano rispetto al paese-paese – e che dopo l’abbondante escursione non volevamo tornare in albergo a notte fonda, siamo rientrati al campo-base e abbiamo mangiato in uno dei numerosi locali affacciati sulla spiaggia. Dal Parco Smeraldo sono tutti raggiungibili a piedi in neanche dieci minuti e cenare sul mare è indiscutibilmente fascinoso. Noi siamo stati al Faro e Cuorone ha reso omaggio alle tradizioni ordinando il coniglio all’ischitana. Hardcore, il coniglio all’ischitana.
Visto che i Maronti non sono vicinissimi a Forio – il centro più vicino ai Giardini, che sono un po’ fuori mano rispetto al paese-paese – e che dopo l’abbondante escursione non volevamo tornare in albergo a notte fonda, siamo rientrati al campo-base e abbiamo mangiato in uno dei numerosi locali affacciati sulla spiaggia. Dal Parco Smeraldo sono tutti raggiungibili a piedi in neanche dieci minuti e cenare sul mare è indiscutibilmente fascinoso. Noi siamo stati al Faro e Cuorone ha reso omaggio alle tradizioni ordinando il coniglio all’ischitana. Hardcore, il coniglio all’ischitana.

Avventure – vol. 3 | Ischia Porto e il Castello Aragonese
Dunque, se volete dedicarvi allo shopping vi consiglio caldamente di fare la vostra comparsa a Ischia Porto nel pomeriggio inoltrato, perché non tutti i negozi aprono presto – controllate magari gli orari, che noi siamo andati di domenica e il giorno della settimana, alta o bassa stagione che sia, forse influisce.
Il nostro obiettivo era girellare e visitare il Castello Aragonese, che svetta in tutta la sua rocciosa arroganza su un altro voluminoso scoglio lavico collegato alla terraferma da un ponte artificiale – l’idea della pietra è venuta ad Alfonso V d’Aragona a metà del ‘400. I primi insediamenti risalgono al 474 a.C. e, a partire da Gerone il Siracusano, tante furono le dominazioni che modificarono la fortezza, stratificandone l’architettura e ampliando gli insediamenti.





 Sempre nel 1400, tutta la popolazione ischitana abitava là sopra, per difendersi dai pirati: c’erano ben sette parrocchie, un paio di conventi, la guarnigione principesca e quasi 2000 famiglie, che verso la metà del ‘700 – debellati i pirati – cominciarono a trasferirsi nel resto dell’isola, per badare alle colture e dedicarsi alla pesca. Gli inglesi assediarono la rocca nel 1809 per strapparla ai francesi, demolendo pure la cattedrale – i cui magnifici resti si possono ancora esplorare. Nel 1800, Ferdinando I – re di Napoli – adibì il Castello a carcere “duro”, destinazione d’uso che è sopravvissuta fino al Regno d’Italia.
Sempre nel 1400, tutta la popolazione ischitana abitava là sopra, per difendersi dai pirati: c’erano ben sette parrocchie, un paio di conventi, la guarnigione principesca e quasi 2000 famiglie, che verso la metà del ‘700 – debellati i pirati – cominciarono a trasferirsi nel resto dell’isola, per badare alle colture e dedicarsi alla pesca. Gli inglesi assediarono la rocca nel 1809 per strapparla ai francesi, demolendo pure la cattedrale – i cui magnifici resti si possono ancora esplorare. Nel 1800, Ferdinando I – re di Napoli – adibì il Castello a carcere “duro”, destinazione d’uso che è sopravvissuta fino al Regno d’Italia.


 Cenni storici a parte, la visita non è riposantissima ma sorprendente. Il panorama dai terrazzi abbraccia il golfo di Napoli e Capri, ci sono chiese e cappelle piene di gatti sonnacchiosi, uliveti, sentieri e scale che si diramano dal corpo principale della fortezza per condurvi ai quattro angoli dell’isola… sempre che un’isolotto tondo possa avere degli angoli. Il percorso è ben indicato e numerato, ma anche in questo caso preparatevi a infrangere il record giornaliero del vostro FitBit. Teoricamente c’è anche un ascensore che dovrebbe portarvi in cima in maniera più rapida, ma quando siamo andati noi non era in funzione.
Cenni storici a parte, la visita non è riposantissima ma sorprendente. Il panorama dai terrazzi abbraccia il golfo di Napoli e Capri, ci sono chiese e cappelle piene di gatti sonnacchiosi, uliveti, sentieri e scale che si diramano dal corpo principale della fortezza per condurvi ai quattro angoli dell’isola… sempre che un’isolotto tondo possa avere degli angoli. Il percorso è ben indicato e numerato, ma anche in questo caso preparatevi a infrangere il record giornaliero del vostro FitBit. Teoricamente c’è anche un ascensore che dovrebbe portarvi in cima in maniera più rapida, ma quando siamo andati noi non era in funzione.
Altre tappe del giro a Ischia Ponte?
Gelato? Ice da Luciano.


Libri? La libreria Imagaenaria è l’unica dell’isola ed è anche ben fornita. In aggiunta, funziona da editore “locale”, con diversi volumi dedicati alla storia dell’isola, narrativa assai estrosa e saggi sui personaggi illustri che in qualche modo hanno lasciato un’impronta a Ischia. No, la gatta Cenerella non l’ho incontrata. Se la vedete, salutatemela.


Caffé? Il bar Cocò occupa strategicamente il fronte sul mare all’imboccatura del ponte del Castello. Ci siamo piazzati lì a fare merenda, in primissima fila.

Ceramiche? Leonilda mi aveva consigliato di fare un salto da Cianciarelli, ma era chiuso. Visto che sono fissata con le ceramiche e non c’è viaggio che termini senza che io mi porti a casa almeno una piastrella, ho perlustrato via Mazzella e ho scatenato un discreto scompiglio da Sole d’Ischia – sì, ha in vetrina il limoncello, i Pulcinella e tanti souvenir non proprio favolosi, ma se ci si addentra c’è parecchio da scoprire. Alla fine ho comprato sei piatti fondi, sei piatti piani, quattro tazzine e una rana. Tutto ha tollerato alla perfezione la lavastoviglie, come mi era stato promesso, e sono soddisfattissima. Il proprietario mi ha imballato e spedito tutto a Milano in un paio di giorni. Se volete fare ricerche e approvvigionarvi in altri lidi, è tutta ceramica vietrese.
Angoli Pittoreschi? Palazzo Malcovati, col suo portone affacciato sul mare e il cortiletto verdissimo e fascinosamente disordinato. Se vi stuzzica qualche remoto ricordo è perché è stato spesso una location cinematografica.


E a cena?
Abbiamo approfittato di un ottimo consiglio dello staff del Parco Smeraldo riunito in seduta plenaria e ci siamo fatti prenotare un tavolo al Giardino Eden. Si prende una barchetta-taxi dal pontile della Curteglia e si naviga tra la costa e il castello per una manciata di minuti. Il locale è in una baietta riparata da un mini-arcipelago di scogli e poche altre volte in vita mia credo di aver mangiato in un posto così bello. C’è un’area bar dove abbiamo fatto l’aperitivo con ottimi cocktail. Temendo per la resistenza di Cesare – che ha scalato un castello e un po’ di sonno poteva legittimamente averlo – non ci siamo cimentati con i diversi percorsi dei menu degustazione, ma mi sento di consigliarvi quell’approccio lì. Non ci siamo fermati al panificio Boccia, ma ci siamo ritrovati a tavola il loro pane, quindi evviva. Cesare, comunque, quando ha visto l’acquario dei frutti di mare e dei conchigliami assortiti ha dimostrato di essere molto più arzillo di me.






Spostamenti
Visto che non volevamo sbatterci – un po’ perché c’era Cesare e un po’ perché non andavo in vacanza da un secolo e ho ritenuto legittimo investire in comodità -, non ho indicazioni particolarmente utili da darvi sui mezzi pubblici. Esistono e circolano copiosamente, comunque. Noi siamo andati in giro in taxi e abbiamo sempre richiamato lo stesso autista – che è diventato il nostro scarrozzatore ufficiale, a un certo punto. Vi fate lasciare il numero e vi organizzate tra esseri umani su orari e punti d’incontro. Per darvi un’idea delle tariffe, dai Maronti a Ischia Ponte/Forio si paga una media di 30 euro a tratta, idem per raggiungere l’imbarco dell’aliscafo a Ischia Porto.


 Spero che questa piccola guida – per esploratori ischitani alle prime armi – possa tornarvi utile. E spero anche di poterla prima o poi arricchire con ulteriori avventure. Per il momento non sono in grado di insediarmi sull’isola come una vera lady Susana, ma ho applaudito la sua decisione a ogni passo. Voglio ringraziare ancora Leonilda e l’Hotel Parco Smeraldo Terme per l’impareggiabile accoglienza e per l’affetto che ci hanno riservato. Ci siamo rimessi sulla via di casa con quel mezzo magone che si manifesta quando si saluta un posto dove sono stati fabbricati ricordi felici. Cesare vi raccomanda di salutargli la tartaruga Giovanni e tutte le sue compagne di stagno. Se andrete da Leonilda e famiglia, non scordate di dichiarare la vostra Tegamini-provenienza, che ci sarà una sorpresina. 😉
Spero che questa piccola guida – per esploratori ischitani alle prime armi – possa tornarvi utile. E spero anche di poterla prima o poi arricchire con ulteriori avventure. Per il momento non sono in grado di insediarmi sull’isola come una vera lady Susana, ma ho applaudito la sua decisione a ogni passo. Voglio ringraziare ancora Leonilda e l’Hotel Parco Smeraldo Terme per l’impareggiabile accoglienza e per l’affetto che ci hanno riservato. Ci siamo rimessi sulla via di casa con quel mezzo magone che si manifesta quando si saluta un posto dove sono stati fabbricati ricordi felici. Cesare vi raccomanda di salutargli la tartaruga Giovanni e tutte le sue compagne di stagno. Se andrete da Leonilda e famiglia, non scordate di dichiarare la vostra Tegamini-provenienza, che ci sarà una sorpresina. 😉
[Per approfondimenti ulteriori, nel circoletto ISCHIA su Instagram troverete una copiosa cronaca video delle nostre imprese. Ma anche qui, qui e qui].


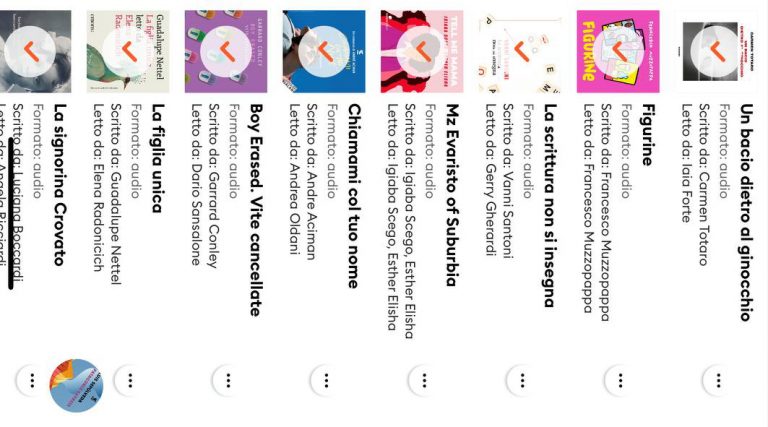

 Che accade in questo libro? Dipende dall’occhio.
Che accade in questo libro? Dipende dall’occhio.

 Dunque, Pietro Minto assembla già da un pezzo una delle mie newsletter preferite –
Dunque, Pietro Minto assembla già da un pezzo una delle mie newsletter preferite – 
 In
In 
 Benvenute e benvenuti nell’angolo della speculative fiction, un anfratto in cui la narrativa piglia una cosa del presente che fa già schifo (o comincia a puzzarci) e la sposta in una dimensione alternativa per farla degenerare fino in fondo.
Benvenute e benvenuti nell’angolo della speculative fiction, un anfratto in cui la narrativa piglia una cosa del presente che fa già schifo (o comincia a puzzarci) e la sposta in una dimensione alternativa per farla degenerare fino in fondo.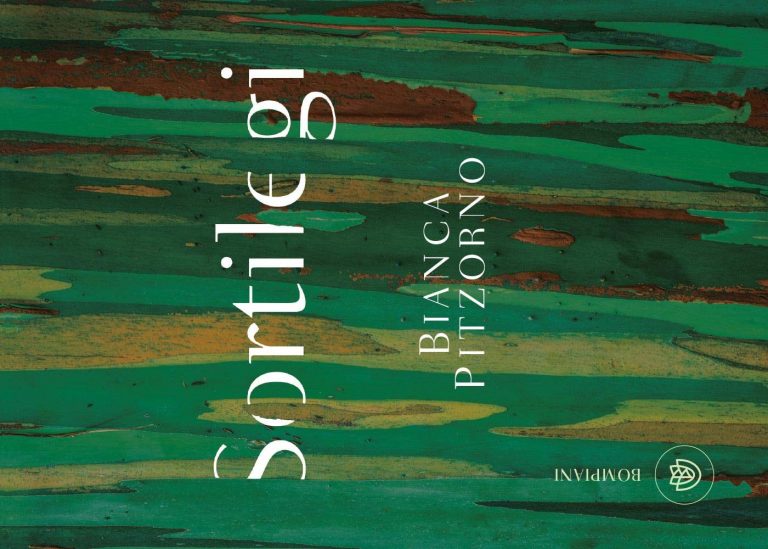
 Bianca Pitzorno patrimonio dell’umanità. Esordirei così.
Bianca Pitzorno patrimonio dell’umanità. Esordirei così.
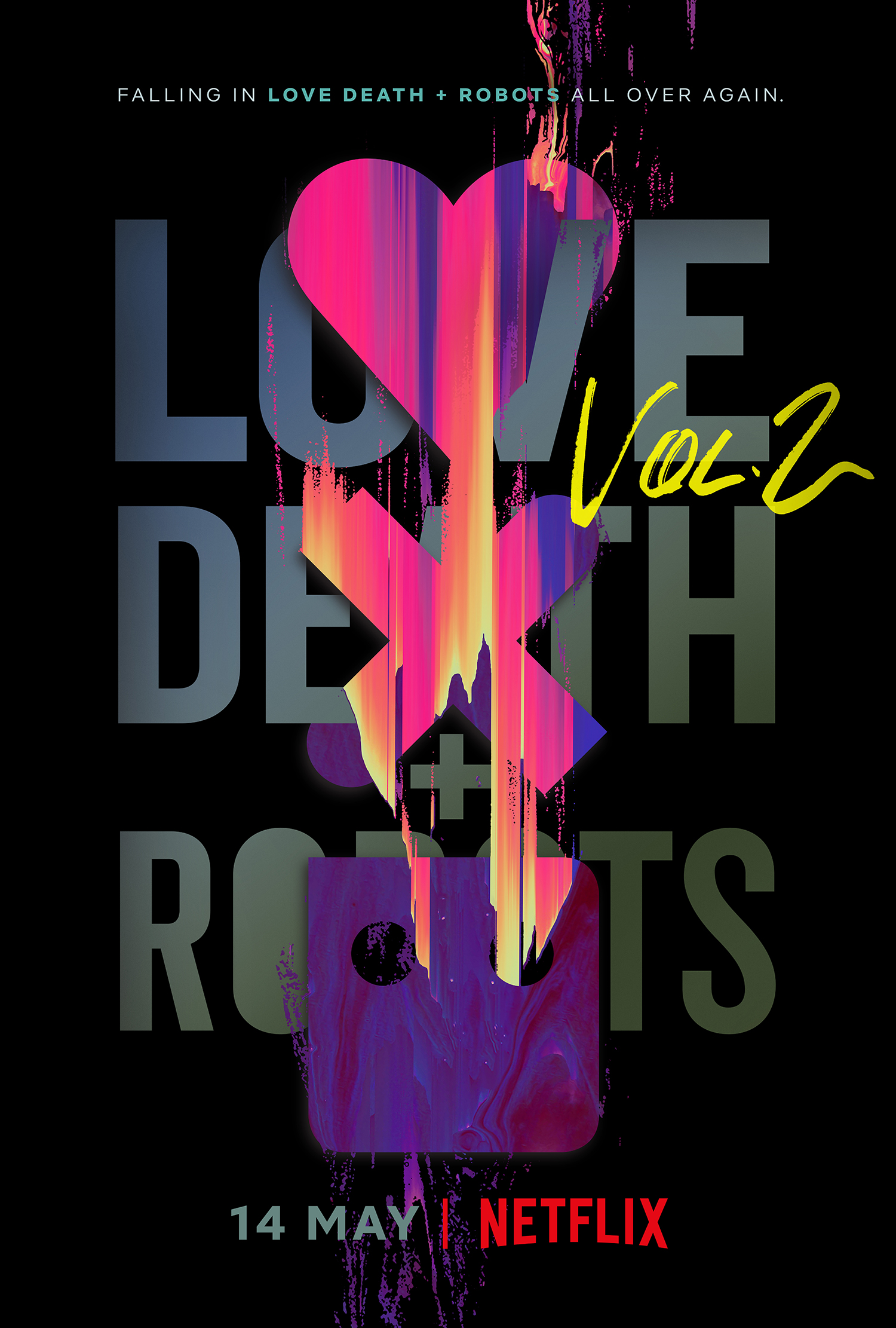 Lo dichiaro all’istante: Love, Death + Robots è una delle mie cose preferite al mondo. La prima stagione ci era piombata addosso senza particolari fanfare, generando un entusiastico effettone-sorpresa dato dalla struttura e dal trattamento visivo estremamente eclettico delle storie. E anche la seconda – uscita il 14 maggio su Netflix – non smentisce il folle spirito delle operazioni. Al comando della ciurma ci sono David Fincher e Tim Miller (qui showrunner/ideatore e già regista direi assai applaudito dalla popolazione del globo per Deadpool), con Jennifer Yuh Nelson a fare da coordinamento registico e da collante creativo.
Lo dichiaro all’istante: Love, Death + Robots è una delle mie cose preferite al mondo. La prima stagione ci era piombata addosso senza particolari fanfare, generando un entusiastico effettone-sorpresa dato dalla struttura e dal trattamento visivo estremamente eclettico delle storie. E anche la seconda – uscita il 14 maggio su Netflix – non smentisce il folle spirito delle operazioni. Al comando della ciurma ci sono David Fincher e Tim Miller (qui showrunner/ideatore e già regista direi assai applaudito dalla popolazione del globo per Deadpool), con Jennifer Yuh Nelson a fare da coordinamento registico e da collante creativo.



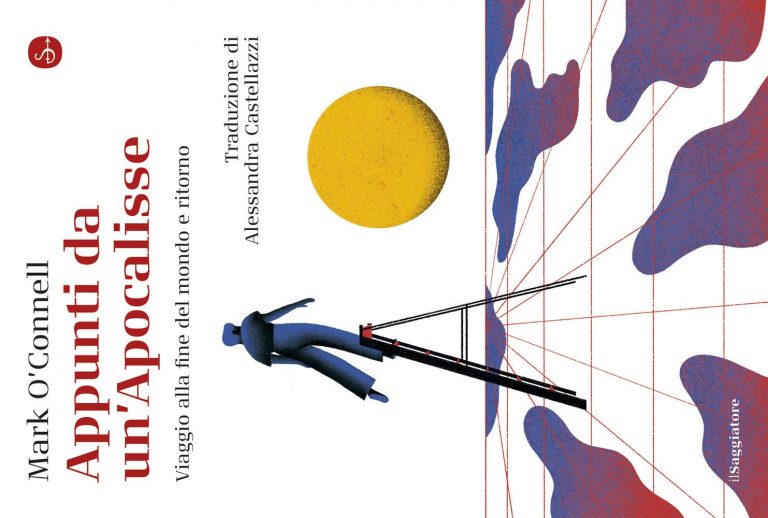
 Dev’essere confortante avere la capacità di analizzare in un libro – e di razionalizzare, in un certo senso – un terrore personale reso onnipresente dal contesto informativo in cui siamo inseriti. Ecco, Mark O’Connell – già transitato per questi lidi con
Dev’essere confortante avere la capacità di analizzare in un libro – e di razionalizzare, in un certo senso – un terrore personale reso onnipresente dal contesto informativo in cui siamo inseriti. Ecco, Mark O’Connell – già transitato per questi lidi con 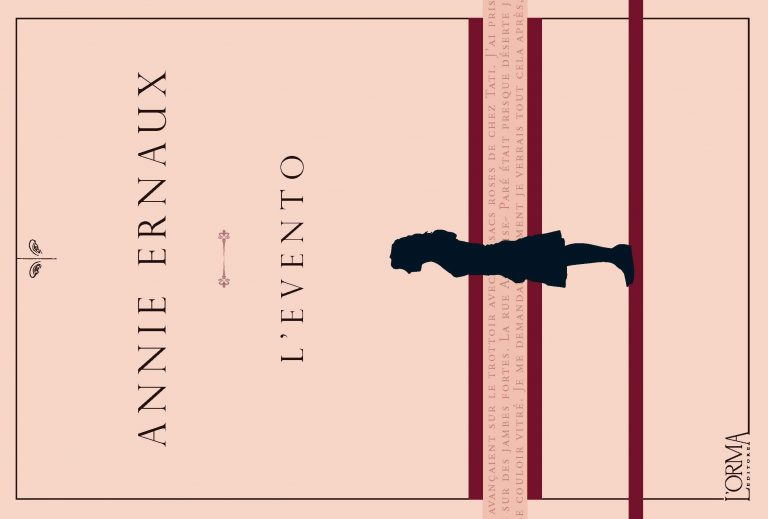
 Orbene, Annie Ernaux è un’autrice che sto pian piano affrontando e che fa della rielaborazione autobiografica – nella speranza di toccare corde universali – la sua cifra narrativa. È asciutta, precisa, inflessibile e acutissima, soprattutto nello sviscerare il sommerso. Ognuno ha il suo, di sommerso, ma lei sommerge anche per gli altri.
Orbene, Annie Ernaux è un’autrice che sto pian piano affrontando e che fa della rielaborazione autobiografica – nella speranza di toccare corde universali – la sua cifra narrativa. È asciutta, precisa, inflessibile e acutissima, soprattutto nello sviscerare il sommerso. Ognuno ha il suo, di sommerso, ma lei sommerge anche per gli altri.