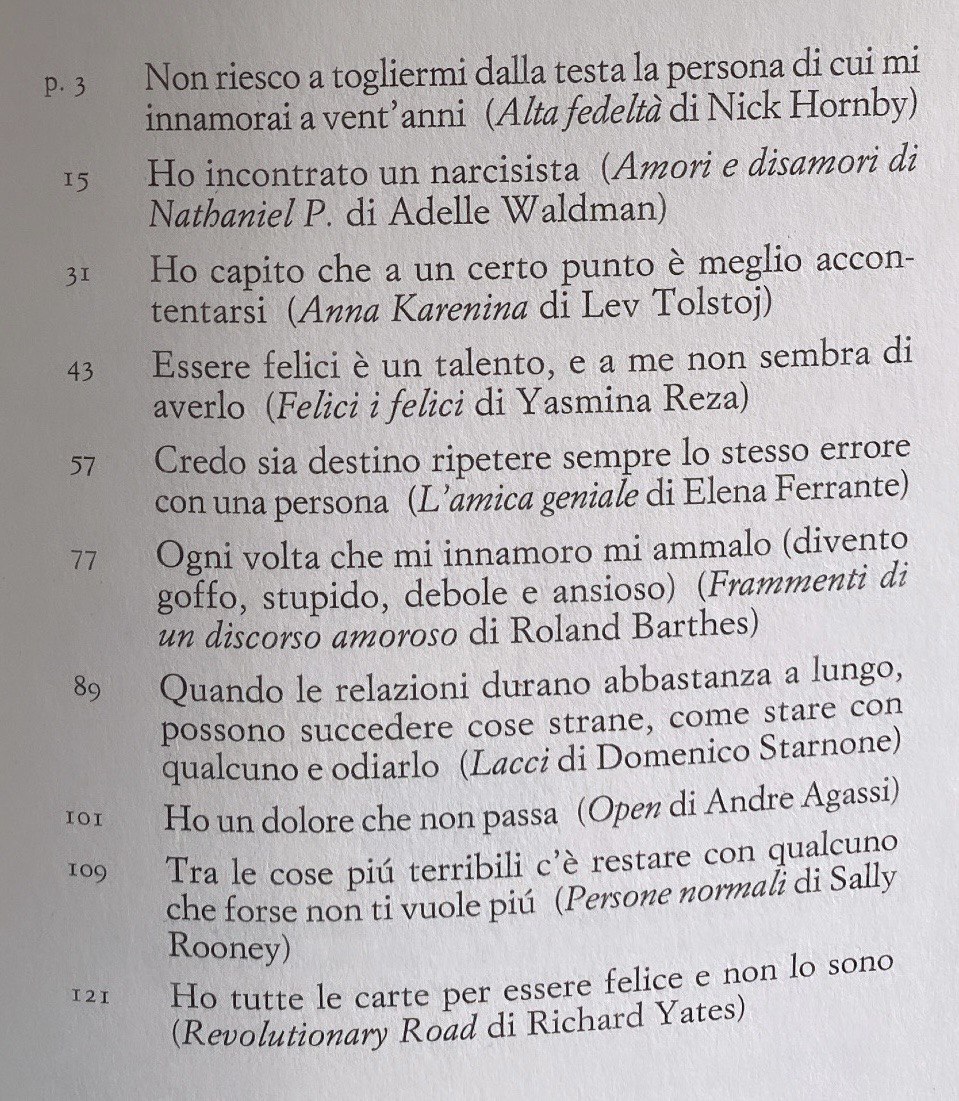Dunque, fughiamo subito un dubbio: se volete leggerlo perché amate Roger Federer (o il tennis) in maniera viscerale non credo vi convenga. Qui il tennis e il blasonato torneo di Wimbledon sono elementi utili a produrre un effettone di romantica abnegazione, ma non è un romanzo SUL tennis.
Henry Evans, il giardiniere del titolo, ha effettivamente curato per mezzo secolo i prati di Wimbledon, ma manco a lui frega niente del tennis – o del verde, direi. La ragazza che amava era una giocatrice accanita e, nella speranza di ritrovarla, Henry ha accettato un posto di giardiniere al circolo perché giocare a Wimbledon da professionista era il grande sogno della sua Rose. Com’è andata? Non benissimo.
 Il padre di Henry, rimasto vedovo, si trasferisce col figlio a Blake Hall per prendere servizio come giardiniere. Blake Hall è Downton Abbey, tanto per produrre un’immagine immediatamente comprensibile. Henry conosce Rose – terzogenita dell’altolocata famiglia – mentre gironzola in bici per la tenuta. Sono coetanei e l’indole dimessa e arrendevole di Henry pare garbare alla determinatissima Rose. Dato che sono poco più che bambini, il loro legame non desta scandali o tragiche preoccupazioni, ma l’amicizia è destinata a crescere e il tempo a passare. Sullo sfondo – ma mica poi tanto – i prodromi della Seconda Guerra Mondiale sono in pieno svolgimento. Che ne sarà di Blake Hall e dei suoi occupanti?
Il padre di Henry, rimasto vedovo, si trasferisce col figlio a Blake Hall per prendere servizio come giardiniere. Blake Hall è Downton Abbey, tanto per produrre un’immagine immediatamente comprensibile. Henry conosce Rose – terzogenita dell’altolocata famiglia – mentre gironzola in bici per la tenuta. Sono coetanei e l’indole dimessa e arrendevole di Henry pare garbare alla determinatissima Rose. Dato che sono poco più che bambini, il loro legame non desta scandali o tragiche preoccupazioni, ma l’amicizia è destinata a crescere e il tempo a passare. Sullo sfondo – ma mica poi tanto – i prodromi della Seconda Guerra Mondiale sono in pieno svolgimento. Che ne sarà di Blake Hall e dei suoi occupanti?
Il giardiniere di Wimbledon – in libreria per Feltrinelli con la traduzione di Chiara Mancini – è costruito a partire da una testimonianza diretta di Henry, resa a una giornalista specializzata in questioni di cuore un po’ smancerose. Quest’intervista fittizia a Harry “anziano” diventa un grande flashback che ci presenta la sua versione della storia – con la “s” piccola e con quella grande – e della relazione con Rose. Ora, io ho faticato enormemente a trovare verosimile i cinquant’anni passati ad aspettare a Wimbledon la fidanzatina di gioventù e credo dipenda anche un po’ dall’esecuzione. L’idea è struggentissima, ma per reggere uno struggimento simile credo serva un peso specifico diverso… e Crilly m’è parsa poco sostanziosa. È un amore raccontato per schemi ricorrenti – resi necessari dalle circostanze di clandestinità della relazione, certo, ma anche molto poco avvincenti da seguire – e azioni “pure”, senza chissà quali indagini interiori.
Quello che spicca e che ho trovato molto più “forte” è l’abbozzo di indagine sociale. Henry e Rose sono condannati dalle diverse posizioni che ricoprono nella catena alimentare e quello è l’unico conflitto davvero rilevante del romanzo.
Henry sa che i figli dei giardinieri non sposano le figlie del proprietario della tenuta e Crilly è brava a creare un’atmosfera corale che accentua la dicotomia tra i piani alti della casa e quelli bassi del personale. La condiscendenza dei “ricchi” verso i loro dipendenti – che regge solo se tutti restano al loro posto -, l’incapacità di percepirsi in una posizione di privilegio, la deferenza obbligata – che tramuta un lavoro onesto e dignitoso in servitù “vera” – e un intero sistema sociale che vuol farti credere che svuotare il pitale del signor Blake sia un grandissimo onore si può riassumere un po’ così: vi concederò la possibilità di lustrarmi le scarpe se mi dimostrerete gratitudine eterna e se potrò rammentarvi di continuo che pure voi mi appartenete. Ecco, l’andazzo è quello… e Rose è figlia di quel mondo, oltre che del suo tempo. Dopo aver visto in azione Lady Sybil, qua ti piglia lo scoramento.
E il tennis? Rose usa Henry come sparring partner, punto. Il tennis è il suo unico afflato di sincera rottura con un contesto di partenza che dice di schifare ma che in realtà le fa comodo – perché non ha idea di cosa ci sia davvero oltre i cancelli della sua splendida dimora.
Insomma, per me è stata una lettura tiepidina “da viaggio”. O forse ho un cuore di pietra e rosico ancora per Sinner-Berrettini al secondo turno di Wimbledon.

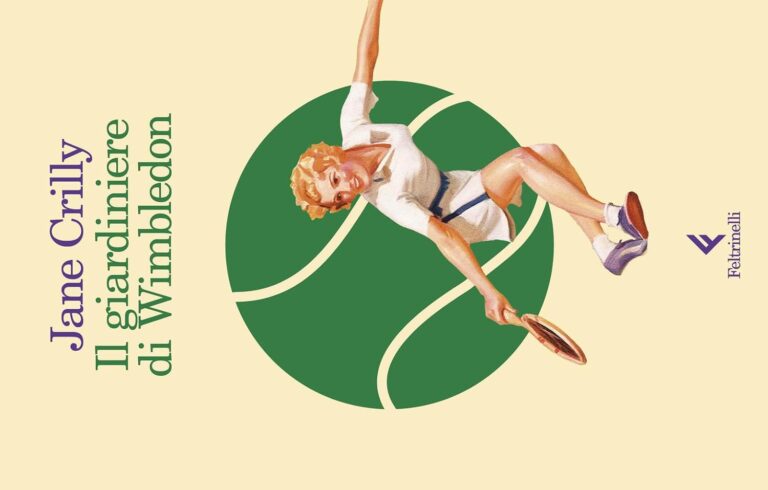
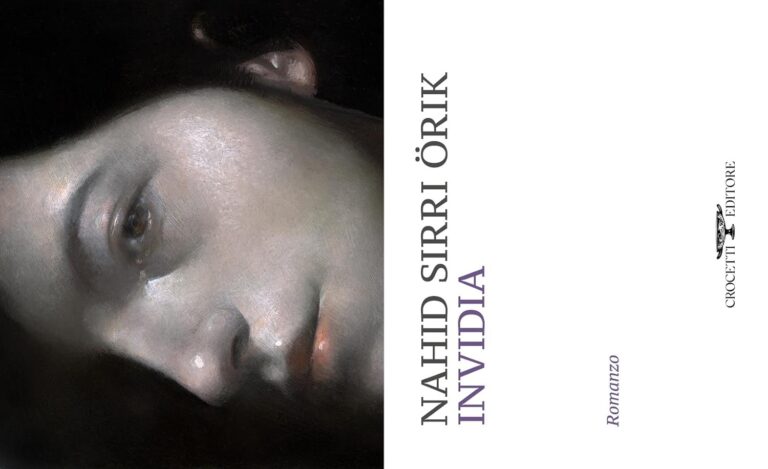
 Una buona domanda per cominciare è la seguente: che cos’è l’invidia? Quali conseguenze può produrre? Per quanto possiamo “coltivarla” prima che ci divori dall’interno? Örik architetta per la protagonista di
Una buona domanda per cominciare è la seguente: che cos’è l’invidia? Quali conseguenze può produrre? Per quanto possiamo “coltivarla” prima che ci divori dall’interno? Örik architetta per la protagonista di 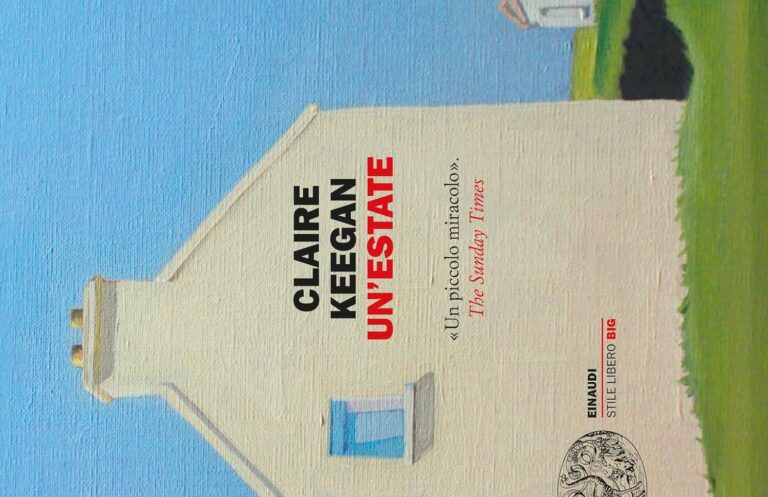

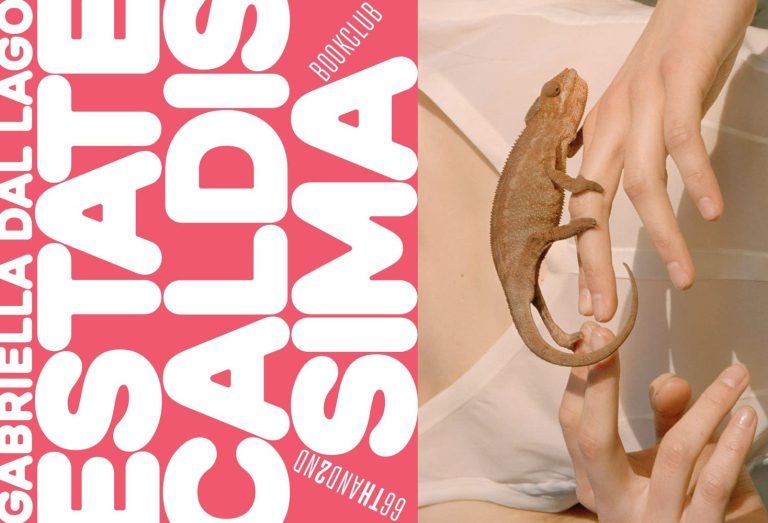
 La casa di campagna che fa da sfondo vivo e presentissimo a
La casa di campagna che fa da sfondo vivo e presentissimo a 

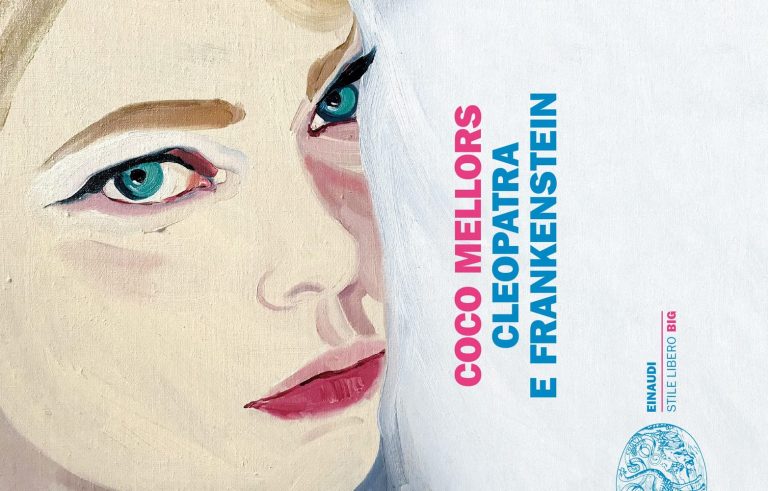

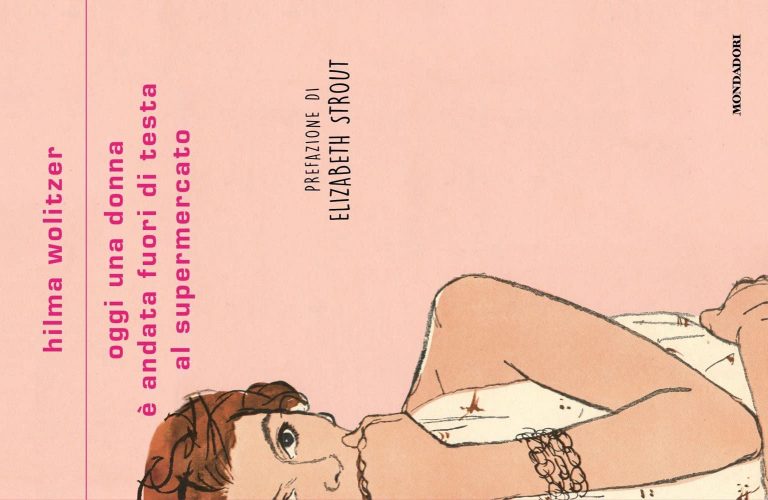
 Hilma Wolitzer è una relativa novità per noi: per la prima volta la troviamo
Hilma Wolitzer è una relativa novità per noi: per la prima volta la troviamo 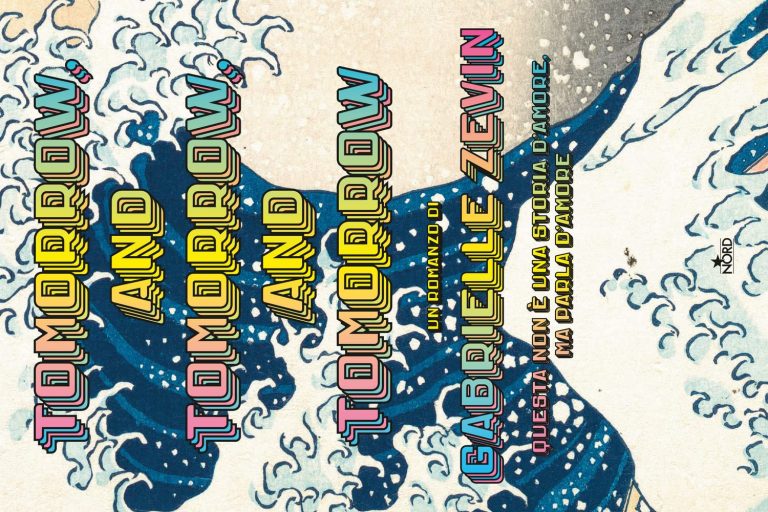
 È bellissimo. Leggetelo.
È bellissimo. Leggetelo.