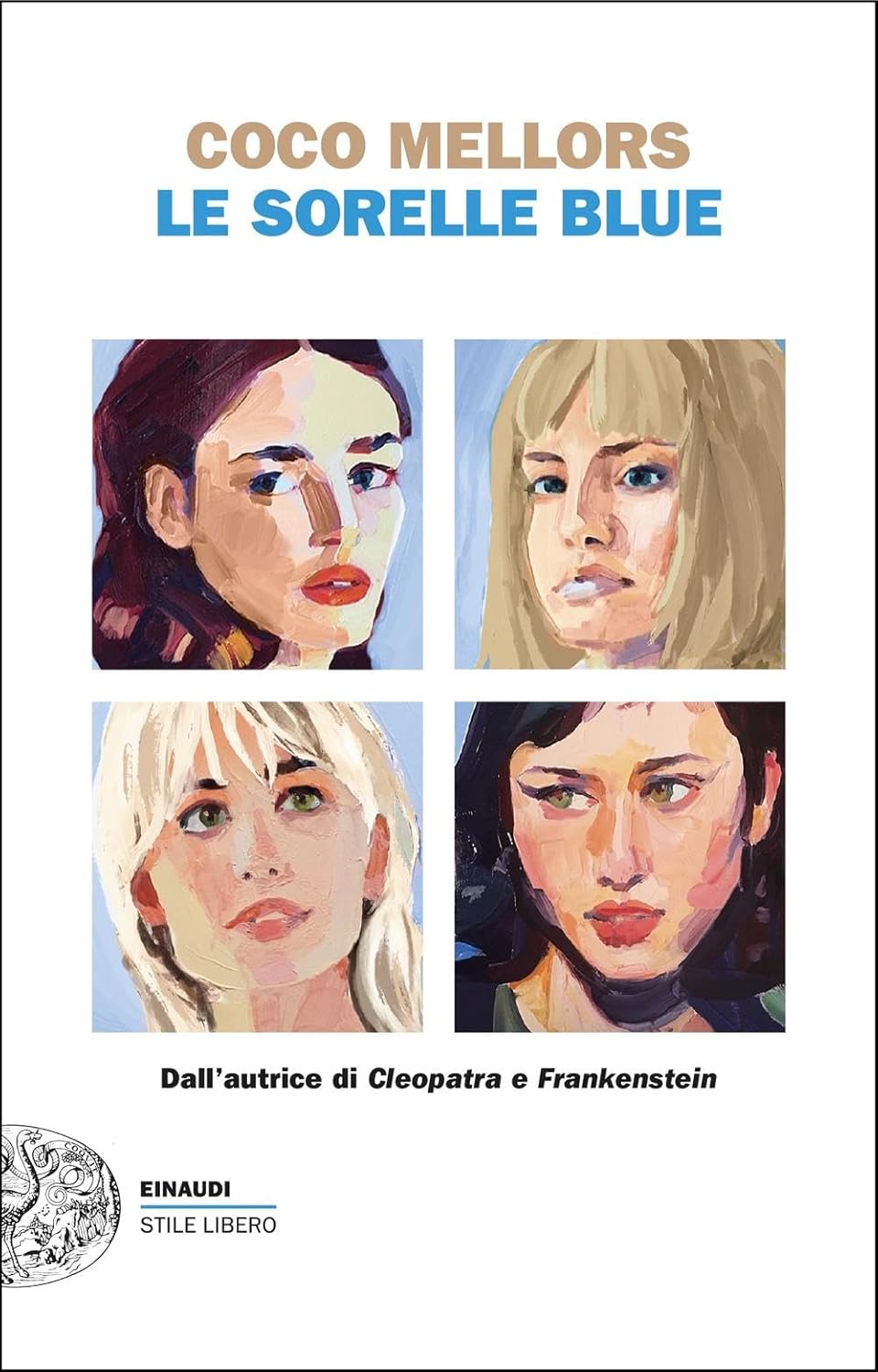Il Premio Malaparte viene assegnato ogni anno a Capri a una personalità rilevantissima della letteratura internazionale. È una felice parentesi di convivialità, dibattito e fertile incontro con l’isola che, nelle sue molte trasformazioni, preserva tenacemente la sua vocazione culturale e artistica. Il vincitore dell’edizione 2025, la ventottesima, è Fernando Aramburu, pubblicato in Italia da Guanda, assai amato da un vasto pubblico per Patria e tradotto per ormai consolidato sodalizio da Bruno Arpaia. Il Malaparte è un riconoscimento all’opera “complessiva” e la preziosa presenza di un autore dal catalogo così nutrito si è anche trasformata in un’occasione per discutere di generi diversi, metodi di lavoro, ricerca linguistica e longevità creativa – che esiste se la spinta per la scrittura obbedisce a un impulso antico e non alla continua replicazione di successi scarsamente architettabili a tavolino.
Prima di procedere con il resoconto dell’intervistona, ecco qua qualche risorsa dal Malaparte-verso.
📚 Edizione 2023: una conversazione con Benjamin Labatut
📚 Edizione 2024: l’incontro con Rachel Cusk
📚 Edizione 2025: Fernando Aramburu si trasforma, piuttosto letteralmente, in un dono per l’isola.
Procediamo? Procediamo.
 Aramburu si è mosso con grande disinvoltura tra narrativa – dal romanzo-mondo alle storie di formazione che attingono dall’esperienza giovanile in un contesto impervio come quello dei Paesi Baschi -, scrittura giornalistica e racconto. La novità più recente, Ultima notte da poveri, approdata in libreria in sostanziale concomitanza col premio, è proprio una raccolta di racconti – particolarmente caustici e imprevedibili. Ci sono trasformazioni, derive grottesche, persone che maneggiano forme di male per deliberato desiderio di nuocere o per opporre una disperata difesa. È gente disallineata, ma anche prontissima a sganciarsi dal sentimento comune di “opportunità” e decoro. Cosa succede ad Aramburu, quando devia dal romanzo per cimentarsi col racconto?
Aramburu si è mosso con grande disinvoltura tra narrativa – dal romanzo-mondo alle storie di formazione che attingono dall’esperienza giovanile in un contesto impervio come quello dei Paesi Baschi -, scrittura giornalistica e racconto. La novità più recente, Ultima notte da poveri, approdata in libreria in sostanziale concomitanza col premio, è proprio una raccolta di racconti – particolarmente caustici e imprevedibili. Ci sono trasformazioni, derive grottesche, persone che maneggiano forme di male per deliberato desiderio di nuocere o per opporre una disperata difesa. È gente disallineata, ma anche prontissima a sganciarsi dal sentimento comune di “opportunità” e decoro. Cosa succede ad Aramburu, quando devia dal romanzo per cimentarsi col racconto?
I racconti mi invadono la testa e mi danno il tormento finché non mi decido a scriverli. Non so perché ma nei racconti perdo il mio lato compassionevole nei confronti dell’umanità. Nel caso dei romanzi, invece, sento di lasciare uno spazio maggiore alla speranza. Non so spiegarmi nemmeno perché nei racconti ci sia sempre una maggiore brutalità, oltre a questa carenza di compassione. Temo non siano letture molto allegre o libri adatti ad accompagnarci sotto all’ombrellone, perché contengono costantemente una certa dose di veleno, di zone buie e cupe.
Ma a controbilanciare c’è anche un buon senso dell’umorismo…
È vero, faccio ricorso all’arma dell’umorismo… ma bisogna fare attenzione col mio umorismo. Da quanto ho potuto verificare, ha la peculiarità di mostrarsi e di venire a galla nelle situazioni in cui forse sarebbe più opportuno un atteggiamento improntato alla gravità, a volte al lutto, alla serietà. Ma è un aspetto che mi definisce quando scrivo e non appartiene alla mia vita quotidiana, alla vita di tutti i giorni. Ovviamente, però, la letteratura esiste anche per permetterci di immaginare situazioni spiacevoli, nelle quali non vorremmo mai trovarci nella vita reale – frangenti come la morte, il dolore, i conflitti matrimoniali e quelli all’interno di una famiglia…
Vi posso assicurare, però, che nella vita di tutti i giorni sono un uomo tranquillo. Ma quando prendo la penna in mano sono assolutamente senza freni. Si scatena il diavolo che c’è in me. [ride]

Se i racconti si materializzano come idee fulminee o “accensioni” improvvise, che ossessionano finché non trovano uno spazio sulla pagina, il lavoro romanzesco è radicalmente diverso, anche all’atto pratico.
Parto sempre da un progetto ben definito e ben delineato. Prima di scrivere la prima frase di un romanzo ho già preso una gran quantità di decisioni, soprattutto formali. È un po’ come se si trattasse di preparare una partita a scacchi in cui, ancora prima di iniziare, bisogna già avere in mente tutte le figure e i personaggi. So che ci sarà una madre, un bambino, un figlio. E la trama, in queste fasi preparatorie, non è neanche così importante.
In secondo luogo, vanno prese delle decisioni relative alla lingua, allo stile della lingua. Non uso sempre la stessa musica verbale. Ad esempio, se devo scrivere una storia ambientata nei Paesi Baschi, sapendo che il popolo basco è poco incline alla verbosità, soprattutto a una verbosità molto fiorita, non potrò scrivere con uno stile come quello – ad esempio – di García Márquez.
Un altro aspetto importante, nel caso del romanzo, è il finale. Ho bisogno di sapere come finisce la storia, ne ho un bisogno assoluto – al contrario di quel che mi succede nel caso dei racconti. Conoscere il finale mi permette di sapere anche dove mi trovo, in qualunque momento della redazione, e dove mi sta portando il fiume narrativo. Il fatto di conoscere la fine mi permette di capire se una parola, un dettaglio, un aggettivo è superfluo o necessario alla trama. E questo aspetto per me è di capitale importanza. Perché un romanzo sia un buon romanzo dobbiamo fare una serie di scelte coerenti che si traducono in scene, dettagli e parole… e tutti questi elementi, congiuntamente, ci fanno confluire verso il finale. Non è detto che sia scolpito nella roccia e che non possa essere cambiato – è successo, anche se resta rarissimo – ma, in generale, tutto va pianificato nel dettaglio. Inizio a lavorare alla trama solo quando comincio con la redazione vera e propria.
Ma come fanno questi approcci così diversi, questi metodi dalle strutture radicalmente opposte a convivere in un unico scrittore?
A casa mia è come se ci fosse una cabina armadio con tantissime ante diverse e in ogni anta c’è una personalità letteraria. In funzione di quello che serve, tiro fuori dall’armadio un vestito specifico – c’è quello del romanziere, quello dell’editorialista… mi trasformo letteralmente in una persona e in uno scrittore diverso in funzione del testo che devo scrivere. E questo l’ho imparato in Germania [dove Aramburu vive ormai dagli anni Novanta]. Il fatto che nell’ambiente in cui abito da così tanto tempo si parli una lingua diversa dalla mia lingua nativa, ha prodotto un certo timore: il mio spagnolo, con gli anni, stava diventando una lingua desueta? Da qui mi sono imbarcato in un processo di oggettivazione della lingua, l’ho “estratta” da me per osservarla. Mi sono anche concesso degli esercizi, un’attività che potrei paragonare a quella di un ventriloquo: mi sono divertito a imitare lo stile degli altri scrittori – e sono riuscito, a volte, anche a ingannare degli amici, a presentare loro dei testi che avevo scritto io ma che loro erano certi che fossero di un altro autore.
A proposito di estrema riconoscibilità, come si “sopravvive” o si impara a convivere con un successo numericamente così rilevante e anche così trasversale come Patria?
 Quello che non volevo fare era ripetere quel genere di successo, perché non sento il bisogno di entrare a tutti i costi nella classifica dei bestseller. Non è colpa mia se Patria è stato il successo che è stato, ma di certo non posso permettere a Patria di proiettare costantemente la sua ombra sulla scrivania dove lavoro. Sono sicuramente mosso da una grande ambizione… ma è un’ambizione letteraria. Se il successo arriva va bene, è sempre il benvenuto, ma non definisce il mio lavoro. Dopo Patria ho aspettato cinque anni per uscire con un nuovo romanzo e in quei cinque anni ho pubblicato versi, riflessioni su altri autori, una raccolta di poesia… avrei potuto capitalizzare il successo di Patria, scrivere immediatamente dopo un Patria 2 e, di certo, mi avrebbe portato un riscontro economico importante. Ma sapevo già che non si sarebbe trattato di un libro di mio gradimento. Non ci avrei creduto nemmeno io, in un libro così. So di avere a disposizione degli anni in cui voglio vivere e scrivere, anni da impiegare per realizzare il mio sogno di adolescente: scrivere un’opera letteraria nel miglior modo possibile, secondo le mie capacità. E questo sogno è indipendente dal successo, che può arrivare o meno. Tutta la mia vita è improntata alla realizzazione di quel sogno, che per me non è in nessun modo negoziabile.
Quello che non volevo fare era ripetere quel genere di successo, perché non sento il bisogno di entrare a tutti i costi nella classifica dei bestseller. Non è colpa mia se Patria è stato il successo che è stato, ma di certo non posso permettere a Patria di proiettare costantemente la sua ombra sulla scrivania dove lavoro. Sono sicuramente mosso da una grande ambizione… ma è un’ambizione letteraria. Se il successo arriva va bene, è sempre il benvenuto, ma non definisce il mio lavoro. Dopo Patria ho aspettato cinque anni per uscire con un nuovo romanzo e in quei cinque anni ho pubblicato versi, riflessioni su altri autori, una raccolta di poesia… avrei potuto capitalizzare il successo di Patria, scrivere immediatamente dopo un Patria 2 e, di certo, mi avrebbe portato un riscontro economico importante. Ma sapevo già che non si sarebbe trattato di un libro di mio gradimento. Non ci avrei creduto nemmeno io, in un libro così. So di avere a disposizione degli anni in cui voglio vivere e scrivere, anni da impiegare per realizzare il mio sogno di adolescente: scrivere un’opera letteraria nel miglior modo possibile, secondo le mie capacità. E questo sogno è indipendente dal successo, che può arrivare o meno. Tutta la mia vita è improntata alla realizzazione di quel sogno, che per me non è in nessun modo negoziabile.
Che tipo era quel ragazzo che sognava di scrivere?
Ero un ragazzo anarchico, un po’ surrealista, coi capelli lunghi… penso che litigheremmo, se ci incontrassimo per strada oggi. [ride] Le idee che ho adesso penso susciterebbero i suoi rimproveri. Ma sono io, in fondo, quello dei due che è sopravvissuto. Non ho la sensazione che nella mia vita sia avvenuto a un certo punto un cambiamento radicale, uno stacco secco o una rottura con il passato. Mi ritengo piuttosto il risultato di un’evoluzione complessiva – il risultato di quello che ho imparato e di quello che mi hanno insegnato.
C’è però una cosa che mi accomuna ancora a quel ragazzo di 14 o 15 anni. Non abbiamo mai accettato la violenza e continuiamo a non accettarla. Mai, in nessuna circostanza, né nell’ambito privato e nemmeno nella società. E qui mi sto riferendo alla violenza di cui sono stato testimone. Proprio da adolescente, ho dovuto fare una scelta: partecipare a quella violenza o oppormi. Penso che l’operato e il lavoro degli intellettuali, in questo senso, sia importantissimo. Qualcuno deve pensare, dal luogo e dallo spazio dell’intelligenza. Possiamo essere d’accordo o no – a seconda dell’intellettuale che parla – ma se non esprimono gli intellettuali chi dovrebbe farlo? I politici? Le persone sui social network? Nelle società più conflittuali e inclini alla violenza, giornalisti e intellettuali sono quelli che scompaiono o che, prima o poi, vengono messi a tacere.
Ci si conosce davvero solo quando ci si rende disponibili ad ascoltare gli altri? Ed è anche così che si può sperare di costruire dei personaggi autentici, scrivendo?
Penso che l’osservazione degli altri abbia un valore e un’utilità quando si ha l’opportunità di farlo da vicino. Osservare una persona in televisione, ad esempio, non ha alcun significato, perché vediamo una persona truccata, collocata all’interno di una situazione concordata. Quello che faccio nei romanzi è soprattutto parlare delle persone, a livello concreto. Non scrivo thriller, non scrivo romanzi rosa, non mi ritengo un esperto di storia o di politica – ovviamente ne so qualcosa, ma non abbastanza da poterne scrivere. Se devo proprio considerarmi un’autorità in qualche campo, è quello della conoscenza dei miei simili. Ma nei loro aspetti più privati, nel loro modo di essere, di saper stare, di capire la vita, di gestire gli anni che restano loro da vivere. Di capire qual è la loro idea della morte, come funzionano le loro relazioni, i loro rapporti familiari, quali sono i loro gusti. Sapere soprattutto come si comportano e come affrontano le tragedie. Per me la noia non esiste: se non ho niente da fare mi siedo fuori al bar e guardo la gente passare.

Si sta in mezzo agli altri per avere qualcosa da scrivere, ma quando bisogna effettivamente farlo serve stare per conto proprio?
Amo moltissimo la solitudine e passo tantissime ore in solitudine, magari con la compagnia della mia cagnolina. E di tre cactus. La mia vita è molto ritualizzata: mi piace fare ogni giorno la stessa cosa alla stessa ora. Ho preso a esempio Kant che diceva “potete utilizzarmi per regolare l’orologio, se volete”. Questo modo di organizzare la mia giornata e la mia vita produce un grande senso di equilibrio. Ovviamente si tratta di una solitudine scelta, volontaria, di cui ho il controllo e che posso interrompere in qualunque momento – sono un uomo sposato, ho una famiglia, ho dei figli, ho una nipotina. Credo che la solitudine sia importantissima per uno scrittore e sono molto grato alla Germania che in qualche modo mi ha isolato. Se fossi vissuto a Madrid o a Barcellona probabilmente avrei scritto il 10% di quello che ho scritto, perché mi avrebbero chiamato gli amici per chiedermi di uscire, di andare a teatro o in giro. E mi conosco… non ho forza di volontà, sarei uscito sempre. In Germania non è successo, invece. Da scrittore mi è andata benissimo così.
Si sentono meglio le voci dei personaggi, in questo produttivo isolamento “scelto”? Pensiamo a un libro come Patria, che di voci ne contiene un coro…
Quando ho iniziato a scrivere, visto che non ero capace di scrivere, ho optato per la prima persona singolare. [ride]. In Patria, invece, ci sono nove voci narranti, più il testo – anche il testo interviene in quanto voce narrativa – e devo dire che se un personaggio ha la responsabilità di essere narratore, lo fa utilizzando la propria voce, una voce che lo caratterizza. Non utilizza la mia voce di scrittore. Se un personaggio è un bambino parlerà con un linguaggio da bambino, semplice. Se è una persona con poca cultura magari commetterà anche degli errori, parlando. Se si tratta di un docente universitario avrà un registro linguistico molto più alto. Tutto questo ha lo scopo di far sì che il lettore sia convinto della verità narrativa. Il mio scopo ultimo è che il lettore dimentichi di avere un libro tra le mani e che abbia piuttosto l’impressione di guardare dalla finestra e veder scorrere le vite degli altri, potrà emozionarsi per queste vite, ridere e piangere. Credo che questo sia il risultato più alto che un romanziere possa ottenere. Il tutto inizia con un inganno, come sappiamo, perché il romanziere non consegna nelle nostre mani un romanzo. Consegna un testo che spetta ai lettori decifrare. E ovviamente questo dipende dal lettore, il modo in cui il testo viene decodificato. Chi è stato in un bookclub lo sa bene – lo stesso libro può ricevere molteplici interpretazioni e reazioni, a seconda della persona che lo legge. Ho tre cactus perché mi servono a ricordare che scrivo per gli altri e non per me e i cactus hanno più o meno le dimensioni della testa di un essere umano – e un’enorme virtù: parlo ai cactus ma loro non mi rispondono. Mi ricordano in ogni momento che loro potrebbero essere i miei potenziali lettori e prima di cominciare a scrivere, ogni giorno, dico loro “oggi scriviamo e la voce narrante sarà quella di un bambino, d’accordo?”. Siccome nessuno ribatte, possiamo cominciare a lavorare tranquillamente. Ecco cosa succede quando si passano così tante ore in casa da soli.
Tra cabine armadio piene di personalità letterarie, diavoli narratori, cactus che fungono anche da oracoli e uno sguardo acutissimo sempre puntato sugli altri, Aramburu sarà anche contento di stare da solo ma non lascia sicuramente da soli i suoi lettori e le sue lettrici. E anche al Malaparte si è dimostrato una splendida e affascinante compagnia.
[Ringrazio ancora il premio per questa ormai consolidata avventura autunnale e Ferrarelle Società Benefit – che ormai da quattordici anni sostiene il Malaparte come sponsor unico – per l’ospitalità e la sempre splendida opportunità.]






 Aramburu si è mosso con grande disinvoltura tra narrativa – dal romanzo-mondo alle storie di formazione che attingono dall’esperienza giovanile in un contesto impervio come quello dei Paesi Baschi -, scrittura giornalistica e racconto.
Aramburu si è mosso con grande disinvoltura tra narrativa – dal romanzo-mondo alle storie di formazione che attingono dall’esperienza giovanile in un contesto impervio come quello dei Paesi Baschi -, scrittura giornalistica e racconto. 
 Quello che non volevo fare era ripetere quel genere di successo, perché non sento il bisogno di entrare a tutti i costi nella classifica dei bestseller. Non è colpa mia se Patria è stato il successo che è stato, ma di certo non posso permettere a Patria di proiettare costantemente la sua ombra sulla scrivania dove lavoro. Sono sicuramente mosso da una grande ambizione… ma è un’ambizione letteraria. Se il successo arriva va bene, è sempre il benvenuto, ma non definisce il mio lavoro. Dopo Patria ho aspettato cinque anni per uscire con un nuovo romanzo e in quei cinque anni ho pubblicato versi, riflessioni su altri autori, una raccolta di poesia… avrei potuto capitalizzare il successo di Patria, scrivere immediatamente dopo un Patria 2 e, di certo, mi avrebbe portato un riscontro economico importante. Ma sapevo già che non si sarebbe trattato di un libro di mio gradimento. Non ci avrei creduto nemmeno io, in un libro così. So di avere a disposizione degli anni in cui voglio vivere e scrivere, anni da impiegare per realizzare il mio sogno di adolescente: scrivere un’opera letteraria nel miglior modo possibile, secondo le mie capacità. E questo sogno è indipendente dal successo, che può arrivare o meno. Tutta la mia vita è improntata alla realizzazione di quel sogno, che per me non è in nessun modo negoziabile.
Quello che non volevo fare era ripetere quel genere di successo, perché non sento il bisogno di entrare a tutti i costi nella classifica dei bestseller. Non è colpa mia se Patria è stato il successo che è stato, ma di certo non posso permettere a Patria di proiettare costantemente la sua ombra sulla scrivania dove lavoro. Sono sicuramente mosso da una grande ambizione… ma è un’ambizione letteraria. Se il successo arriva va bene, è sempre il benvenuto, ma non definisce il mio lavoro. Dopo Patria ho aspettato cinque anni per uscire con un nuovo romanzo e in quei cinque anni ho pubblicato versi, riflessioni su altri autori, una raccolta di poesia… avrei potuto capitalizzare il successo di Patria, scrivere immediatamente dopo un Patria 2 e, di certo, mi avrebbe portato un riscontro economico importante. Ma sapevo già che non si sarebbe trattato di un libro di mio gradimento. Non ci avrei creduto nemmeno io, in un libro così. So di avere a disposizione degli anni in cui voglio vivere e scrivere, anni da impiegare per realizzare il mio sogno di adolescente: scrivere un’opera letteraria nel miglior modo possibile, secondo le mie capacità. E questo sogno è indipendente dal successo, che può arrivare o meno. Tutta la mia vita è improntata alla realizzazione di quel sogno, che per me non è in nessun modo negoziabile.

 Che esista un oceano a separarvi dalla vostra casa d’origine o che vi troviate a un’ora di macchina dal quel che c’è ancora della vostra famiglia,
Che esista un oceano a separarvi dalla vostra casa d’origine o che vi troviate a un’ora di macchina dal quel che c’è ancora della vostra famiglia, 






 Una buona intervista si fa se il soggetto interrogato ha qualcosa da dire e se si fanno le domande giuste. Un’intervista *eccellente* è, in realtà, uno scambio tra due persone che si riconoscono e si rendono disponibili alla reciproca curiosità, scordandosi gerarchie e ruoli per creare qualcosa di autonomo, che per ricchezza sta in piedi da solo e aggiunge un tassello in più rispetto ai punti di riferimento di partenza. Che uno scrittore intervisti bene un altro scrittore non è affatto scontato – genera attenzione perché ti porti a casa due grandi nomi in una botta sola, ma bisogna appaiarli con buonsenso. E anche in quel caso non sai come andrà a finire.
Una buona intervista si fa se il soggetto interrogato ha qualcosa da dire e se si fanno le domande giuste. Un’intervista *eccellente* è, in realtà, uno scambio tra due persone che si riconoscono e si rendono disponibili alla reciproca curiosità, scordandosi gerarchie e ruoli per creare qualcosa di autonomo, che per ricchezza sta in piedi da solo e aggiunge un tassello in più rispetto ai punti di riferimento di partenza. Che uno scrittore intervisti bene un altro scrittore non è affatto scontato – genera attenzione perché ti porti a casa due grandi nomi in una botta sola, ma bisogna appaiarli con buonsenso. E anche in quel caso non sai come andrà a finire.