Quel che sappiamo del “mondo” di Biglietto blu è essenziale (e all’apparenza semplicissimo, nel suo funzionamento): alla prima mestruazione, tutte le ragazze vengono accompagnate in un edificio governativo per l’assegnazione del biglietto che determinerà il loro futuro. Biglietto bianco: avranno una famiglia e dei figli. Biglietto blu: lavoreranno, non saranno obbligate a stringere legami duraturi e dovranno obbedire all’imperativo di non riprodursi. Dopo l’estrazione, le biglietto-bianco saranno caricate su un’auto che le accompagnerà al loro nuovo nido, mentre le biglietto-blu, tempestivamente dotate di spirale, dovranno cavarsela da sole per raggiungere “la città”, abbandonando su due piedi la famiglia d’origine e affrontando un viaggio assai poco rassicurante. Hai fame? Nessun problema, cattura un bel coniglio selvatico e scuoiatelo a mani nude. Hai freddo? Peggio per te. Ti si sono sfondate le scarpe? Rubale a qualche altra ragazzina che vaga sulla statale.
Il biglietto si può cambiare? No, il “sistema” decide, provvede, traccia la rotta e, soprattutto, non sbaglia. Non ci si appella all’assegnazione del biglietto così come non si mettono in discussione le grandi certezze della natura: il sole sorge e tramonta, le biglietto-bianco accudiranno i loro figli e le biglietto-blu saranno produttive, indipendenti e “libere”. Le biglietto-bianco non frequentano le biglietto-blu e nessuna sa più di quello che le occorre sapere. A ogni donna è assegnato un dottore che, a cadenza serrata, si prenderà cura della sua mente e del suo corpo. I dottori sono figure ibride, un po’ psicanalisti, un po’ medici generalisti e un po’ funzionari pubblici, controllori e guardiani. Ti misuro la pressione e mi assicuro che anche questa settimana non ti siano venute le piattole, ti parlo e ti ricordo immancabilmente qual è il tuo posto e che cosa ci si aspetta da te, ti racconto che il sistema ti conosce e che il biglietto che hai è proprio quello che asseconda la tua indole più profonda. Ma fila sempre tutto liscio? Ogni donna obbedisce e si allinea al ruolo che le toccato in sorte? Dipende. Questo romanzo esiste perché esiste una ribelle.

In tutta sincerità, ero in apprensione per la tenuta di questo libro. Nel recente passato, sono spuntati parecchi romanzi che hanno cercato di esplorare i margini di manovra delle femmine all’interno di società e contesti più o meno normati, mondi alternativi che portano all’estremo i germi non sempre benevoli del presente che abitiamo per provare a farci intravedere un fosco orizzonte incombente – o per farci più che motivatamente incazzare. Alcuni libri hanno assegnato alle donne poteri in grado di sovvertire lo status quo – penso a Ragazze elettriche, tanto per citarne uno molto fortunato e credo pure piuttosto riuscito – mentre altri sono partiti da premesse “croccanti” (e forse anche un po’ furbette) per risolversi poi in pasticci che poco aggiungono alla consapevolezza collettiva o si trasformano, più semplicemente, in occasioni sprecate. Insomma, un Racconto dell’ancella non può materializzarsi in libreria tutti i giorni, ma quel che possiamo augurarci è di imbatterci, di tanto in tanto, in un romanzo che non si sfilacci sotto al peso di una premessa forse troppo ambiziosa, per quanto significativa e stimolante. Ecco, Sophie Mackintosh non ci tradisce. Ci tratta un po’ come i medici di Biglietto blu – uscito nei Supercoralli Einaudi nella traduzione di Norman Gobetti – trattano le loro pazienti: ci fornisce l’impianto basilare del mondo e lascia che sia Calla, la biglietto-blu che ci farà da portabandiera, a tratteggiare per noi il paesaggio interiore delle non-allineate. È il tocco di un’accorta stratega, ma è anche molto efficace, “vivo”. Un po’ funziona perché l’isolamento di Calla rispecchia i compartimenti stagni che separano forzosamente le detentrici dei due tipi di biglietto, ma anche perché l’imperativo a cui Calla finirà per rispondere è intimo, slegato dalle circostanze e dalle lecite possibilità che le spettano e, soprattutto, nasce da una presa di coscienza che demolisce i limiti per esplorare il cuore vero della questione: la possibilità di scegliere.
Siamo forse più abituate a lottare per il riconoscimento del nostro sacrosanto diritto a non diventare madri. Mackintosh assegna alla sua protagonista un imperativo diametralmente opposto: in una società che non prevede per le biglietto-blu la possibilità di fare figli (e che con ogni mezzo cerca di convincere le biglietto-blu che quella sia la strada più adatta a loro), Calla cerca di tenere a bada un grumo inammissibile di desiderio, finendo poi per accettare questo “sentimento oscuro” e passare consapevolmente all’azione, preparandosi ad affrontare le poco rosee conseguenze della sua scelta. Lottare per diventare madri o per non diventare madri? In realtà, stiamo parlando della stessa cosa. La gravidanza clandestina di Calla sfonda i confini del lecito per abbattere una barriera che intrappola sia le biglietto-blu che le biglietto-bianco: non ci sarà libero arbitrio per nessuna, finché un sistema senza volto (e forse anche governato da caso) continuerà a stabilire il destino biologico delle sue pedine. Lo status riproduttivo dell’una o dell’altra categoria è solo il tassello iniziale di un’estensione capillare del controllo: nel mondo di Calla viene accettato come fatto inconfutabile che lavoro e cura della famiglia non possano coesistere, che una vivace attività sessuale non possa accompagnarsi alla gestione del focolare domestico, che l’ambizione all’indipendenza economica non possa riguardare anche le madri. Da ambo le parti, le donne vengono catechizzate sistematicamente e strumentalmente. Guarda come sei fortunata, puoi uscire la sera, scopare con chi ti pare, fare carriera e coltivare la tua individualità. Guarda come sei fortunata, puoi coccolare un bebè e vivere in una bella casa, sei al sicuro, là fuori ci si affanna ma tu non devi preoccuparti di nulla. Calla avanza, giorno dopo giorno, con la convinzione di essere difettosa, di non aver meritato il biglietto-bianco, di essere carente su qualche fronte decisivo. Le viene ripetuto che non dipende da lei, che quello che le è stato assegnato è esattamente quello che merita e che le si addice di più, perché il sistema le conosce tutte e sa che cosa è meglio per ciascuna. Non è tutto più semplice, alla fin fine, quando qualcuno traccia già il sentiero per noi? Perché affannarsi tra decisioni, scelte e cantonate inevitabili, quando possiamo riconoscerci nel ruolo che ci è stato assegnato e risparmiarci un sacco di fatiche e di sofferenze? Calla si renderà presto conto, però, che per quanto un carceriere possa apparirci benevolo, sempre un carceriere resta.
Per non rovinarvi avvenimenti e colpi di scena non mi addentrerò nel viaggio di Calla – ormai smascherata da una pancia prominente, verrà magnanimamente invitata a lasciare il contesto civile di cui non può più dirsi parte – ma quel che mi sento di dire è che sì, regge fino alla fine. Anzi, il finale è un bel treno che vi investirà. Giuro, sono dilaniata.
Mackintosh è asciutta, diretta, essenziale. Calla esordisce con reticenza, perché molto del suo cuore è abituata a nascondere per poter continuare a esistere “libera”, ma quello che si concede di provare cresce gradualmente col venire meno delle impalcature che da sempre la ingabbiano. È un romanzo che rifugge ogni approccio impositivo all’identità, che rivendica un territorio dove sentirci alleate, dove poterci evolvere e riconoscere. È un romanzo che parla di corpo, di strutture di controllo e di indipendenza – che non deriva semplicemente dal poter esercitare un individualismo “produttivo”, ma dalla possibilità di costruire uno spazio di scelta che non dipenda da legittimazioni esterne o dall’imposizione di un modello. È un libro, anche, che demolisce l’illusione confortante di una deresponsabilizzazione sistematica: vogliamo prenderci cura di te, vogliamo toglierti un peso, ti vogliamo semplificare la vita… ecco perché decidiamo per te. Tu non ne sei capace, è chiaro, ma siamo pronti a farci carico anche di questo tuo limite. Ci sta a cuore il tuo bene, davvero, compenseremo noi le imperfezioni che ti impediscono di affrontare l’universo in autonomia. Ma cosa stiamo al mondo a fare, se non per tentare con le nostre migliori forze di far combaciare la realtà esterna con la realtà che ci portiamo dentro? Cosa ci resta, se non veniamo manco ritenute in grado di sapere chi siamo o di scoprire, col tempo, che cosa desideriamo davvero? Un biglietto colorato, forse. Assegnato per caso.
 Reduci dalla NOTEVOLE mole di 4321 – che possiamo aver amato o molto ammirato o possiamo magari ricordare in prevalenza per la fatica che ci ha fatto fare -, trovarsi alle prese con un Auster così snello, in libreria per i Supercoralli Einaudi con la traduzione di Cristiana Mennella, è già una notizia.
Reduci dalla NOTEVOLE mole di 4321 – che possiamo aver amato o molto ammirato o possiamo magari ricordare in prevalenza per la fatica che ci ha fatto fare -, trovarsi alle prese con un Auster così snello, in libreria per i Supercoralli Einaudi con la traduzione di Cristiana Mennella, è già una notizia.
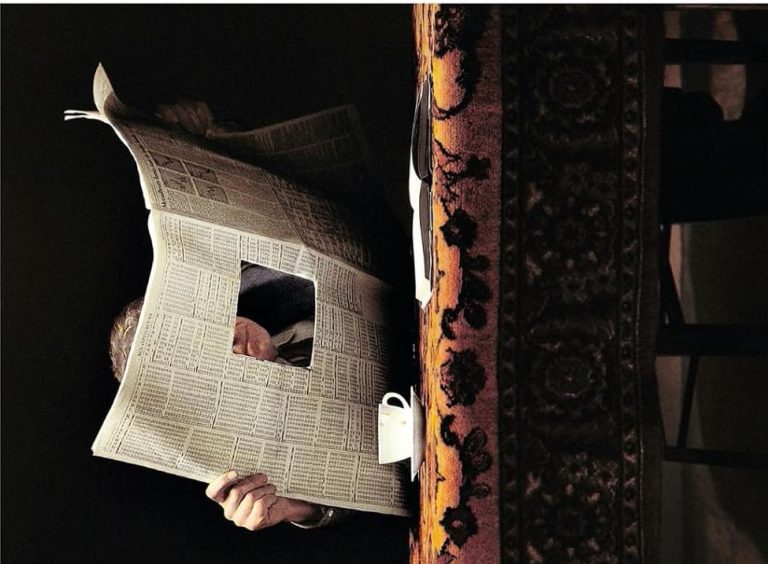


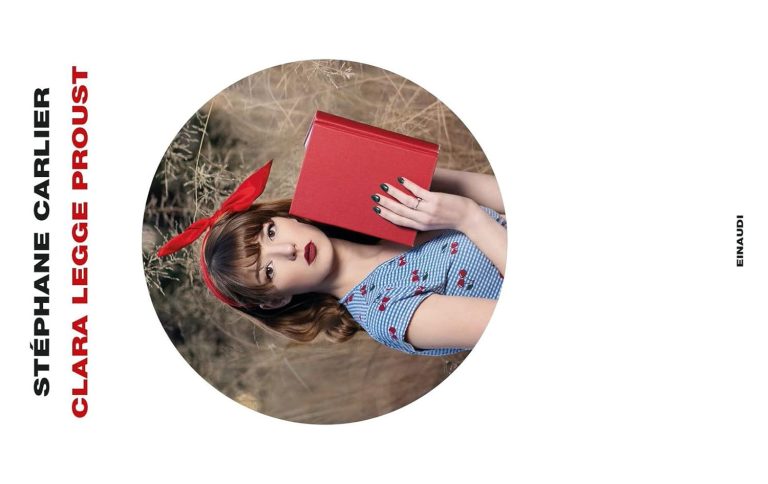
 Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust.
Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust. 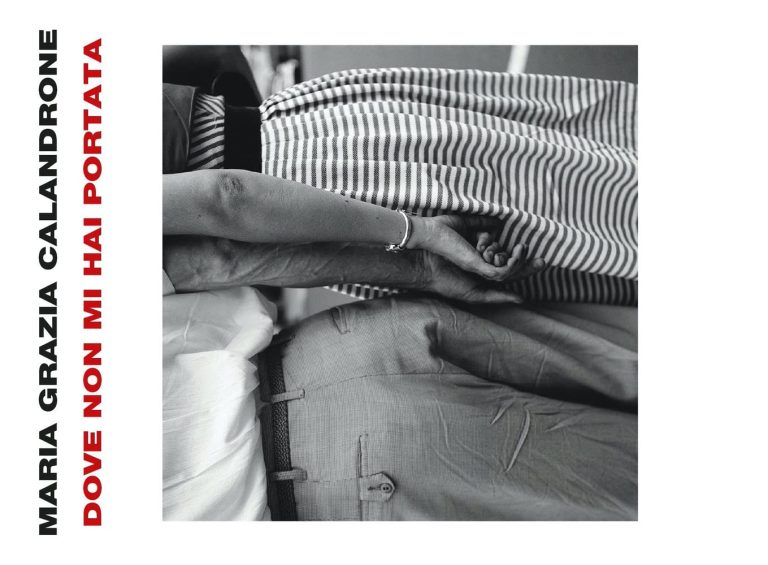
 Chi era Lucia, la madre? Che vita può essere stata quella di una donna (ancora giovanissima) che sceglie di morire dopo aver creduto profondamente in un amore giudicato inammissibile? Chi si è lasciata alle spalle in Molise, a Palata? E chi era Giuseppe, l’uomo che le ha donato una parentesi di felicità?
Chi era Lucia, la madre? Che vita può essere stata quella di una donna (ancora giovanissima) che sceglie di morire dopo aver creduto profondamente in un amore giudicato inammissibile? Chi si è lasciata alle spalle in Molise, a Palata? E chi era Giuseppe, l’uomo che le ha donato una parentesi di felicità?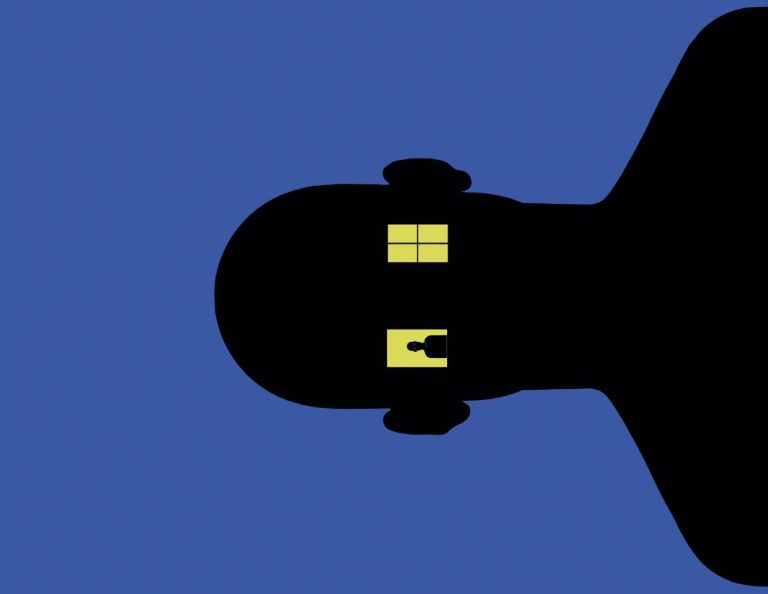

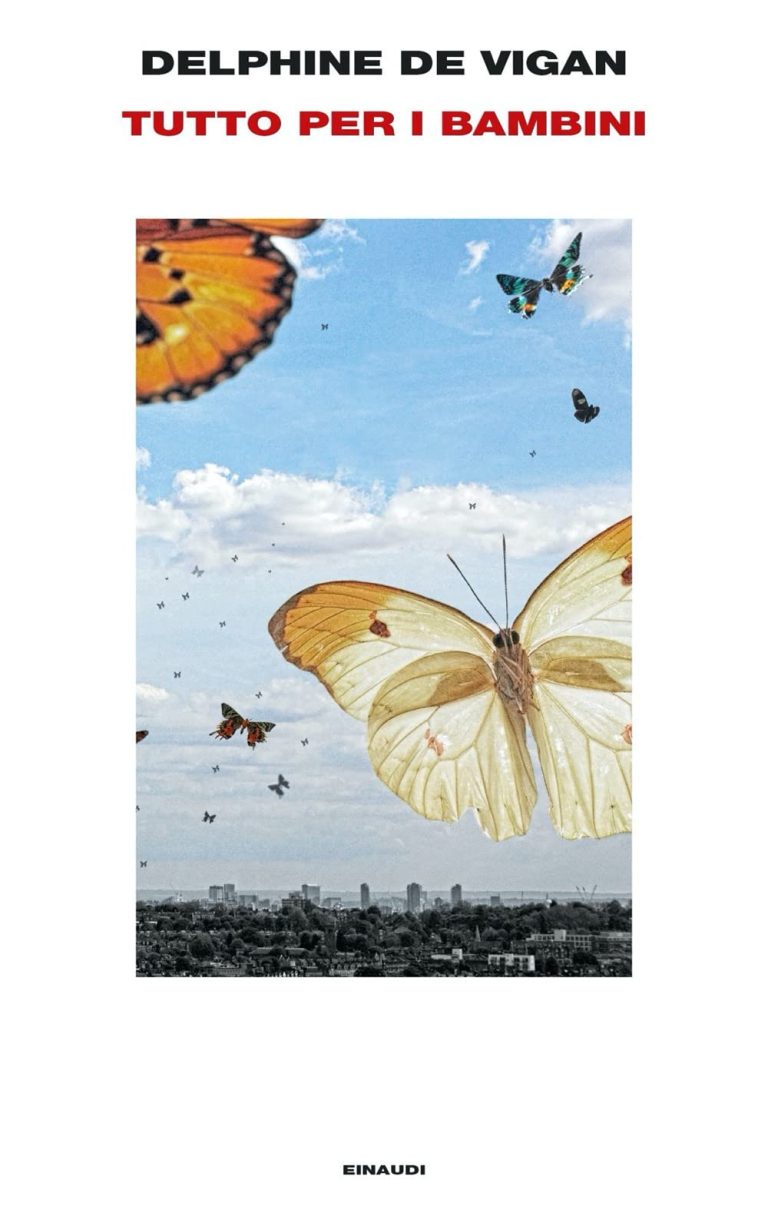
 Mélanie, non si sa se per ingenuità, opportunismo o mera ambizione, cerca di convincersi che tutto quello che lei ama fare, apparendo, sia un gioco e una gioia priva di vincoli anche per i suoi figli – oltre che per un pubblico sterminato e molto partecipe -, ma sarà davvero così? Se il maggiore, Sam, non manca mai di dimostrarsi collaborativo, lo stesso non si può dire della sorellina minore, che crescendo pare sempre meno entusiasta di guardare in camera e recitare il copione prestabilito…
Mélanie, non si sa se per ingenuità, opportunismo o mera ambizione, cerca di convincersi che tutto quello che lei ama fare, apparendo, sia un gioco e una gioia priva di vincoli anche per i suoi figli – oltre che per un pubblico sterminato e molto partecipe -, ma sarà davvero così? Se il maggiore, Sam, non manca mai di dimostrarsi collaborativo, lo stesso non si può dire della sorellina minore, che crescendo pare sempre meno entusiasta di guardare in camera e recitare il copione prestabilito…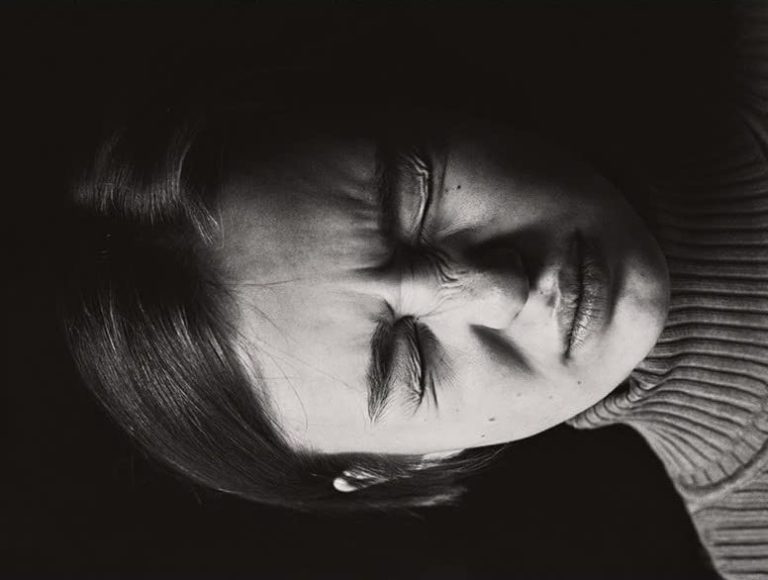
 Vi ho quasi certamente attaccato una pippa superflua, però.
Vi ho quasi certamente attaccato una pippa superflua, però. 
 Vorrei esordire con una personalissima constatazione: Paolo Cognetti mi infonde serenità. Non c’è romanzo o cronaca del suo filone “d’alta quota” – da
Vorrei esordire con una personalissima constatazione: Paolo Cognetti mi infonde serenità. Non c’è romanzo o cronaca del suo filone “d’alta quota” – da 


 Claudia e Francesco condividono un legame antico. Un po’ dipende dalla fascinazione di lui e un po’ dalle circostanze: la madre di Francesco e il padre di Claudia sono amanti. Quando, ancora ragazzini, si trovano a dover imparare a convivere con questa realtà parallela – che sgretola famiglie “ufficiali” ma spalanca uno spazio di sentimento libero, nonostante tutto – diventano un punto di riferimento l’una per l’altro. In comune hanno più di quanto si potrebbe sospettare e, negli anni, nemmeno la distanza li separerà, perché quello che davvero li fonde è l’essere perennemente spostati rispetto al contesto a cui appartengono.
Claudia e Francesco condividono un legame antico. Un po’ dipende dalla fascinazione di lui e un po’ dalle circostanze: la madre di Francesco e il padre di Claudia sono amanti. Quando, ancora ragazzini, si trovano a dover imparare a convivere con questa realtà parallela – che sgretola famiglie “ufficiali” ma spalanca uno spazio di sentimento libero, nonostante tutto – diventano un punto di riferimento l’una per l’altro. In comune hanno più di quanto si potrebbe sospettare e, negli anni, nemmeno la distanza li separerà, perché quello che davvero li fonde è l’essere perennemente spostati rispetto al contesto a cui appartengono.