
Cos’è, questo Rifiuto di Tony Tulathimutte – uscito qui da noi per e/o con la traduzione di Vincenzo Latronico?
È un romanzo di racconti, più una meta-appendice finale in cui l’autore si fa rifiutare il libro da una casa editrice. Le storie stanno in piedi pure da sole, ma contengono personaggi e rimandi che appaiono anche nelle altre.
Mondo?
È sia il nostro che quello incistatissimo e ultra-tribale delle comunità digitali. Ci trovate il dating (più o meno) online, il porno, i videogiochi, gli incel con le spalle strette, i tech-bro startuppari fanatici, i collettivi universitari che decostruiscono e problematizzano anche un toast al formaggio, i maschi che si considerano più femministi delle femministe, i segaioli stravolti, la gente che decide di non avere un’identità e se ne crea così tante sui social da trasformarsi in un mito o in una cospirazione, le ragazze sole che si aggrappano a uomini che se le fiondano una volta e poi dicono “cavolo, hai frainteso, ci tengo troppo alla nostra amicizia”.
Sono tutte persone incastrate e storte che si sentono troppo bizzarre per trovare una nicchia di vera appartenenza e che, allo stesso tempo, non desiderano quella solitudine e non l’hanno chiesta. Sono certe di essere impossibili da amare o da capire, di essere troppo o troppo poco e si rifugiano in un vittimismo paradossale che è talmente egoriferito e “chiuso” da smentire il loro desiderio di base – trovare qualcuno che le veda, che le capisca, che se le pigli e le faccia sentire normali, una buona volta. Al “povera/o me” s’attacca tutto il discorso dell’identità, che Tulathimutte spezzetta in un gran sistema solare di auto-marginalizzazioni e di traumi specifici, sbandierati per accumulare ancora più punti-compassione e non per combattere le iniquità – reali e zeppe di implicazioni – con la forza di un collettivo. Che altro avrebbero, altrimenti?
Che c’entrano gli spazi digitali? Parecchio, perché se nel mondo “reale” e in mezzo alla gente si appare all’istante alieni e inadeguati, invasati con roba che non conosce nessuno o cronicamente sfigati e soli, online si può fare a meno del corpo, si possono mediare le interazioni per farle diventare gestibili, si può ripartire da zero – mascherandosi da altro – e spremere dopamina dai cuori che arrivano. Ci si rappresenta e ci si racconta, si separano gli ambienti per fare in modo che almeno uno diventi vivibile, ma ci si può ingannare fino a un certo punto – perché il corpo, volenti o nolenti, c’è.
Sono anche posti in cui la rabbia trova una destinazione e viene nobilitata dalla ricostruzione di una rete di punti di riferimento – questo contesto ha rigettato anche te? Perfetto, vieni qua che siamo già parecchi e, a ben pensarci, forse abbiamo ragione noi. Nessuno è felice della sua condizione, ma non è un patimento passivo e arrendevole: contiene sempre la convinzione – più o meno ben riposta – di aver subito un’imperdonabile ingiustizia.
Qua dentro c’è molto sesso, ci sono kink considerati irricevibili dagli stessi personaggi che quelle pulsioni le provano, ci sono fantasie che si dilatano fino all’assurdo più totale e c’è roba obiettivamente schifosa che, per accumulazione estremamente fantasiosa, trasforma il libro in una succursale di Rotten che, oltre al corpo, comprende anche le relazioni umane.
Il linguaggio?
Ha tradotto Latronico e, anche senza aver visto il materiale di partenza, quel che ha dovuto gestire non è solo l’inglese, ma anche un’abbondanza di gerghi specialistici da subculture del web, il miscuglio di slang e brevità delle chat “chiuse”, l’aziendalese, il motivazionalese e lo spogliatoiese. Non sono certissima che qua dentro si batta il record mondiale dell’utilizzo del termine “sborra”, ma qualche soldo ce lo metterei. Dev’essere stato un lavoraccio e molte decisioni gestionali si sono visibilmente rese necessarie, ma fila via in una maniera che in italiano suona plausibile.
Non so quanto senso abbia – dato il tema e il passo del libro – star qua a proporre dei trigger-warning ma, se siete di costituzione delicata e cercate storie confortevoli ed edificanti, non credo che vi convenga molto tentare.
Per tutti gli altri, Rifiuto è doomscrolling a forma di romanzo. Fa ridere, fa vomitare, fa impressione (sia per inventiva che per schifo e arguzia), fa satira, esaspera profondamente, ipnotizza come un incidente stradale e non somiglia a niente. Non vuoi neanche immaginartela della gente del genere, ma vuoi andare avanti a leggere. È un libro strutturato in modo da farvi sentire, sviscerare e trovare problematiche, disoneste e strumentali tutte le campane. Quel che le accomuna è che suonano irrimediabilmente a morto e il funerale potrebbe diventare il nostro – sempre che non lo sia già.






 Che esista un oceano a separarvi dalla vostra casa d’origine o che vi troviate a un’ora di macchina dal quel che c’è ancora della vostra famiglia,
Che esista un oceano a separarvi dalla vostra casa d’origine o che vi troviate a un’ora di macchina dal quel che c’è ancora della vostra famiglia, 


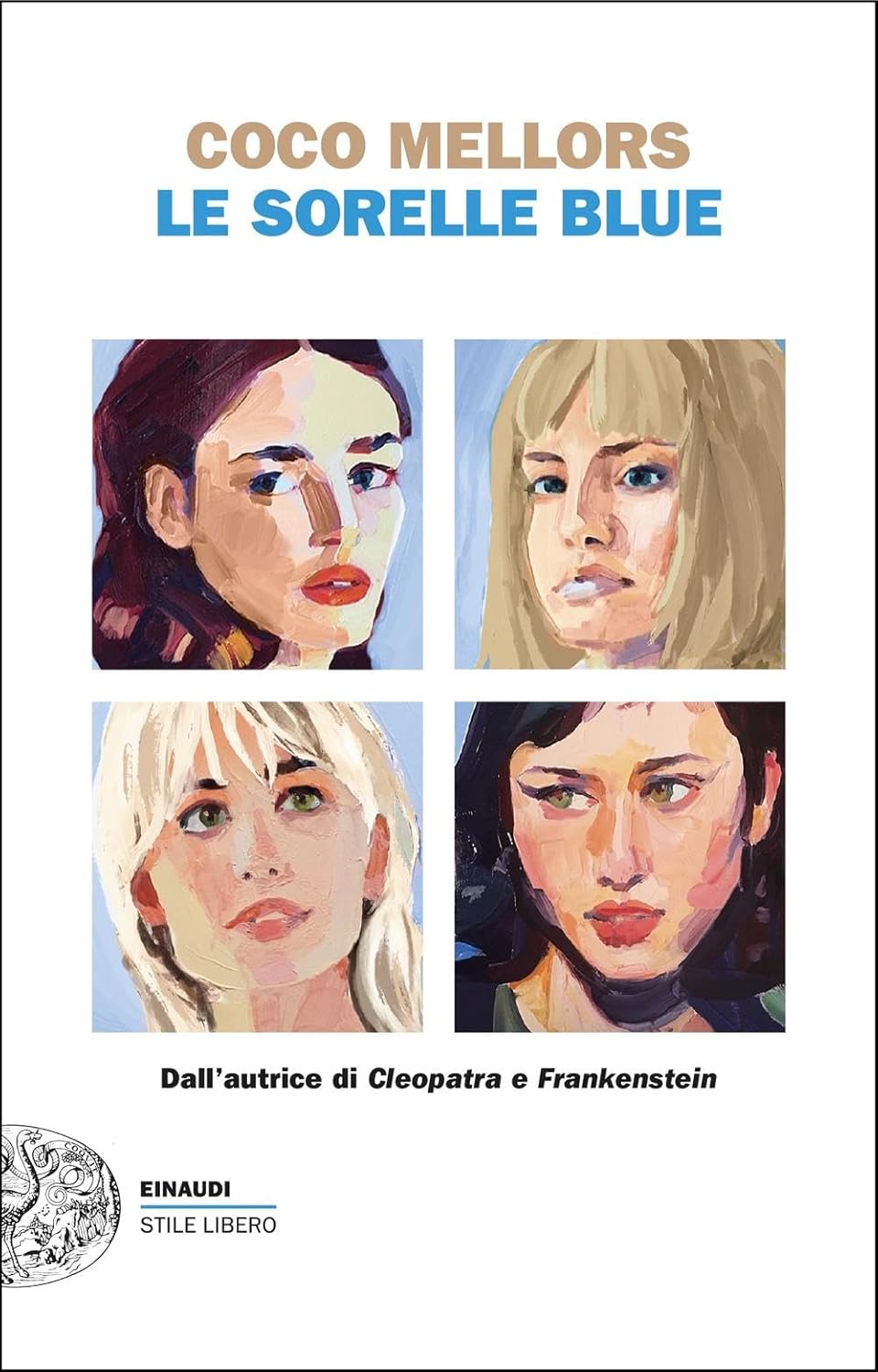

 Il problema che
Il problema che 


 Devo ammettere che il mio preferito resta
Devo ammettere che il mio preferito resta 
 Non so se riuscirò mai a ricordarmi nell’ordine giusto le creature che popolano il titolo di
Non so se riuscirò mai a ricordarmi nell’ordine giusto le creature che popolano il titolo di 
 Di
Di