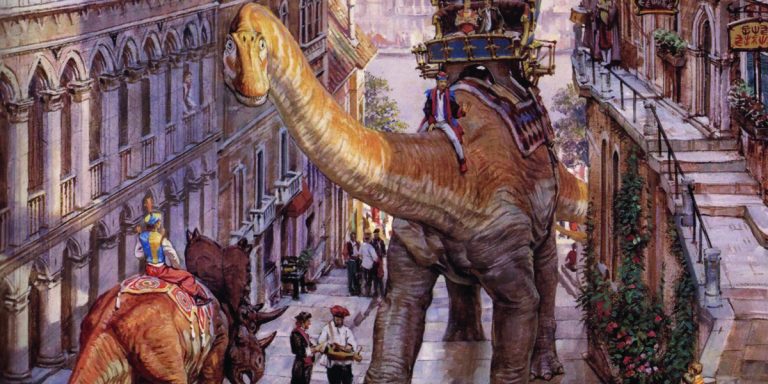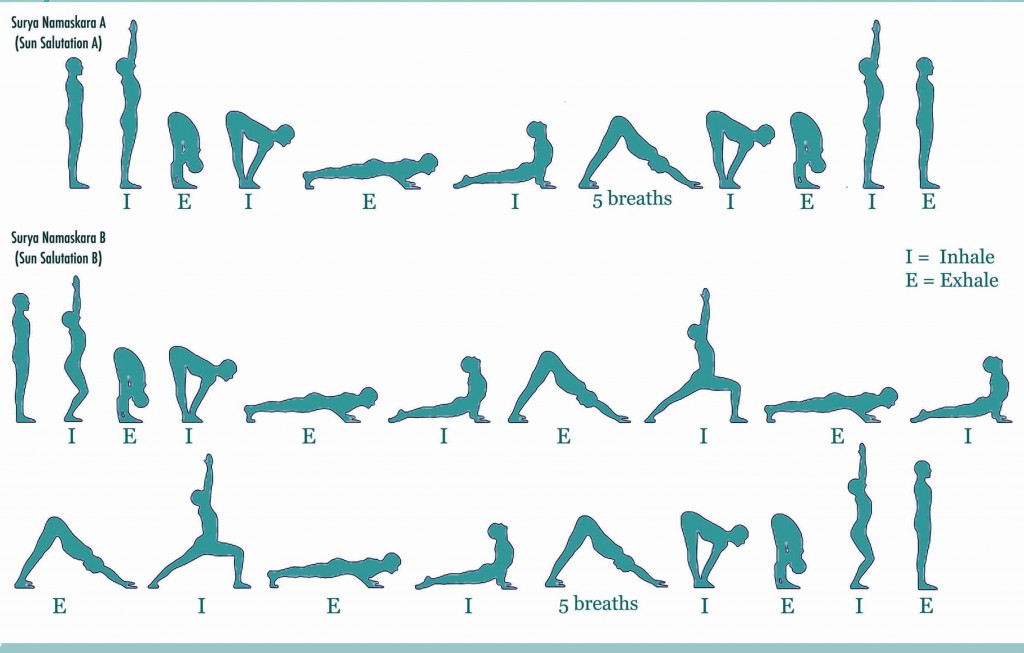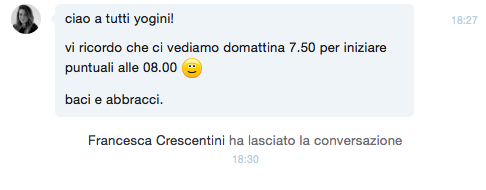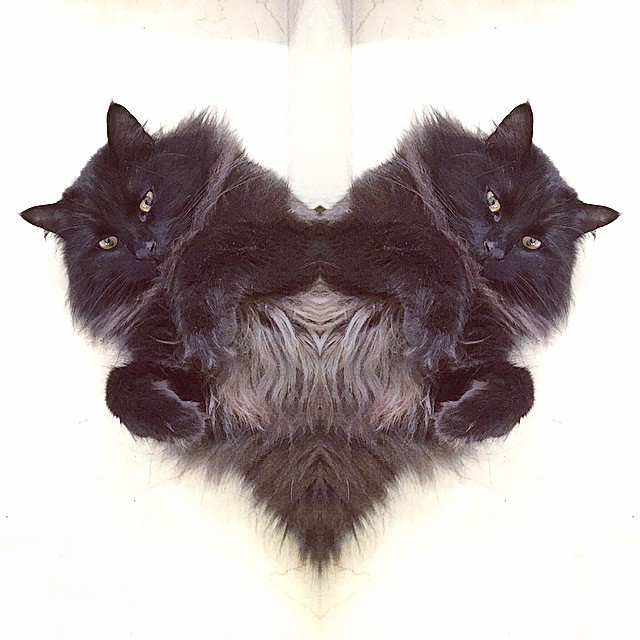A Life’s Work, in italiano, si chiama Puoi dire addio al sonno ed è uscito per Mondadori (con la traduzione di Micol Toffanin) nel 2009, nell’ormai lontana era pre-Resoconto/Transiti/Onori. Il titolo che è toccato a noi è decisamente meno denso di significato. E di certo strizza l’occhio alla longeva tendenza a classificare i racconti incentrati sulla maternità (autobiografici – come in questo caso – e non) in due grandi categorie piuttosto polarizzate: da una parte ci sono quelle che te la mettono giù durissima e, dall’altra, le pasticcione piene d’entusiasmo, quelle che tra mille peripezie e goffaggini cercano di venderti una versione rassicurante e spensierata del diventare madri.
[EDIT per aggiornarci sugli avvenimenti più recenti: nel 2021, A Life’s Work è transitato nel catalogo Einaudi con un titolo che trasporta esattamente quello originale: Il lavoro di una vita.]
Quelle che te la mettono giù durissima vengono solitamente accusate di voler terrorizzare le loro simili o di dipingere a tinte eccessivamente fosche un’esperienza indiscutibilmente sacra e meravigliosa. Anzi, si continua ancora a colpevolizzare, perché se una ti viene a raccontare – ad esempio – una depressione post-partum diventa quasi automaticamente una donna da guardare con sospetto, una persona che deve avere per forza qualche tara pesante, visto che non partecipa alle gioie dell’avvenuta procreazione e sembra tirarsi indietro di fronte alla sua grande missione biologica – e poi diciamocelo, signora mia, se non voleva i figli doveva pensarci prima.
Le allegre pasticcione sono pronte a fornirci speranza. Dai, se ce l’ha fatta questa rincoglionita posso farcela anch’io. Dimmi che andrà tutto bene. Raccontami di sederini morbidi, di piedini piccolissimi, di tutine, di passeggiate al parco, di sensazioni di infinito appagamento e di “finalmente ho capito qual è la mia vera vocazione”.
 Il problema con le due estremizzazioni non è di poco conto. Le narrazioni che te la mettono giù dura tendono a far venire a galla il brutto, lo sporco, l’emotivamente disturbante e il difficile. Per quanto tutto ciò possa rispondere a verità, sono inevitabilmente respingenti. Le tribolazioni altrui, soprattutto in tema di maternità, scatenano i sensi di colpa, innescano una reazione di difesa che porta all’istante a dichiarare che tu no, tu non sei mica un mostro del genere. Perché? Perché la “madre” non è un concetto neutro. Anzi, è uno dei concetti più connotati e più zavorrati dalle aspettative collettive. Sguazziamo in uno stereotipo resistentissimo che stabilisce come dovrebbe essere una “buona madre” – e poco importa se lo stereotipo sia datato, figlio prediletto di una cultura che santifica la donna solo se fa la madre (e basta) e assolutamente scollato dalla realtà socioeconomica che abitiamo. Il fatto è che esiste anche quello che ci spaventa. Esistono anche situazioni che non ci somigliano o nelle quali preferiremmo non ritrovarci. Il fatto che una narrazione sia respingente – secondo certi canoni o private sensibilità – non la rende meno autentica o meno degna di essere ascoltata, capita, accolta. Non è che leggendo un’esperienza “negativa” della maternità e prestando orecchio anche alle campane meno entusiastiche ci si esponga a un qualche genere di contagio. Non è che empatizzando con chi ha avuto una partenza in salita – o con chi continua ad arrancare – finiremo per sabotarci. Chiaro, poi… quello che scegliamo di incamerare nelle nostre riflessioni risponde anche a un bisogno, a una ricerca di senso che può portarci a cercare conforto in peripezie simili alle nostre o a trovare quello che ci serve in racconti più spensierati, più edulcorati, più “positivi”. Ed eccoci arrivati al polo opposto.
Il problema con le due estremizzazioni non è di poco conto. Le narrazioni che te la mettono giù dura tendono a far venire a galla il brutto, lo sporco, l’emotivamente disturbante e il difficile. Per quanto tutto ciò possa rispondere a verità, sono inevitabilmente respingenti. Le tribolazioni altrui, soprattutto in tema di maternità, scatenano i sensi di colpa, innescano una reazione di difesa che porta all’istante a dichiarare che tu no, tu non sei mica un mostro del genere. Perché? Perché la “madre” non è un concetto neutro. Anzi, è uno dei concetti più connotati e più zavorrati dalle aspettative collettive. Sguazziamo in uno stereotipo resistentissimo che stabilisce come dovrebbe essere una “buona madre” – e poco importa se lo stereotipo sia datato, figlio prediletto di una cultura che santifica la donna solo se fa la madre (e basta) e assolutamente scollato dalla realtà socioeconomica che abitiamo. Il fatto è che esiste anche quello che ci spaventa. Esistono anche situazioni che non ci somigliano o nelle quali preferiremmo non ritrovarci. Il fatto che una narrazione sia respingente – secondo certi canoni o private sensibilità – non la rende meno autentica o meno degna di essere ascoltata, capita, accolta. Non è che leggendo un’esperienza “negativa” della maternità e prestando orecchio anche alle campane meno entusiastiche ci si esponga a un qualche genere di contagio. Non è che empatizzando con chi ha avuto una partenza in salita – o con chi continua ad arrancare – finiremo per sabotarci. Chiaro, poi… quello che scegliamo di incamerare nelle nostre riflessioni risponde anche a un bisogno, a una ricerca di senso che può portarci a cercare conforto in peripezie simili alle nostre o a trovare quello che ci serve in racconti più spensierati, più edulcorati, più “positivi”. Ed eccoci arrivati al polo opposto.
Sì, ma il libro?
Il polpettone introduttivo mi sembrava rilevante, in questo caso, perché A Life’s Work non ha ricevuto un’accoglienza particolarmente tenera. Come racconta anche Cusk nell’introduzione alla nuova edizione del volume, tanto si è detto e scritto di lei come madre, di quello che avrebbe pensato sua figlia – non sia mai! – leggendo, da grande, questa cronaca dei suoi primi mesi di vita.
Cusk è incoraggiante? Fornisce risposte? Ha scritto un manuale per la gestione del neonato? Ha cercato di convertirci a una corrente pedagogica? Ci vuole imporre un punto di vista? Per niente.
Cusk si è domandata, in estrema sintesi, che fine faccio io – madre – quando metto al mondo un figlio. Che cosa succede al corpo, alla vita interiore e alla struttura del mondo di una donna che, a un certo punto, partorisce e piomba in un paradigma completamente nuovo. Che cosa accade alla coscienza individuale quando si trova legata a un altro essere umano che è stato per nove mesi parte di te e che, separandosi, manifesta una volontà, dei bisogni primari che non sono negoziabili, delle esigenze e dei comportamenti che non si adattano alle norme e al funzionamento della realtà che conosciamo.
E non sono domande che trovano risposta nel semplicistico “eh, ti è nato un figlio che cosa ti aspettavi, mica è tutto uguale poi”.
Pur sapendo che le cose cambieranno, non c’è nessuno che viene a farti un bel disegnino. Così come non c’è nessuno che può dirti come cambieranno per te. Per la madre standardizzata dell’immaginario collettivo c’è un percorso assai chiaro – e anche una serie di traguardi emotivi da raggiungere, accompagnati da una tabella dei sentimenti autorizzati e degli obiettivi che la prole deve centrare per potersi ritenere “normale”. Certo, sarà difficile, ma ci hanno insegnato che lo spirito di sacrificio è il motore di ogni madre che si rispetti. Suvvia, che sarà mai.
A Life’s Work non la mette giù dura. Non è nemmeno stato scritto per il gusto di provocare, turbare o scandalizzare – non che poi contenga chissà quale vicenda provocatoria, disturbante o scandalosa. Tira semplicemente fuori delle domande eretiche rispetto al paradigma della madre esemplare. Perché al centro dell’attenzione – somma stranezza – c’è la madre, non c’è il bambino. È un libro che parla di ruoli e di equilibri. Chi ero e chi sono? Non c’è un interruttore che ci fa passare dalla “modalità io” che ci ha accompagnato per tutta la vita alla “modalità madre” in maniera automatica. E chiedersi che cosa resta di te – specialmente nei primi mesi – è un quesito perfettamente legittimo, indipendentemente da quanto tu sia felice, triste, sola, supportata, disperata, sostenuta, euforica, convinta, preoccupata, assonnata, energica. È un libro che si interroga sull’identità femminile in un momento cruciale, ma senza cancellare o ignorare le altre spinte che costituiscono, nel loro complesso, quel “chi siamo”. Diventare madri non è obbligatorio ma, quando succede, è senza dubbio un’esperienza di trasformazione. Perché diventando madri diventeremo altro, ma se siamo qui vuol dire che abbiamo macinato storie, idee, sogni, relazioni, punti di riferimento, passioni, abitudini. Sovrascriverli completamente ci renderebbe madri migliori? Rachel Cusk non ha stilato per noi un decalogo su come disinnescare le coliche o un vademecum per selezionare la babysitter perfetta. Non è una madre “pratica”. Non è la madre saggia che pretende di spiegarti come si vive, di mostrarti un modello d’eccellenza, di pungolarti affinché tu sia radiosa, euforica, appagata e… innocua per il tuo prossimo. Cusk è una persona che si sta domandando insieme a noi che cosa sia, alla fin fine, una delle molti madri possibili. Quello che le accomuna tutte è la portata di un compito che non si esaurisce mai, finché si sta al mondo. A Life’s Work? Credo proprio di sì. È un tragitto fluido, un susseguirsi di abissi anomali. E può capitare, affacciandosi sull’orlo del baratro, di percepire la vertigine e di perdere l’equilibrio… ma anche di trovarsi di fronte, molto spesso, a un paesaggio meraviglioso.
 Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta, furibonda e circostanziata. Nel produrre questo ritratto “mediato” di Angela, Antonio Franchini intreccia piani temporali, registri e ricordi, restituendoci un intero sistema di disvalori, oltre che la parabola biografica di un rapporto di sangue. Angela è difficile da intrappolare e impossibile da neutralizzare, perché non tace mai e sgomita per deformare la realtà. Il suo dominio è lo spazio domestico – prima a Napoli e poi a Milano, dove segue due dei suoi figli ormai diventati adultissimi – ma il dove la si piazzi conta poco, perché Angela è impermeabile al mondo, alle opinioni altrui, all’italiano e alla temperanza.
Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta, furibonda e circostanziata. Nel produrre questo ritratto “mediato” di Angela, Antonio Franchini intreccia piani temporali, registri e ricordi, restituendoci un intero sistema di disvalori, oltre che la parabola biografica di un rapporto di sangue. Angela è difficile da intrappolare e impossibile da neutralizzare, perché non tace mai e sgomita per deformare la realtà. Il suo dominio è lo spazio domestico – prima a Napoli e poi a Milano, dove segue due dei suoi figli ormai diventati adultissimi – ma il dove la si piazzi conta poco, perché Angela è impermeabile al mondo, alle opinioni altrui, all’italiano e alla temperanza.

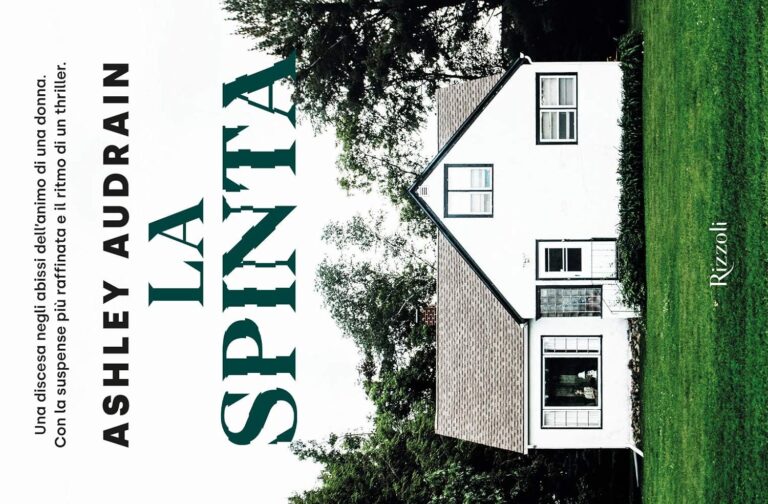
 Blythe è il prodotto di una dinastia di madri che la società civile disapproverebbe. È sopravvissuta a un’infanzia infelice e al rifiuto costante, senza avere gli strumenti “anagrafici” necessari per decodificare i patimenti delle donne della sua famiglia. All’università conosce un ragazzo e, per la prima volta, riesce a immaginare un futuro tollerabile – anzi, un futuro felice. Sono innamorati, lui è convinto che in lei si nasconda una madre meravigliosa e lei ha un gran bisogno di crederci, di meritarsi questa vasta fiducia. Nasce Violet, ma Blythe ci capisce poco. Si ritrova inchiodata a casa – è Fox che lavora mentre lei prova a dedicarsi alla scrittura – con una neonata che pare richiedere più di quanto lei possa ragionevolmente darle. Nulla di quanto aveva immaginato trova specchio nella quotidianità con Violet, ma mostrarsi capace e padrona della situazione, dar prova di essere degna di quell’immagine di madre esemplare così cara al marito ha il sopravvento sulla realtà dei fatti. Chissà, magari Blythe esagera. Magari è lei che non ci sta dentro. Violet non sarà mica così terribile, dai. Perché la devi sempre dipingere a tinte così fosche? Verrebbe quasi da pensare che non le vuoi bene… ma sarebbe una mostruosità bella e buona. Sei un mostro, Blythe?
Blythe è il prodotto di una dinastia di madri che la società civile disapproverebbe. È sopravvissuta a un’infanzia infelice e al rifiuto costante, senza avere gli strumenti “anagrafici” necessari per decodificare i patimenti delle donne della sua famiglia. All’università conosce un ragazzo e, per la prima volta, riesce a immaginare un futuro tollerabile – anzi, un futuro felice. Sono innamorati, lui è convinto che in lei si nasconda una madre meravigliosa e lei ha un gran bisogno di crederci, di meritarsi questa vasta fiducia. Nasce Violet, ma Blythe ci capisce poco. Si ritrova inchiodata a casa – è Fox che lavora mentre lei prova a dedicarsi alla scrittura – con una neonata che pare richiedere più di quanto lei possa ragionevolmente darle. Nulla di quanto aveva immaginato trova specchio nella quotidianità con Violet, ma mostrarsi capace e padrona della situazione, dar prova di essere degna di quell’immagine di madre esemplare così cara al marito ha il sopravvento sulla realtà dei fatti. Chissà, magari Blythe esagera. Magari è lei che non ci sta dentro. Violet non sarà mica così terribile, dai. Perché la devi sempre dipingere a tinte così fosche? Verrebbe quasi da pensare che non le vuoi bene… ma sarebbe una mostruosità bella e buona. Sei un mostro, Blythe?

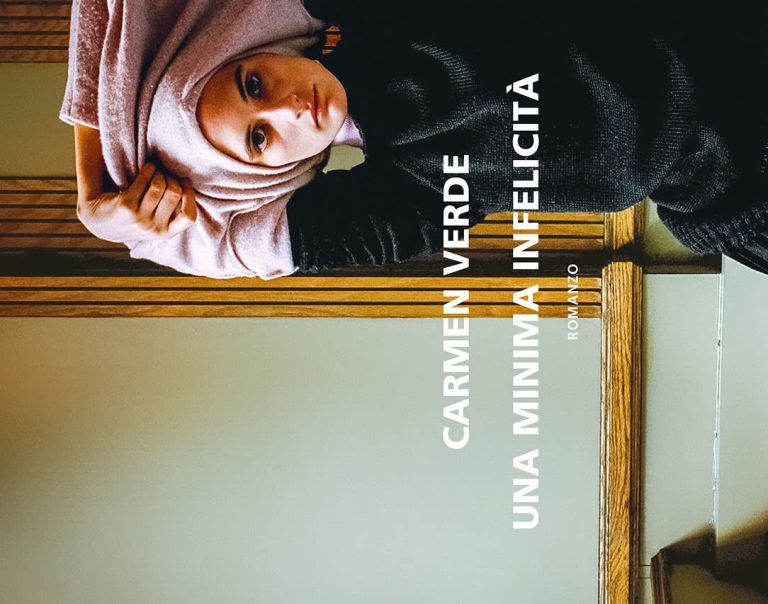
 Ogni famiglia è infelice a modo suo, abbiamo collettivamente metabolizzato.
Ogni famiglia è infelice a modo suo, abbiamo collettivamente metabolizzato. 
 Il nostro punto di vista è quello di Michela, ex cardiochirurga di sopraffino talento che ora fa la mamma quasi a tempo pieno e deve gestire sostanzialmente per conto suo – perché suo marito Aurelio è ancora un medico impegnatissimo – una figlia protoadolescente “difficile”. Leggiamo quello che Michela sceglie di affidare a una specie di diario scritto per la madre, ormai scomparsa da una quindicina d’anni ma ancora ben viva nella memoria e snodo fondamentale della vicenda.
Il nostro punto di vista è quello di Michela, ex cardiochirurga di sopraffino talento che ora fa la mamma quasi a tempo pieno e deve gestire sostanzialmente per conto suo – perché suo marito Aurelio è ancora un medico impegnatissimo – una figlia protoadolescente “difficile”. Leggiamo quello che Michela sceglie di affidare a una specie di diario scritto per la madre, ormai scomparsa da una quindicina d’anni ma ancora ben viva nella memoria e snodo fondamentale della vicenda.
 Partirei con un piccolo cappello introduttivo da ascoltatrice dell’audiolibro – se vi interessa sentirlo,
Partirei con un piccolo cappello introduttivo da ascoltatrice dell’audiolibro – se vi interessa sentirlo, 
 Il problema con le due estremizzazioni non è di poco conto. Le narrazioni che te la mettono giù dura tendono a far venire a galla il brutto, lo sporco, l’emotivamente disturbante e il difficile. Per quanto tutto ciò possa rispondere a verità, sono inevitabilmente respingenti. Le tribolazioni altrui, soprattutto in tema di maternità, scatenano i sensi di colpa, innescano una reazione di difesa che porta all’istante a dichiarare che tu no, tu non sei mica un mostro del genere. Perché? Perché la “madre” non è un concetto neutro. Anzi, è uno dei concetti più connotati e più zavorrati dalle aspettative collettive. Sguazziamo in uno stereotipo resistentissimo che stabilisce come dovrebbe essere una “buona madre” – e poco importa se lo stereotipo sia datato, figlio prediletto di una cultura che santifica la donna solo se fa la madre (e basta) e assolutamente scollato dalla realtà socioeconomica che abitiamo. Il fatto è che esiste anche quello che ci spaventa. Esistono anche situazioni che non ci somigliano o nelle quali preferiremmo non ritrovarci. Il fatto che una narrazione sia respingente – secondo certi canoni o private sensibilità – non la rende meno autentica o meno degna di essere ascoltata, capita, accolta. Non è che leggendo un’esperienza “negativa” della maternità e prestando orecchio anche alle campane meno entusiastiche ci si esponga a un qualche genere di contagio. Non è che empatizzando con chi ha avuto una partenza in salita – o con chi continua ad arrancare – finiremo per sabotarci. Chiaro, poi… quello che scegliamo di incamerare nelle nostre riflessioni risponde anche a un bisogno, a una ricerca di senso che può portarci a cercare conforto in peripezie simili alle nostre o a trovare quello che ci serve in racconti più spensierati, più edulcorati, più “positivi”. Ed eccoci arrivati al polo opposto.
Il problema con le due estremizzazioni non è di poco conto. Le narrazioni che te la mettono giù dura tendono a far venire a galla il brutto, lo sporco, l’emotivamente disturbante e il difficile. Per quanto tutto ciò possa rispondere a verità, sono inevitabilmente respingenti. Le tribolazioni altrui, soprattutto in tema di maternità, scatenano i sensi di colpa, innescano una reazione di difesa che porta all’istante a dichiarare che tu no, tu non sei mica un mostro del genere. Perché? Perché la “madre” non è un concetto neutro. Anzi, è uno dei concetti più connotati e più zavorrati dalle aspettative collettive. Sguazziamo in uno stereotipo resistentissimo che stabilisce come dovrebbe essere una “buona madre” – e poco importa se lo stereotipo sia datato, figlio prediletto di una cultura che santifica la donna solo se fa la madre (e basta) e assolutamente scollato dalla realtà socioeconomica che abitiamo. Il fatto è che esiste anche quello che ci spaventa. Esistono anche situazioni che non ci somigliano o nelle quali preferiremmo non ritrovarci. Il fatto che una narrazione sia respingente – secondo certi canoni o private sensibilità – non la rende meno autentica o meno degna di essere ascoltata, capita, accolta. Non è che leggendo un’esperienza “negativa” della maternità e prestando orecchio anche alle campane meno entusiastiche ci si esponga a un qualche genere di contagio. Non è che empatizzando con chi ha avuto una partenza in salita – o con chi continua ad arrancare – finiremo per sabotarci. Chiaro, poi… quello che scegliamo di incamerare nelle nostre riflessioni risponde anche a un bisogno, a una ricerca di senso che può portarci a cercare conforto in peripezie simili alle nostre o a trovare quello che ci serve in racconti più spensierati, più edulcorati, più “positivi”. Ed eccoci arrivati al polo opposto.