Ho senz’altro letto più cose a tema maternità dopo l’abbondante conclusione delle mie gravidanze che nella fascia di caotica necessità di capirci qualcosa che coincide con l’incubazione. Possiamo pure dire che, da gravida, non ho letto niente e che, anche dopo, ci ho messo degli anni a razionalizzare davvero un’infinità di aspetti dell’esperienza fisica, emotiva, pratica e relazionale della maternità. Di certo, mi sembra di essere più capace di “capire” ora, ma dipende anche un po’ dall’arrivo sulla scena di un genere di saggistica che non ha l’obiettivo di spiegarci come si gestisce un neonato ma, invece, sposta il fuoco sull’esperienza delle madri, in un contesto contemporaneo.

Il fatto che i manuali che sperano di risolverci le rogne della nanna, della pappa, dell’allattamento e dello spannolinamento siano andati statisticamente per la maggiore è (anche) il prodotto di un grande vuoto d’interesse, che comincia a concretizzarsi appena un neonato abbandona la pancia per affacciarsi al mondo. Le madri, che per nove mesi sono state monitorate, misurate, analizzate e “gestite” si trasformano repentinamente in soggetti che devono assolvere una serie di funzioni, senza però essere accompagnate da un sistema di cura altrettanto strutturato e imperativo. Per Matrescenza – in libreria per Laterza con la traduzione di Alessandra Castellazzi – Lucy Jones parte proprio da qui, da quel vuoto di studi, attenzioni cliniche e psicologiche e dalle lacune nella sostenibilità della vita quotidiana che accompagna le neo-madri, che sembrano spesso armarsi e partire per conto loro in una missione campale.
Il termine “matrescenza” ha qui il compito di descrivere il periodo – in realtà ben più lungo e articolato di una gravidanza – in cui una donna si assesta nella nuova condizione di madre. Jones, che di lavoro fa la giornalista scientifica, unisce alla sua esperienza (ha avuto tre figli) un ricchissimo sistema di fonti capaci di rendere meno opaco e meno trascurabile questo momento di passaggio. Dagli studi neuroscientifici alle lacune nell’informazione delle gestanti, dagli sforzi per affrontare (o renderci consapevoli) degli strascichi fisici del parto alla necessità di un approccio privo di stigma al sostegno psicologico, Jones parla di corpo per parlare di identità, autonomia, sicurezza, benessere, mente, medicina, legami, lavoro e società.
Chissà, probabilmente da gravida non avrei letto nemmeno questo libro, ma il fatto che adesso ci sia mi fa ben sperare. E finalmente, forse, ho qualcosa da consigliare a chi mi chiede spessissimo “sono incinta! Cosa leggo per prepararmi?”. Magari qualcosa di rigoroso e ben documentato che ti ricordi che continuerai a esistere anche tu, amica.

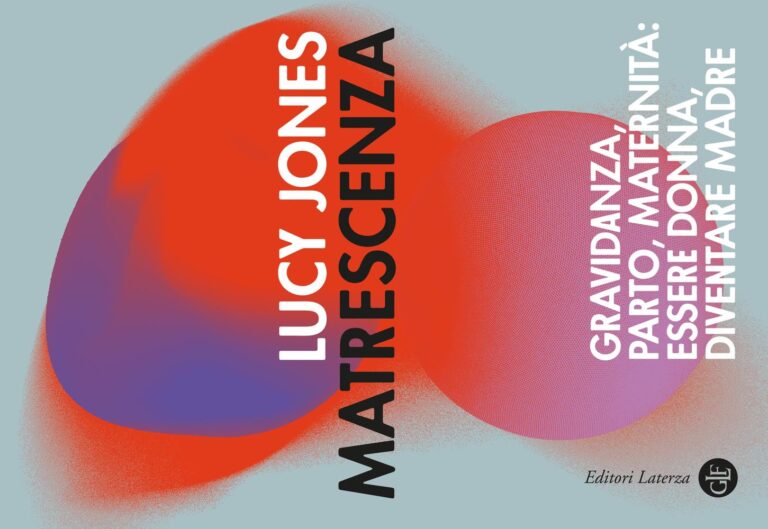
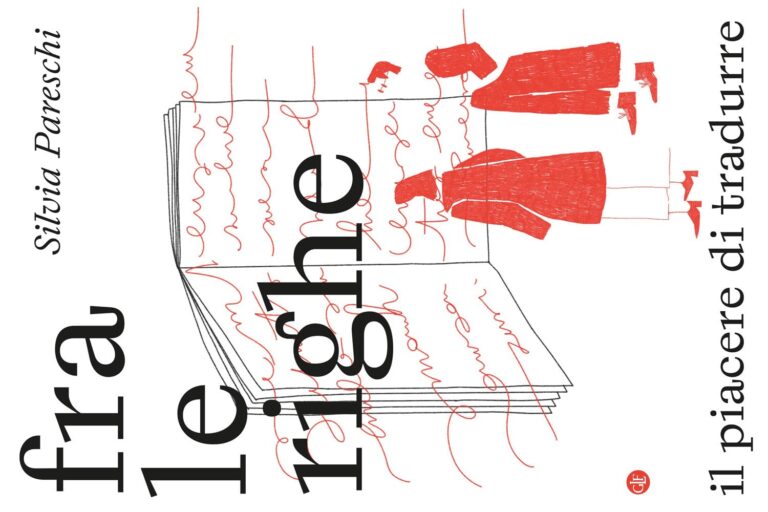
 Tra autobiografia professionale e collezione di dilemmi (risoltissimi), Pareschi condensa in
Tra autobiografia professionale e collezione di dilemmi (risoltissimi), Pareschi condensa in 
 Quante delle usanze che diamo per assodatissime sono in realtà costrutti sociali o “riti” relativamente recenti? Non so stilare un elenco completo, ma fra queste lente sedimentazioni storiche c’è senz’altro la misurazione del tempo che trascorre secondo scansioni convenzionali/condivise e l’abitudine di festeggiare il compleanno, considerandolo sia come una ricorrenza o un giorno “speciale” che come rigoroso traguardo periodico che ci consente di dichiarare con precisione la nostra età anagrafica.
Quante delle usanze che diamo per assodatissime sono in realtà costrutti sociali o “riti” relativamente recenti? Non so stilare un elenco completo, ma fra queste lente sedimentazioni storiche c’è senz’altro la misurazione del tempo che trascorre secondo scansioni convenzionali/condivise e l’abitudine di festeggiare il compleanno, considerandolo sia come una ricorrenza o un giorno “speciale” che come rigoroso traguardo periodico che ci consente di dichiarare con precisione la nostra età anagrafica.