Orbital di Samantha Harvey ha vinto il Booker Prize 2024 ed è stato accolto da una generalizzata meraviglia da parte di stampa e critica. In italiano ha trovato casa da NN Editore, con la traduzione di Gioia Guerzoni. Io, che sui premi internazionali tendo a essere più reattiva che sui riconoscimenti nostrani, l’ho letto in inglese perché ero curiosa. Ci possiamo fidare ciecamente di Gioia? Direi di sì.
 È un libro di indubbia originalità e peculiare esecuzione. Relativamente breve ma a suo modo densissimo, è un esperimento narrativo che si svolge per intero a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nell’arco di sedici orbite attorno al nostro pianeta. Perché proprio sedici? Perché quello è il “percorso” normale e quotidiano della stazione nell’arco di 24 ore.
È un libro di indubbia originalità e peculiare esecuzione. Relativamente breve ma a suo modo densissimo, è un esperimento narrativo che si svolge per intero a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nell’arco di sedici orbite attorno al nostro pianeta. Perché proprio sedici? Perché quello è il “percorso” normale e quotidiano della stazione nell’arco di 24 ore.
E che succede? Quasi niente.
L’equipaggio, composto da sei astronauti di provenienze terrestri differenti, lavora, mangia, dorme, pulisce, svolge esperimenti, fa manutenzione, fluttua, scatta fotografie.
La vita pratica che Harvey riproduce è fatta di routine ferree, indispensabili al buon funzionamento di un microcosmo d’intricatissima complessità e delicatezza, e di pensieri sospesi, di contemplazione rarefatta e di serie sempre identiche di incombenze parcellizzate. Le missioni durano mesi e chi arriva a farne parte – rispondendo a vocazioni viscerali – si trasforma in un ingranaggio della macchina e al contempo la modifica: ogni equipaggio diventa un organismo unico e irripetibile, fatto di pezzi meccanici e di anime in viaggio, di dati e di legami. Chi ci accompagna per queste sedici orbite finisce per ricoprire un ruolo dichiarato, negli spazi angusti della stazione. Anton è il cuore, Pietro è la mente, Roman è il braccio, Shaun è lo spirito, Chie è la coscienza, Nell è il respiro. La stazione procede imperterrita con loro nelle viscere, imprigionandoli e proteggendoli e, soprattutto, collocandoli in una posizione rara. Nessuno vive in pianta stabile così lontano dalla superficie del pianeta, nessuno esperisce il medesimo stato di sospensione – il moto orbitale è, tecnicamente, una caduta libera che raggiunge un punto d’equilibrio -, nessuno vede sorgere la Luna e il Sole così spesso. La Terra è un grande spettacolo che sfiora l’astratto e che evoca interrogativi incessanti, la stazione è un’impresa umana assurda e fragile. Che la vita perseveri, in entrambi i posti, è l’ultimo dei miracoli.

Harvey vi proporrà a ciclo continuo descrizioni liriche di quel che si può ammirare dagli oblò – fan della geografia, ve ne rallegrerete – e l’impasto dei pensieri e dei ricordi dell’equipaggio. Tre eventi emergeranno per ancorare gli astronauti al resto degli accidenti umani: un tornado mastodontico da monitorare, una persona cara che muore, un’altra missione che rende quasi puerile il movimento circolare della stazione. Saranno tre sterzate potenti? No, perché in questo romanzo – e nel come sceglie di raccontarci la vita umana in un contesto così unico – le proporzioni non funzionano come le intendiamo noi. E nemmeno il tempo, le distanze, i legami. Verremo a tratti investiti da un tedio infinito e sorpresi un istante dopo da un’illuminazione improvvisa, ci convinceremo di essere troppo insignificanti per mutare il corso delle cose e ci sentiremo, immediatamente dopo, paralizzati dall’immensa fortuna di esistere. È un libro strano: pesantissimo e incorporeo, claustrofobico ma vasto. Funziona, forse, come la forza di gravità su un essere umano che diventa un astronauta: il corpo smette di avere peso, mentre il cervello continua a gestirlo come se ci fosse ancora qualcosa che fa resistenza, che ti tira giù verso il suolo e ti obbliga a sapere sempre dov’è l’alto e dov’è il basso.

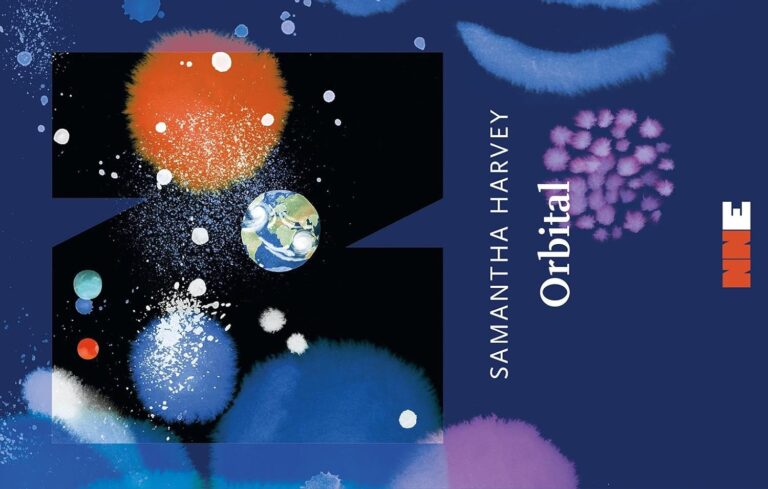
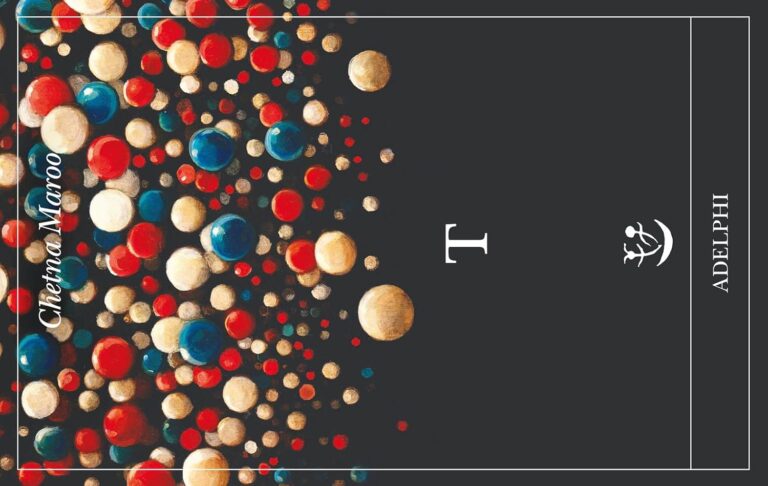
 Gopi e le sue sorelle hanno perso la mamma e si ritrovano per allenarsi, un giorno dopo l’altro, sotto l’occhio spento del padre su un campetto alla periferia di Londra. Farle giocare è l’unica cosa che sembra aiutarlo a tenersi a galla e loro lo assecondano, insieme e solissime, colpendo palle a ripetizione nella speranza di ritrovare il ritmo della normalità… o di lasciarsi ipnotizzare. C’è molto di meccanico, negli sport che si fanno con la racchetta, ma esiste uno specifico stato di felice straniamento che si innesca quando ti abbandoni all’automatismo. Si diventa fluidi, si diventa leggeri, ci si dimentica di sé, si fa tutto il giro e forse ci si ritrova.
Gopi e le sue sorelle hanno perso la mamma e si ritrovano per allenarsi, un giorno dopo l’altro, sotto l’occhio spento del padre su un campetto alla periferia di Londra. Farle giocare è l’unica cosa che sembra aiutarlo a tenersi a galla e loro lo assecondano, insieme e solissime, colpendo palle a ripetizione nella speranza di ritrovare il ritmo della normalità… o di lasciarsi ipnotizzare. C’è molto di meccanico, negli sport che si fanno con la racchetta, ma esiste uno specifico stato di felice straniamento che si innesca quando ti abbandoni all’automatismo. Si diventa fluidi, si diventa leggeri, ci si dimentica di sé, si fa tutto il giro e forse ci si ritrova.