
Paolo Nori è un felice esempio di come un libro si possa leggere volentieri e ascoltare ancora più volentieri. Allo stesso tempo, è inaccettabile che qualcuno che non è Nori legga Nori, secondo me. Cioè, ci può provare, ma verrà fuori una roba dissonante, depotenziata, loffia. Ma Nori, credo, è capace di leggere anche gli altri. Li trasforma e se li porta vicini, come se non ci fosse una riga al mondo che non lo riguarda. È proprio bello incontrare, di tanto in tanto, qualcuno che sembra aver imbroccato una vocazione. Il come sia accaduto, in mezzo a mille altre cose, è una delle tante ossa di Chiudo la porta e urlo – in libreria per Mondadori e anche ascoltabile su Storytel.
È un romanzo, in teoria, che vuole raccontarci chi è stato Raffaello Baldini, un poeta di Santarcangelo di Romagna che abitava a Milano e scriveva nel suo dialetto, traducendosi da solo in italiano e parlando di gente solitaria e matta che gravitava solo su Santarcangelo. Nori ci legge Baldini e ci legge anche tutto quello che succede mentre si vive, si scrive, ci si pianta e ci si rimane male quando disgraziatamente si fa bella figura.
Ogni volta che leggo o ascolto Nori ho la sensazione nettissima di non aver solo letto qualcosa, ma di aver passato del tempo insieme a una persona. A me piace, che Nori ci tiri dentro ai fatti suoi, che ci porti a presentazioni e discorsi e nei libri che sta traducendo o che ama da quando ha scoperto che era il caso di studiare la letteratura russa. Non mi convincerà ad andare a correre perché noi di Piacenza qualche riserva verso un’esortazione che ci arriva da Parma la dobbiamo comunque avere, ma sentirlo parlare di dialetti e delle città piccole – che magari non ti mangiano come le grandi e son sempre casa tua, anche se scappi – è una specie di riconciliazione. Non so se quest’anno vincerà IL GRANDE PREMIO, ma mi viene da dirgli che è andata a meraviglia già così.




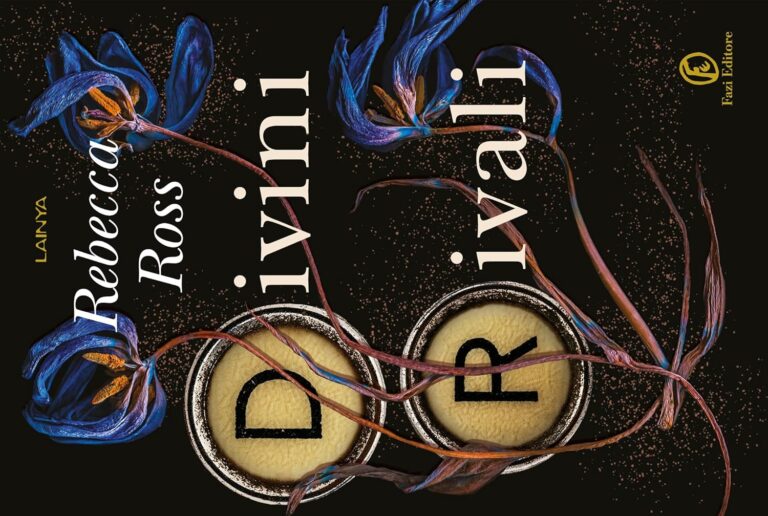



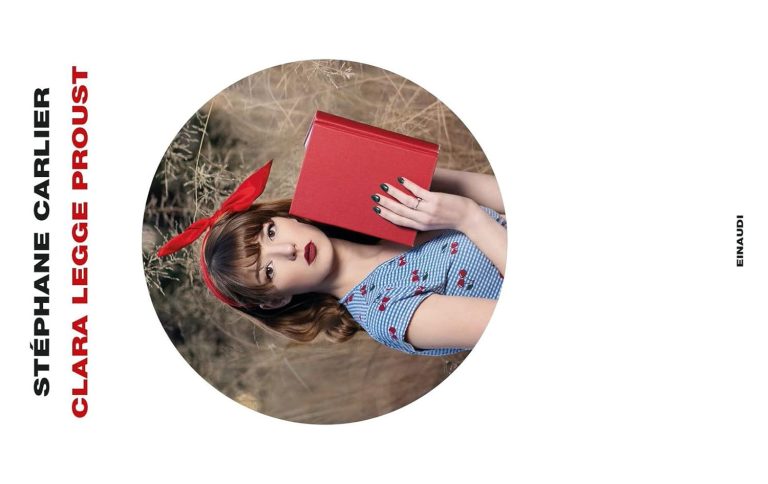
 Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust.
Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust. 


 Il nostro punto di vista è quello di Michela, ex cardiochirurga di sopraffino talento che ora fa la mamma quasi a tempo pieno e deve gestire sostanzialmente per conto suo – perché suo marito Aurelio è ancora un medico impegnatissimo – una figlia protoadolescente “difficile”. Leggiamo quello che Michela sceglie di affidare a una specie di diario scritto per la madre, ormai scomparsa da una quindicina d’anni ma ancora ben viva nella memoria e snodo fondamentale della vicenda.
Il nostro punto di vista è quello di Michela, ex cardiochirurga di sopraffino talento che ora fa la mamma quasi a tempo pieno e deve gestire sostanzialmente per conto suo – perché suo marito Aurelio è ancora un medico impegnatissimo – una figlia protoadolescente “difficile”. Leggiamo quello che Michela sceglie di affidare a una specie di diario scritto per la madre, ormai scomparsa da una quindicina d’anni ma ancora ben viva nella memoria e snodo fondamentale della vicenda.
 Claudia e Francesco condividono un legame antico. Un po’ dipende dalla fascinazione di lui e un po’ dalle circostanze: la madre di Francesco e il padre di Claudia sono amanti. Quando, ancora ragazzini, si trovano a dover imparare a convivere con questa realtà parallela – che sgretola famiglie “ufficiali” ma spalanca uno spazio di sentimento libero, nonostante tutto – diventano un punto di riferimento l’una per l’altro. In comune hanno più di quanto si potrebbe sospettare e, negli anni, nemmeno la distanza li separerà, perché quello che davvero li fonde è l’essere perennemente spostati rispetto al contesto a cui appartengono.
Claudia e Francesco condividono un legame antico. Un po’ dipende dalla fascinazione di lui e un po’ dalle circostanze: la madre di Francesco e il padre di Claudia sono amanti. Quando, ancora ragazzini, si trovano a dover imparare a convivere con questa realtà parallela – che sgretola famiglie “ufficiali” ma spalanca uno spazio di sentimento libero, nonostante tutto – diventano un punto di riferimento l’una per l’altro. In comune hanno più di quanto si potrebbe sospettare e, negli anni, nemmeno la distanza li separerà, perché quello che davvero li fonde è l’essere perennemente spostati rispetto al contesto a cui appartengono.
 Dunque, sono sempre molto avvinta dai libri che usano la struttura come un elemento “strategico” che contribuisce a costruire la narrazione. In
Dunque, sono sempre molto avvinta dai libri che usano la struttura come un elemento “strategico” che contribuisce a costruire la narrazione. In