Parlare di come è strutturato questo libro credo produca più disservizi che chiarezza. Lidia Yukanavitch sceglie la metafora dell’acqua proprio per lasciar scorrere i ricordi, creare gorghi, lanciarci giù per una cascata o imprigionarci nella fanghiglia stagnante dei momenti più cupi. La struttura che sceglie – o da cui si fa trasportare – è fluida come la memoria, deformata dalle rifrazioni della luce e condizionata dalla profondità degli eventi che man mano riguadagnano la superficie.

Insomma, La cronologia dell’acqua – in libreria per Nottetempo con la traduzione di Alessandra Castellazzi – diventa lineare solo dopo averne preso le distanze e dopo averlo considerato “tutto insieme”. E mentre si legge ci si aggrappa a quello che fluttua. Ci aggrapperemo a bottiglie vuote, a mostri sacri della letteratura, a mariti perduti, a percorsi accademici tortuosi, a elaborati sex-toy, a una bicicletta nuova, a una collezione di ciocche di capelli… tutti questi detriti viaggiano verso alcune isole “stabili” che ospitano dolori imperdonabili, incorreggibili.
Grossolanamente, potremmo dire che la storia di Yukanavitch è quella di una bambina cresciuta in una famiglia disfuzionalissima e violenta. Di un precoce prodigio del nuoto che non ha mai raggiunto orizzonti eclatanti. Di un corpo portato al limite e consegnato a un disordine vertiginoso. Di una ricerca per spogliare la lingua e la scrittura dal gesso dell’accettabilità e del garbo. Di una madre che perde la sua bambina e sceglie di non rimettere insieme i pezzi.
Pare la cronaca di quel che resta all’indomani di un susseguirsi di disastri naturali, se là fuori esistessero disastri naturali circoscrivibili a una singola persona. C’è il trauma come tema portante – già, anche qui… ben giunte e ben giunti nella Grande Era del Trauma Letterario, movimento collettivo che ha forse contribuito a mantenere vivo e a costruire un ulteriore seguito per un libro originariamente pubblicato nel 2011 -, ma c’è anche una grande vitalità rabbiosa, una volontà di persistere che non sfida tanto le circostanze avverse o il destino, ma diventa sfida contro il proprio stesso buio.
Non è un libro gradevole da leggere, penso. Ha guizzi di grazia estrema e frequentissime ruvidità. Le parti legate al sesso e alle dipendenze non sono particolarmente scioccanti, secondo me – per quanto trattate con esplicita disinvoltura -, ma credo risultino depotenziate dalla nostra ormai crescente assuefazione al tema. E la scrittura che viene a galla in questi capitoli m’è parsa molto didascalica, molto apparecchiata per ottenere un effetto, molto più banale dell’auspicato. L’aspetto positivo è che in questo libro ci sono così tante Yukanavitch che di rado si rimane ancorati a un unico vascello espressivo e ci sta che le pulsioni più incontenibili vengano descritte col metro espressivo che corrisponde a un tempo preciso, che si tratti di adolescenza o di qualsiasi altro momento di violenta liberazione.
Non so se La cronologia dell’acqua abbia voglia di sottoporsi a un “mi è piaciuto”/”non mi è piaciuto”. Ha davvero poco senso domandarselo. É un libro tremendo, crudo, violento. Ma è un libro che persiste e ci riconcilia con i mostri, i rancori, le furie irrimediabili, gli abbandoni e le sconfitte. Fa speranza anche quando fa più schifo. Prova a fare arte per mostrarci come far crescere una pelle nuova. Prova a raccontare che si può ambire alla felicità anche se ci sentiremo per sempre danneggiati. Prova a descriverci uno spazio eterno – liquido – di trasformazione.



 Dalla gestione domestica all’organizzazione della famiglia, dai compiti di “cura” alle operazioni basilari e ripetitive che garantiscono il buon funzionamento di una casa, con
Dalla gestione domestica all’organizzazione della famiglia, dai compiti di “cura” alle operazioni basilari e ripetitive che garantiscono il buon funzionamento di una casa, con 
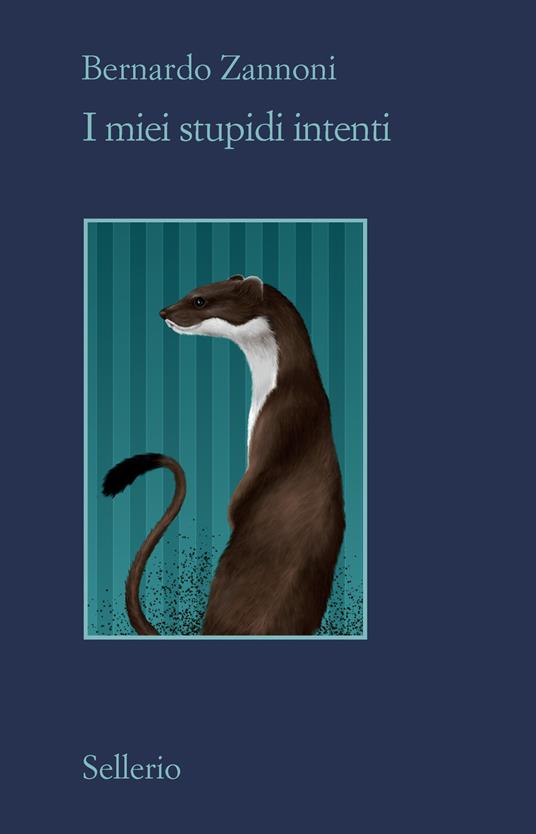 Ho deciso che il modo più efficace per provare
Ho deciso che il modo più efficace per provare




 I racconti
I racconti




 Partirei con un piccolo cappello introduttivo da ascoltatrice dell’audiolibro – se vi interessa sentirlo,
Partirei con un piccolo cappello introduttivo da ascoltatrice dell’audiolibro – se vi interessa sentirlo, 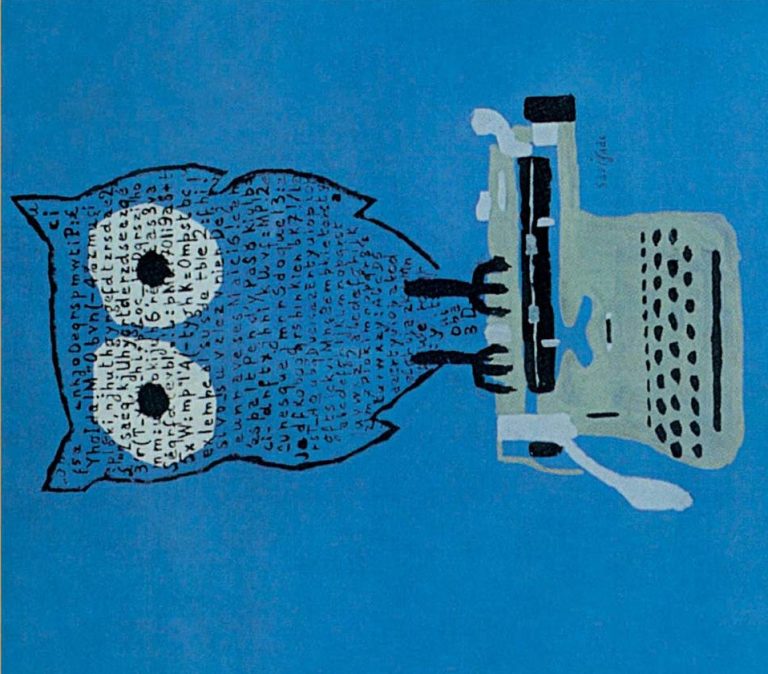

 [Bonus track: un capitolo è dedicato a Norstein e al suo lavoro geniale, che si sviluppa in una sorta di mondo parallelo immune dalle scadenze ma tristemente soggetto alle necessità materiali.
[Bonus track: un capitolo è dedicato a Norstein e al suo lavoro geniale, che si sviluppa in una sorta di mondo parallelo immune dalle scadenze ma tristemente soggetto alle necessità materiali.