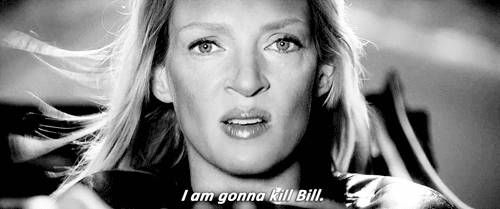Sono arrivata alla conclusione che le feste di compleanno sono necessarie perché solo buttando in piedi una gran caciara si riesce vagamente a seppellire la tristezza fisiologica che ti assale quel giorno lì. Amici, parenti, congiunti, figuranti stipendiati o anche solo semplici anziani che osservano le celebrazioni in corso. Torte giganti. Canzoni. Bevande alcoliche. Doni, pacchetti, regali, roba nuova. Plateali dimostrazioni di gioia, parate, Frecce Tricolori. Beyoncé.
Io lo so che dovrei mettere in pratica questa strategia. Ci penso tutti gli anni – o, almeno da quando ho smesso di compierli volentieri. Ma poi non lo faccio mai. Ma no, ormai è tardi per invitare. Ma no, non c’è abbastanza spazio. Ma no, non ho preparato niente. Ma no, che con Cesare in mezzo alla confusione facciamo fatica. Ma no, mettono pioggia.
Quand’è che ho smesso di compiere gli anni volentieri, però?
Dopo i 25, credo.
Che per me è anche stato un po’ il momento in cui mi è sembrato di non avere più di fronte un futuro fatto ancora di potenzialità vaste e assolute, ma una sorta di destino già parzialmente scritto. Ma non perché ci sia, chissà dove, una qualche divinità che trascorre le sue giornate a tessere il fato di ogni singolo essere umano del pianeta. Ma perché col passare del tempo accumuliamo scelte e decisioni che, a cascata, producono delle conseguenze più o meno ragionevoli, auspicabili o prevedibili. E che ci fanno avanzare in una certa direzione, sbarrandoci altre strade.
Cresci – se sei fortunata e magari già un po’ propensa a fottertene dei ruoli che l’universo potrebbe appiccicarti addosso – con l’idea di poter fare quel che ti pare, di poter diventare tutto. E, visto che nel TUTTO c’è tutto, c’è anche quello che vorresti essere, ci sono i tuoi desideri. Per forza. Magari non ti sono ancora chiari, questi desideri, ma sai di avere a disposizione un ventaglio di aspirazioni. E il cosa sei, prima o poi, ti apparirà. E sarà lì a portata di mano.
Ecco.
Il tempo che passa, però, fa cambiare forma al tuo ventaglio. Lo modifica.
Magari diventi più capace di distinguere i tuoi talenti dalla roba che ti riesce malissimo. E ripieghi uno spicchio, accantonando qualcosa. Magari sai già che una certa facoltà universitaria sarebbe favolosa per te, ma poi tuo cugino ti ride in faccia alla cena di Natale e ti viene da cambiare idea. E ti iscrivi da un’altra parte, perché è una facoltà “utile”. Nessuno ride più, questa volta, ma ripieghi un altro spicchio. Magari ci metti un qualche anno a identificare le tue aspirazioni. Ed esplori qualche spicchio per accertarti della sua solidità o per accantonarlo con più sicurezza. Ti piace un tizio e state molto bene insieme. Ma lui è lontano e non si può spostare. E tu hai appena iniziato un nuovo lavoro e nemmeno a te pare di poter cambiare città. E salutiamo un altro spicchio.
Mamma mia, leggere 4321. Che toccasana.
Comunque.
Non è detto che ripiegare spicchi sia un male. Di tante cose è meglio liberarsi. Ed è anche molto complicato trascorrere la vita dribblando decisioni, per la paura di ritrovarsi con un ventaglio chiuso in mano. Ma accorgersi, a un certo punto, che fare retromarcia è difficoltoso e che la quantità di spicchi che possiamo giocarci è diventata un pochino meno fantasmagorica non è rassicurantissimo. Ti viene in mente che forse hai sbagliato. Che era troppo presto o troppo tardi. Che hai sprecato delle opportunità. Che non sei mai dove dovresti essere. Che sei troppo grande per cambiare idea. E il futuro comincia a somigliare a un puntino, invece che a un vasto orizzonte illuminato da un sole sfavillante. E l’unica differenza che percepisci è che hai un anno in più, ma di miracoli non ne hai combinati. E non sei molto fiduciosa sulla possibilità di combinarne in futuro, visto l’andazzo.
Perché, SI SA, è il futuro a fare ansia.
E il passato? Quello è il magazzino per la roba di cui ci rimproveriamo.
E il presente serve a pensare alle stronzate del passato e ad attendere che il futuro ci riservi dei miglioramenti.
Credo di aver preso una nuova decisione: mi sono rotta le balle di questo schema. Sarà che, per quanto malvolentieri io compia gli anni, gli ultimi anni che ho compiuto mi hanno dato ben poche occasioni di rimpianto, recriminazione e ripensamento. Sarà che ho imparato molto più di quello che ho perso per strada, per quanto faticosi siano stati alcuni momenti. Sarà che mi sento immancabilmente sostenuta dagli abitanti grandi e piccoli di questa casa – e anche da chi, superando filtri più o meno accentuati, riesce comunque a farmi arrivare numerosi buffettini di incoraggiamento.
Forse il nocciolo della questione non è tanto il tempo che passa, ma un po’ come lo misuri e come scegli di percepirlo.
Perché è pacifico che in un anno ci siano 365 giorni, ma quello che mi viene da prendere in considerazione – quando ripenso a quello che ho combinato – è il dov’ero e il cosa facevo, o le persone che vedevo in un determinato periodo, o quanto mi sentissi saggia o scema. Preferisco pensarmi a capitoli, che per precise demarcazioni temporali. Preferisco misurare i traguardi o prendere atto delle battute d’arresto che sentirmi “vecchia” o “giovane”. E credo sia meglio investire le mie energie nel decidere qualcosa con il cuore e con la testa – accettando l’imponderabile ma provando a fare tutto il possibile per ottimizzare le risorse che abbiamo disposizione – che spaventarmi per i ventagli che si ripiegano.
Perché tutto è migliorabile, tutto potrebbe essere fatto “meglio” o andare meglio – ovviamente. Si può sempre ambire ad essere un po’ più felici. Ma se devo farmi schiacciare da questa sensazione di non essere ancora riuscita a fare abbastanza, se devo perennemente proiettarmi verso chissà che cosa, partirò sempre da più lontano. Perché non ci sarà mai un presente che sento di padroneggiare, un momento “vivo” in cui potrò decidere di iniziare a cambiare (in meglio) quello che penso di dover cambiare.
È un po’ una forma di auto-deresponsabilizzazione, forse, questo spostare sempre tutto sul futuro. Come se il trascorrere del tempo fosse una garanzia di successo. Il tempo non ci calcola. Non è buono. Non è malevolo. Fa il suo. E siamo noi a raccoglierne e a portarne i segni, nel bene e nel male. E temo tocchi un po’ a noi capire che nessuno farà il lavoro necessario al posto nostro. O che il bello che ci stiamo perdendo – nel nome di un “migliore” ipotetico che non è detto che apparirà mai – non tornerà a farci visita. Non con la meraviglia della prima volta, almeno.
E niente, ho 33 anni.
E non ho ancora trovato il modo di ricordarmi com’è che si compiono volentieri.
E ho un ventaglio che è quello che è, perché è lo specchio di un viaggio fatto di tante decisioni, felicità, cretinate, miracoli, sciatterie, scoperte e tentativi. È roba mia. Forse è pure a pois. Non so cosa ne sarà degli spicchi che posso ancora scegliere di esplorare – ma ho deciso di cominciare a usarlo strada facendo, proprio nel modo in cui un ventaglio andrebbe sensatamente utilizzato. Farò quello che posso e proverò ad avvicinarmi a quello che non posso fare. E, nel frattempo, col ventaglio mi ci voglio sventolare.