
Dunque, ci sono delle signore di un sobborgo-bene di Charleston che bidonano un bookclub pretenzioso per fondarne uno “specializzato” lì per lì in true-crime, delitti efferati, cronaca nera e grandi misteri americani. Sono amiche, hanno tutte una manciata di figli a testa, dei mariti che lavorano mentre loro badano al tran tran domestico e delle casone col pratino da curare. Sono immerse in un contesto di “vicinato” a metà tra l’invadenza e l’estrema premura: qui ci vive solo gente come si deve, siamo una grande famiglia, la nostra comunità è genuina e virtuosa. Siamo negli anni ‘90 e Patricia Campbell è afflitta – come le sue amiche – da tutte le migliori intenzioni della Brava Moglie del Sud. Ma cosa succede quando in una comunità così affiatata e unita appare un elemento di rottura – e di potenziale stravolgimento?
Il “corpo estraneo”, per le nostre affiatate lettrici, è un nuovo vicino che arriva nel quartiere per prendersi cura – a suo dire – dell’anziana zia. Sembra un tizio a posto, ma non lo si vede mai in giro di giorno, guida un furgonaccio, pare sprovvisto di documenti, risponde con cordiale evasività (e palesi contraddizioni) a ogni domanda personale e resta sullo zerbino finché non lo si invita esplicitamente a entrare in casa. La suocera invalida di Patricia perde la brocca appena lo vede e sostiene a gran voce di averlo già incontrato da bambina: questo qui è il tizio che ha distrutto le nostre famiglie! Patricia non sa bene cosa pensare: Miss Mary è senza dubbio più di là che di qua, ma tanti altri piccoli incidenti cominciano a verificarsi attorno a James Harris… e forse vale la pena indagare.
Mentre Patricia si esercita a demolire le barriere del suo razionalissimo mondo per confrontarsi con qualcosa che sfida il senso condiviso della realtà, James Harris si guadagna la fiducia di mariti, figli e figlie, semplici passanti, ratti. Nel quartiere afroamericano cominciano a sparire dei bambini, ma nessuno – a parte Patricia e la badante di Miss Mary, che viene da lì – pare scomporsi. I nostri figli stanno bene, no? I ragazzini neri si mettono sempre nei guai, che sarà mai.
In un’alternanza di ipocrisie terrificanti – ma molto rivelatorie -, gaslighting sistematico, problemi strutturali di attendibilità – dovremmo forse dar retta a una casalinga suggestionata dal true-crime? Dove andremo a finire! -, uomini coglioni e foschi presagi, Grady Hendrix apparecchia una storia corale che batte un po’ sempre sugli stessi tasti ma che riesce a intrattenerci bene, insinuando il tarlo del sovrannaturale nella vita placida (e urbanamente meschina) del quartiere.
Peccato per James Harris – che dice poco e credo sia anche l’ipotetico mostro più noioso che mi sia capitato d’incontrare – ma un pollice su per l’abile stratificazione delle inquietudini e del senso di minaccia latente. L’indagine di Patricia non è degna della CIA, ma la dinamica dei personaggi fa il suo dovere e il fatto che le opinioni delle donne vengano sempre trattate con estrema condiscendenza e paternalismo fa arrabbiare, ma è anche il succo della questione.
Sì, qua e là c’è roba schifosa, macabra e splatter. Ma anche pulire la cameretta di un adolescente credo lo sia.
Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe è uscito per Mondadori nella traduzione di Rosa Prencipe, ma si può ascoltare anche su Storytel – come ho fatto io. Per collaudare Storytel con un bel mese gratuito, qua c’è il solito link.
Se volete approfondire le imprese di Hendrix, di suo ho letto anche Horrorstör, una roba mattissima e dal taglio OH CHE PAURA ancor più calcato. Che succede? Tutta la vicenda è ambientata in un megastore di arredamento che molto ricorda un arcinoto colosso svedese. È una via di mezzo tra un’escape-room e una discesa agli inferi ma, in maniera ancor più spiccata, è una riflessione sul consumo, sul capitalismo e sul lavoro come forma di dannazione eterna. Fa ridere, mette angoscia, è una chicca di astuta stranezza.

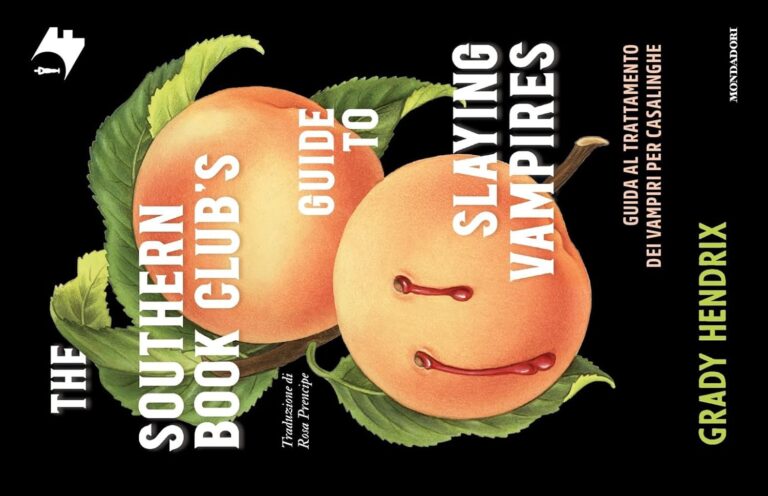
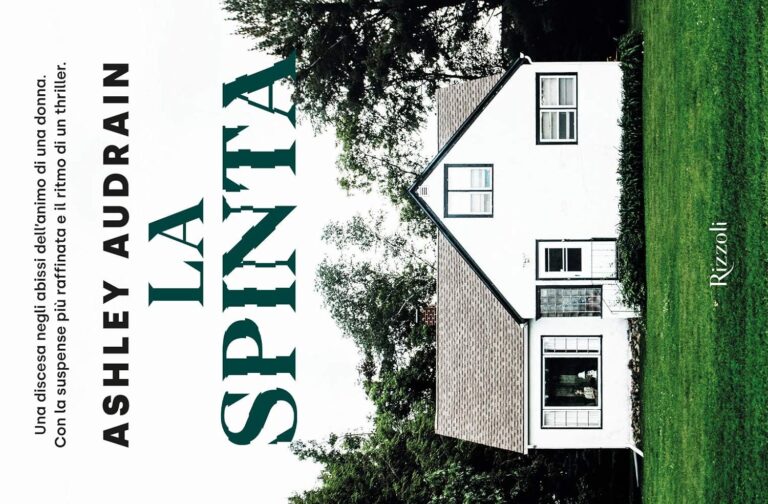
 Blythe è il prodotto di una dinastia di madri che la società civile disapproverebbe. È sopravvissuta a un’infanzia infelice e al rifiuto costante, senza avere gli strumenti “anagrafici” necessari per decodificare i patimenti delle donne della sua famiglia. All’università conosce un ragazzo e, per la prima volta, riesce a immaginare un futuro tollerabile – anzi, un futuro felice. Sono innamorati, lui è convinto che in lei si nasconda una madre meravigliosa e lei ha un gran bisogno di crederci, di meritarsi questa vasta fiducia. Nasce Violet, ma Blythe ci capisce poco. Si ritrova inchiodata a casa – è Fox che lavora mentre lei prova a dedicarsi alla scrittura – con una neonata che pare richiedere più di quanto lei possa ragionevolmente darle. Nulla di quanto aveva immaginato trova specchio nella quotidianità con Violet, ma mostrarsi capace e padrona della situazione, dar prova di essere degna di quell’immagine di madre esemplare così cara al marito ha il sopravvento sulla realtà dei fatti. Chissà, magari Blythe esagera. Magari è lei che non ci sta dentro. Violet non sarà mica così terribile, dai. Perché la devi sempre dipingere a tinte così fosche? Verrebbe quasi da pensare che non le vuoi bene… ma sarebbe una mostruosità bella e buona. Sei un mostro, Blythe?
Blythe è il prodotto di una dinastia di madri che la società civile disapproverebbe. È sopravvissuta a un’infanzia infelice e al rifiuto costante, senza avere gli strumenti “anagrafici” necessari per decodificare i patimenti delle donne della sua famiglia. All’università conosce un ragazzo e, per la prima volta, riesce a immaginare un futuro tollerabile – anzi, un futuro felice. Sono innamorati, lui è convinto che in lei si nasconda una madre meravigliosa e lei ha un gran bisogno di crederci, di meritarsi questa vasta fiducia. Nasce Violet, ma Blythe ci capisce poco. Si ritrova inchiodata a casa – è Fox che lavora mentre lei prova a dedicarsi alla scrittura – con una neonata che pare richiedere più di quanto lei possa ragionevolmente darle. Nulla di quanto aveva immaginato trova specchio nella quotidianità con Violet, ma mostrarsi capace e padrona della situazione, dar prova di essere degna di quell’immagine di madre esemplare così cara al marito ha il sopravvento sulla realtà dei fatti. Chissà, magari Blythe esagera. Magari è lei che non ci sta dentro. Violet non sarà mica così terribile, dai. Perché la devi sempre dipingere a tinte così fosche? Verrebbe quasi da pensare che non le vuoi bene… ma sarebbe una mostruosità bella e buona. Sei un mostro, Blythe?