Cixin Liu e Il problema dei tre corpi – ascoltabile su Storytel o in libreria per Mondadori con la traduzione di Benedetta Tavani – ci incoraggiano a maneggiare un notevole quesito esistenziale: si può apprezzare moltissimo un libro anche se abbiamo l’impressione di non averci capito una mazza? Ho deciso di sì.
Primo tomo di una trilogia che sfida i limiti della materia, dello spazio e anche dei nostri quattro neuroni ancora funzionanti, Il problema dei tre corpi diventerà fra qualche mese una serie Netflix e si confronta con un domandone che si colloca all’intersezione tra scienza e filosofia: SIAMO FORSE SOLI NELL’UNIVERSO? Corollario: che succede se si scopre che soli non siamo?

La domanda è un po’ la stessa di Contact, un film che è piaciuto solo a mio padre – che si riguarda pure Interstellar due volte a settimana. Ai comandi del radiotelescopio di Arecibo troviamo una volenterosissima e appassionata Jodie Foster, sostenuta da un Matthew McConaughey palesemente troppo aitante per interpretare un teologo capace di edificare un solido ponte tra scienza e fede. Discorrendo della strutturale solitudine cosmica del genere umano, ripensano a quante galassie ci sono, quanti soli circondati da pianeti ancora non conosciamo, quanto è vasto l’universo e approdano a un NON POSSIAMO ESSERE SOLI, SAREBBE UNO SPRECO DI SPAZIO. Poi limonano, mi pare.
 Cixin Liu si rifiuta di ricorrere a simili mezzucci, ma ci spappola le sinapsi con un epico intrigo su più piani narrativi che, dalla Cina della Rivoluzione Culturale, segue l’accidentato percorso di una scienziata bollata come Pericolosa Dissidente e mandata in esilio in una base militare segreta. Non ci fidiamo di te, scienziata, ma abbiamo giustiziato tutte le altre grandi menti che potrebbero aiutarci nel progetto Costa Rossa, quindi ti muriamo per un paio di decenni in questo avamposto sperduto e vediamo come gestire questa fastidiosa faccenda della scarsa devozione al sistema.
Cixin Liu si rifiuta di ricorrere a simili mezzucci, ma ci spappola le sinapsi con un epico intrigo su più piani narrativi che, dalla Cina della Rivoluzione Culturale, segue l’accidentato percorso di una scienziata bollata come Pericolosa Dissidente e mandata in esilio in una base militare segreta. Non ci fidiamo di te, scienziata, ma abbiamo giustiziato tutte le altre grandi menti che potrebbero aiutarci nel progetto Costa Rossa, quindi ti muriamo per un paio di decenni in questo avamposto sperduto e vediamo come gestire questa fastidiosa faccenda della scarsa devozione al sistema.
Quello che si fa davvero alla base Costa Rossa (dotata di un’immane parabola puntata verso gli abissi dello spazio) emergerà gradualmente, mentre il diabolico Cixin Liu ci traghetta verso un vicino presente pieno di studiosi che si ammazzano (sopraffatti dall’enormità dei fatti) e di gente che si infila tute matte per cimentarsi in un videogioco immersivo, ambientato su un pianeta vessato da condizioni estreme e da un’instabilità invalidante. CHE COSA DIAMINE STA ACCADENDO.
Non sono nelle condizioni di commentare l’accuratezza scientifica dell’impianto argomentativo di Cixin Liu, ma la sua straordinaria ambizione ha del prodigioso e il romanzo, nel complesso, funziona anche per noi che non abbiamo un dottorato. Una lunga tradizione di film catastrofici ci insegna che gli alieni vogliono solo spazzarci via, ma una fantascienza meno crudele ci ha anche esortati a stabilire un contatto, inseguendo un’idea di trascendenza che colma la sterminata solitudine galattica. Su una scala tra Spielberg e Independence Day, Cixin Liu sceglie un posizionamento interessante: immagina che i dilemmi etici ammorbino anche le civiltà aliene e ci mette nelle condizioni di “combattere” ad armi non proprio pari ma paragonabili, almeno in un’ottica di lungo periodo. Il terreno di gioco è la manipolazione della materia, la capacità di comprenderne il potere invisibile, lo slancio del progresso, ma anche quanto ci riteniamo degni di sopravvivere, di occupare meritatamente quello “spazio” così raro e prezioso.

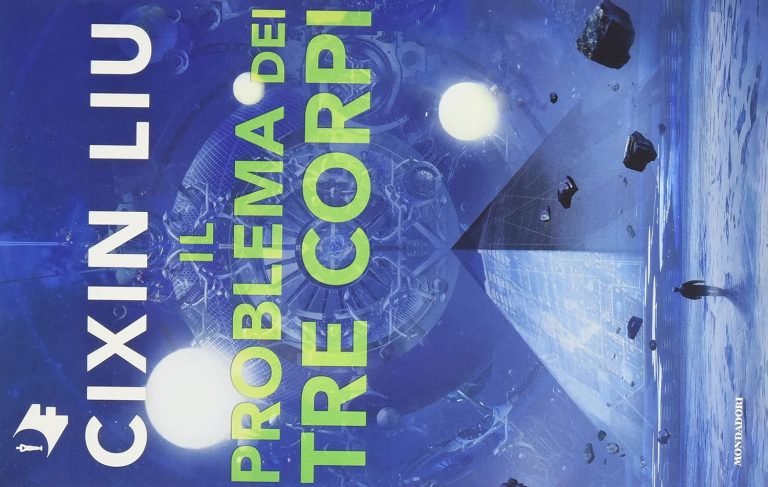



 Ma chi li aziona? Le Crisalidi non vanno benzina
Ma chi li aziona? Le Crisalidi non vanno benzina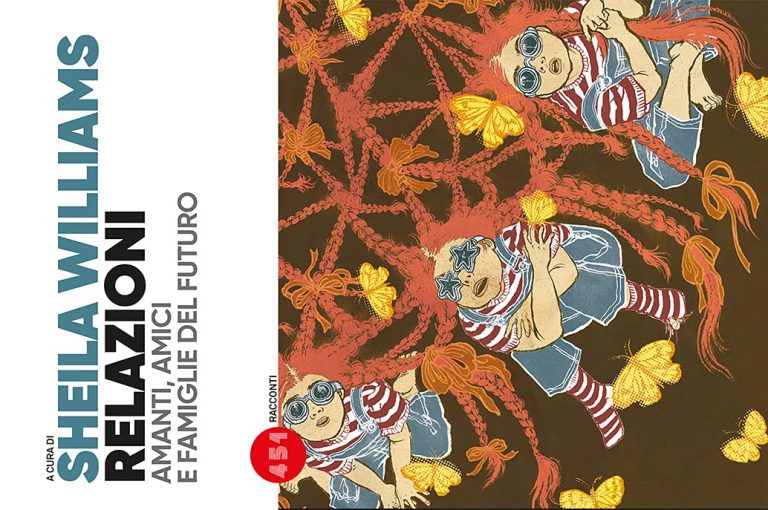
 Non è una gran novità per la fantascienza, che ha sempre parlato di mondi “altri”, di creature sconosciute e di congegni alieni rispetto al nostro presente più visibile per interrogarsi realmente su quello che accade alla vita che conosciamo, a noi come esseri umani, all’anima che ci separa dal meccanico.
Non è una gran novità per la fantascienza, che ha sempre parlato di mondi “altri”, di creature sconosciute e di congegni alieni rispetto al nostro presente più visibile per interrogarsi realmente su quello che accade alla vita che conosciamo, a noi come esseri umani, all’anima che ci separa dal meccanico.
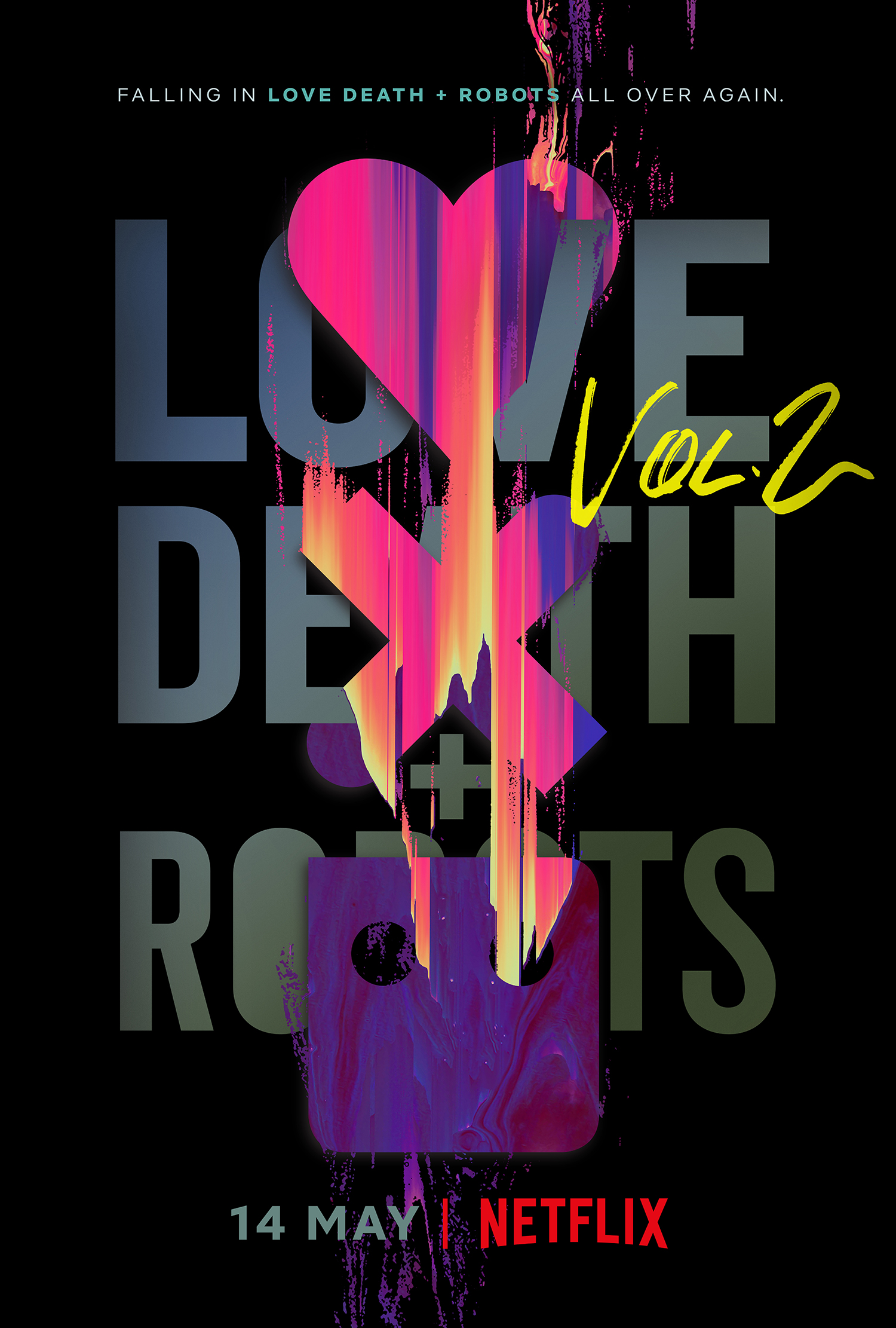 Lo dichiaro all’istante: Love, Death + Robots è una delle mie cose preferite al mondo. La prima stagione ci era piombata addosso senza particolari fanfare, generando un entusiastico effettone-sorpresa dato dalla struttura e dal trattamento visivo estremamente eclettico delle storie. E anche la seconda – uscita il 14 maggio su Netflix – non smentisce il folle spirito delle operazioni. Al comando della ciurma ci sono David Fincher e Tim Miller (qui showrunner/ideatore e già regista direi assai applaudito dalla popolazione del globo per Deadpool), con Jennifer Yuh Nelson a fare da coordinamento registico e da collante creativo.
Lo dichiaro all’istante: Love, Death + Robots è una delle mie cose preferite al mondo. La prima stagione ci era piombata addosso senza particolari fanfare, generando un entusiastico effettone-sorpresa dato dalla struttura e dal trattamento visivo estremamente eclettico delle storie. E anche la seconda – uscita il 14 maggio su Netflix – non smentisce il folle spirito delle operazioni. Al comando della ciurma ci sono David Fincher e Tim Miller (qui showrunner/ideatore e già regista direi assai applaudito dalla popolazione del globo per Deadpool), con Jennifer Yuh Nelson a fare da coordinamento registico e da collante creativo.


