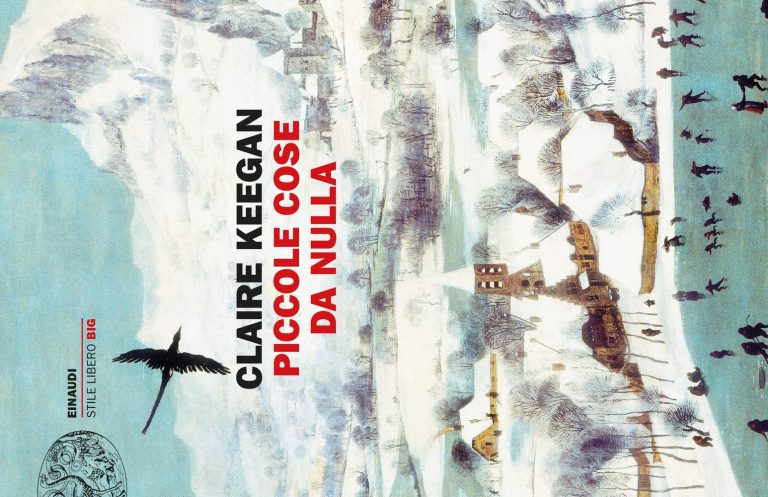Non so di preciso che cosa voglio dire, ma magari lo scopro se comincio a rifletterci.
Dunque, il mio bambino ha compiuto due anni da poche settimane – il che significa che anch’io, in qualità di mamma, ho compiuto due anni. Non sono tanti, ma neanche pochi. E ho il sospetto che, per capire fino in fondo che cosa vuol dire essere “una mamma”, occorrerà ancora parecchio tempo. Forse è un’identità che si costruisce pian piano, ogni volta che soffiamo un naso o prendiamo al volo un bicchiere di plastica con stampato sopra il pesce Dory – magari prima che si schianti sul pavimento. Ogni volta che sentiamo una parola nuova – che combacia, possibilmente, con quello che un ditino sta indicando – o che facciamo del nostro meglio per renderci conto che no, il sabato mattina non si dorme più fino a tardi.
Sono proprio quattro esempi in croce dei millemila esempi possibili. Perché gli esempi non ci mancano. E nemmeno le narrazioni.
In questi due anni, oltre ad interrogarmi sulla metamorfosi identitaria che mi ha investita, ho cominciato a fare molto più caso a come tendiamo a raccontare l’esperienza della maternità. Ma anche a come questi racconti vengono “accolti” e metabolizzati all’interno delle reti sociali (tridimensionali e non) che popoliamo.

Mi utilizzerò come esempio non perché io ho ragione e gli altri sono scemi, ma perché faccio parte della casistica e mi pare una metodologia agevole.
Se uno va a vedere il mio profilo Facebook – ma quello personale, proprio – sembro una che non solo non ha un marito, ma manco si è mai riprodotta. Anzi, sembro una in coma da cinque anni che ogni tanto condivide (per chissà quale miracolo medico) dei link a quello che scrive o che fa per lavoro. E gli altri miei social non sono molto diversi, come approccio – anche se li utilizzo in maniera decisamente molto più “umana” rispetto al profilo Facebook. Sulle Stories di Instagram parlo tanto, in generale. E parlo anche di Cesare. Ma non è una presenza preponderante. Così come non lo si incontra molto spesso nella gallery. Quando c’è, poi, non lo si vede in faccia, ma sempre impegnato a scatenare la sua magnifica assurdità su oggetti, giochi, balocchi e scenari naturali. Non sono neanche una che manda a raffica foto del figlio agli amici. O che, parlando, riconduce immancabilmente la conversazione alla prole. Sempre a livello di contenuti multimediali, invece, amministriamo i parenti stretti con un’applicazione di photo-sharing che ci consente di caricare su questo super cloud condiviso tutti i video e le foto del bambino – i nonni e gli zii (che vivono tutti a un’oretta da noi), quindi, finiscono per avere in mano una fotocopia delle gallerie di immagini che ci sono sui nostri DEVAIS… e il resto lo integriamo telefonandoci indefessamente durante la settimana. Visto che coi social ci lavoro, poi, mi sono anche accorta di non essermi riconvertita a “mamma blogger”. Ho scritto spesso di Cesare e di noi – e ho anche accettato di partecipare a qualche progetto “da mamma” – ma, se una persona volesse leggere dei suggerimenti per organizzare la festa di compleanno perfetta per degli umani che arrivano a stento al metro d’altezza, qui non troverebbe assolutamente nulla.
Ecco.

Io, ogni tanto, mi sento a disagio. Perché, da un lato, mi pare di non “esternare” a sufficienza l’amore e la felicità che provo – considerando soprattutto la frequenza standard con cui i bambini rientrano nelle narrazioni degli altri. Dall’altro lato, però, percepisco il fastidio – spesso manifesto e fiero – di chi si trova a intercettare questi racconti.
Per farla breve, il timore di rompere i coglioni al prossimo che provo quando salgo su un mezzo pubblico con un bambino piccolo che potrebbe mettersi a piangere all’improvviso e per un tempo imprecisato (nonostante i miei sforzi di tenerlo allegro, di intrattenerlo e di ammansirlo) è lo stesso timore che mi sfiora SEMPRE quando mi viene voglia di pubblicare una foto di mio figlio, di inserirlo in una conversazione con il mio prossimo o di scrivere qualcosa che lo riguarda.
L’indole è indole, penso. E sono anche sicura che sia più un problema mio che una vasta piaga sociale. Cioè, anche in un contesto tra i più bambino-friendly del pianeta forse non passerei le giornate a creare album su Facebook dedicati a Cesare o a scrivere pensierini sulle sue gesta nelle caption di Instagram. E non risponderei alla domanda “Che ore sono?” con “Le cinque… proprio il momento in cui Cesare ieri notte ha tossito per tre volte svegliandoci di soprassalto. Ci siamo alzati tutti, siamo andati a vedere se si era scoperto e gli abbiamo accarezzato la testolina”.
Io, semplicemente, sono una che non lo farebbe “così tanto”… ma forse un po’ di più sì.
È anche vero che ci sono narrazioni con cui fatico a empatizzare, nonostante la condizione comune della maternità sia un fattore di avvicinamento. Per esempio, non ho voglia di leggere nessun libro sulle avventure di mamme pasticcione che nella loro consolante imperfezione cronica dovrebbero farci sentire meno inadeguate e più sprint. Così come fatico a identificarmi nelle foto con le mamme ricoperte di veli d’organza che stringono neonati al cuore, accompagnati da un immancabile “6 l’amore della nostra vita, kucciolo”. O con la maggior parte delle caption “da blogger” che vedo su Instagram.
Se non apprezzo tutto questo sono dunque uguale a quelli che dichiarano apertamente di odiare i bambini, anche se ne ho uno? Non lo so, ma non credo.
Perché sono sinceramente felice di imbattermi negli aneddoti di tante persone che seguo volentieri e che condividono anche molto spesso le gesta dei loro infanti, foto comprese. Di sicuro, crescendo, ho anche imparato ad analizzare meglio le classiche situazioni in cui ti viene da stramaledire i bambini perché “disturbano” o non si adattano a uno specifico contesto come piccoli Lord. Chiaro, non sono Santa Rita… se un bambino mi prende a pedate per quindici minuti su un autobus senza che nessuno gli impedisca di malmenarmi tendo a indispettirmi, ma spesso mi accorgo che le madri e i racconti delle madri vengono quasi sempre recepiti con un velo di compatimento. Con un “rieccola qua, a menarcela coi figli”. E non mi soffermo sulla deriva di scherno che accompagna le famigerate “pancine” (nelle loro accezioni più o meno immaginarie o strumentali), perché lì si spalanca un abisso che ha come risultato finale “mamma = povera imbecille dell’alto medioevo”.

Nessuna mamma, forse, ha idea di come regolarsi quando comunica la sua esperienza, nel nostro specifico presente. In fin dei conti, non abbiamo punti di riferimento pregressi. Le nostre mamme non avevano questo problema, se così poi possiamo chiamarlo. Al massimo dovevano preoccuparsi della vicina di casa impicciona o dei parenti che dovevano per forza ficcare il naso nelle loro scelte educative. Non si mettevano a fare, a livello analogico, quello che facciamo noi con le storie e le immagini dei nostri bambini sui social (se abbiamo dei profili pubblici, ovviamente). Cioè, se ci pensiamo, è come se ci mettessimo in mezzo alla strada a distribuire fotografie della nostra prole (con tanto di didascalia) ai passanti. È un paragone scemo, perché i comportamenti si evolvono con i contesti e la normalità di quello che succede è misurata sulle abitudini che sviluppiamo (e che gravitano su un concetto di “accettabilità” che muta con le norme condivise in un certo periodo). Però ci penso, ogni tanto, a mia madre che si mette nel parcheggio della Società Canottieri Vittorino da Feltre a fare volantinaggio con le mie foto di Natale.
Noi, di contro, possiamo scegliere come approcciare la questione (nessuno ci obbliga a “comunicare” i nostri infanti), ma molto spesso continuiamo a non poterne controllare a pieno le conseguenze.
Io, per dire, quando voglio farmi del male vado a leggere cosa scrive la gente sotto ai post della Ferragni col figlio. Se voglio provare del furore vero apro i commenti sotto agli status di qualche amica che ha incautamente dichiarato di dover portare un neonato a fare l’esavalente o, peggio, che si è proclamata felice per il passaggio al latte artificiale.
Ma lasciando perdere i temi ritenuti scottanti o i personaggi famosi – che tirano sempre fuori il meglio dai frequentatori della rete, proprio -, nemmeno coi racconti più innocui e tranquilli si va via lisci. Perché in mezzo ai tanti “ma che bel bimbo!” e “ma che tenerezza!” c’è sempre, se ci fate caso, almeno una voce inopportuna che sceglie di staccarsi da coro per ricordarci che le vicine di casa rompicoglioni continuano a esistere. O per domandare con finto interessamento “ma scusa perché non fai così e così?”. O per farti notare una mancanza, un deficit, un “potevi farlo meglio”. O per esplicitare l’irritazione che i bambini suscitano immancabilmente quando vengono a contatto con situazioni non pienamente strutturate per loro, ma che comunque fanno parte della realtà e del vivere comune.
Racconti una marachella?
Non sei una persona responsabile, stai crescendo un criminale, siete un pericolo per l’ordine pubblico.
Racconti un momento di fatica?
Eh, capirai. Io ho scalato il K2 con due gemelli nello zaino da trekking. E avevo anche il cagotto.
Racconti un traguardo?
Awwww, che bello. Due righe sotto: ma scusa, ha un anno e mezzo e non camminava ancora?

Quando voglio raccontare qualcosa di felice mi chiedo sempre “ma non sarà TROPPO coccoloso?”. Perché è un attimo. Diventi LA MAMMA RIMBECILLITA.
È come se non ci fosse una via di mezzo ancora codificata.
Ci sono dei costrutti e dei nessi causa-effetto prestabiliti. Dei “modelli” di mamma che in un dato periodo sono da ritenersi più accettabili e digeribili – o meno fastidiosi – di altri.
Se ti lamenti troppo era meglio se i figli non li facevi, se non ti lamenti neanche un po’ stai sicuramente fingendo che la tua vita sia un idillio, se parli troppo di bambini sei pesante, se ne parli troppo poco vuol dire di certo che nascondi qualcosa o che non li ami abbastanza. Se dici che sei contenta di come te la stai cavando vuol dire che te la meni GUARDA CHE NOI QUA NON DORMIAMO DA SEI ANNI, se dici che sei scoraggiata stai sputando sul dono più grande che il cielo poteva farti, se lavori come hai sempre lavorato sei una che non sa dare la giusta priorità alle cose, se vai in vacanza lasciando il bambino ai nonni sei un’egoista, se vai in vacanza e ti porti il bambino dovresti prendere in considerazione che anche gli altri sono in vacanza e forse è meglio se stavi a casa tua con quel neonato che strilla, se non vai in vacanza stai chiaramente privando una giovane mente delle esperienze necessarie al suo arricchimento, se racconti tre delle ottantasei cose buffe che ha fatto tuo figlio durante la giornata sei una che se le inventa perché è in cerca di attenzione.
Tutto questo accade contemporaneamente.
E accade, soprattutto, quando sei sincera. Quando non stai cercando di dare spettacolo o di somigliare a un canovaccio noto.
In generale, mi pare che le mamme si dipingano con molto più cinismo e distacco di quello che provano veramente. O che, all’estremo opposto, entrino in modalità “mamma onnipotente” – quella sempre bella, attiva, che lavora, che va a pilates, che s’abbona a teatro, che ha tempo per la famiglia ma anche per farsi i fattacci suoi e che ha sfornato solo bambini prodigio.
Non escludo che nelle due categorie ci siano davvero mamme sinceramente ciniche o mamme sinceramente onnipotenti, ma entrambi gli schieramenti – nelle loro varie sfumature di autentica adesione al principio cardine – hanno il sacro terrore di poter in qualche modo ricascare nello standard della mamma lobotomizzata dalla prole, occupando un punto qualsiasi all’interno dello spettro che va da “sono due anni che proviamo a invitarla fuori ma sai… col bambino… dice sempre che non ce la fa” e finisce con “presa per il culo conclamata su tutte le piattaforme perché ha cucinato la placenta”.
Sembra che non esista nulla di più disdicevole di una donna precedentemente in grado di funzionare all’interno di un contesto socio-lavorativo che, dopo aver avuto un figlio, dà segni di essere in qualche modo stata modificata dall’esperienza. È come se, inconsciamente, cercassimo costantemente di dire “ah, sì, sono mamma. Ma sono ancora una persona normale! Non lasciatemi indietro!”.

Sono andata a rileggermi alcune cose che ho scritto in questi due anni sul tema della maternità. E lo ripeto anch’io, immancabilmente: un mio grande obiettivo, tra i tanti, è quello di rimanere NORMALE.
Che volevo dire? Forse che è importante non dimenticare come eravamo prima. Che possiamo far lievitare la nostra identità per creare dello spazio nuovo che la maternità possa occupare senza sovrascrivere tutto quello che c’era già. O che, per qualsiasi cosa, vogliamo poter continuare a contare sulla rete di fiducia e di rapporti sociali che coltivavamo da nullipare.
Sono ambizioni legittime, mi pare.
Ma in quel SONO ANCORA NORMALE credo si nasconda anche un “non preoccupatevi, non vi ammorberò notte e giorno parlando di cacca. Lo so che è una rottura intollerabile”. Perché io, quello slancio empatico lo faccio. “Sarò menosa?”. “Come posso rendere sereno questo viaggio in treno?”. Il fatto è che, spesso, non percepisco uno slancio simmetrico che proviene dalla direzione opposta.
Per me, che ho passato a casa con Cesare un anno intero, in pratica, conservare la presa sulla normalità rappresentava un obiettivo importante. Perché, di punto in bianco, ti ritrovi a gestire tutto quello che sei in una maniera completamente diversa. Certo, hai nove mesi di gravidanza a disposizione per immaginare il cambiamento di paradigma che ti aspetta… ma poi, quando ogni mattina la porta si chiude e tuo marito va in ufficio, le ore che ti separano da un nuovo contatto con un adulto che ti racconta cos’ha fatto quel giorno sono parecchie. Si diventerebbe un po’ autoreferenziali anche ritrovandosi a gestire una responsabilità minore o un senso di meraviglia molto più limitato. E nemmeno una persona che tende a over-analizzare tutto – salve, eccomi qua! – riesce a prevedere davvero come la prenderà, come reagirà e quale sarà la portata dei suoi sentimenti. Perché sì, gli esseri umani si riproducono dall’alba dei tempi e la faccenda non dovrebbe causare un particolare scalpore, ma per il singolo (e specialmente per la singola nuova mamma) l’evento rimane rivoluzionario. Ma non perché, magari, l’hai presa un po’ troppo sportivamente e sei una che non si rende conto della portata del compito – massì, facciamo un figlio, in qualche modo ce la caveremo -, ma perché un bambino che nasce È un evento rivoluzionario.
C’è chi scopre una vocazione all’accudimento che non pensava di avere.
C’è chi abbandona la modalità Erode e si candida a rappresentante di classe al nido.
C’è chi diventa ferocemente intollerante verso i ventenni spensierati.
C’è chi si mette a chiacchierare in mezzo alla strada con chiunque stia spingendo un altro passeggino.
C’è chi si lamenta delle difficoltà CONTINUAMENTE, ma è felice lo stesso.
C’è chi si lamenta e lo sta facendo per manifestare un grande disagio sommerso.
C’è chi scopre di avere a fianco un padre inadeguato o un uomo che, di contro, “migliora”.
C’è chi riconverte ogni sua narrazione personale alla narrazione della maternità.
Che ne sappiamo. Succede di tutto.
Ci sono tanti racconti lontani da me. Così come ci sono tante esperienze che sono diventate, nei mesi, fonte di incoraggiamento, di utilità pratica e di supporto emotivo. La “normalità” da conservare, per me, è sempre stata un po’ un’arma di difesa. Perché, specialmente all’inizio, ti rendi conto che il resto del mondo procede mentre tu ti trovi in una bolla di tempo sospeso dove esisti – a lungo – quasi esclusivamente in funzione del tuo ruolo di mamma. Ci sono donne più pronte a votarsi alla causa, donne che non sapevano di essere così “adatte” a un compito del genere e donne che si riconfigurano con più difficoltà. E ogni incontro che facciamo, mentre cerchiamo di capire come cavarcela, è un incontro che ci segna un po’. Nel calderone vanno a finire le amiche che insistono per sapere TUTTO quello che sta succedendo, ma anche i colleghi che alzano gli occhi al cielo quando ti suona il telefono e dall’asilo ti dicono che il bambino ha la febbre e devi andarlo a prendere. Ci sono i ragazzi che ti aiutano a portare il passeggino su per una scalinata ma ci sono anche quelli col cane al guinzaglio che, su un marciapiede stretto, si piantano in mezzo e ti guardano infastiditi, senza capire che dovrebbero scendere loro, non tu che hai una carrozzina ingombrante.

Quello che volevo dire, forse, è che mi piacerebbe percepire un po’ più di cameratismo tra esseri umani. Detestare i bambini è un diritto sacrosanto, ci mancherebbe. Non capisco tanto, però, come proclamare il proprio odio per un’intera categoria umana – anzi, per due categorie: i figli e i genitori – possa tramutarsi in un tratto desiderabile. Ciao, sto dichiarando con fierezza di non essere in grado di empatizzare con questa fetta di mondo. Wow… complimenti.
Mi rendo conto che, spesso, la paura che abbiamo di risultare fastidiose e inopportune – sia mentre ci raccontiamo che mentre “viviamo”, a livello pratico – frena un po’ la possibilità di condividere il bello. Quello su cui inevitabilmente è più difficile allinearsi e concordare è tutta la parte “felice”. Siamo più propense a far venire fuori le menate, perché le menate sono invariabilmente condivisibili. A chi piace svegliarsi quattro volte a notte? A chi piace la scarlattina? A chi piace l’assoluta irrazionalità di un bambino di due anni che strilla come un condor perché non può portare in giro un cane di plastica di due chili e mezzo? A nessuno, porca miseria. Forse, allora, è anche per quello che la felicità viene sempre descritta in maniera esagerata e stereotipata. La madre “soddisfatta” è un susseguirsi di frasi da Baci Perugina, nomignoli ultra-stucchevoli, luoghi comuni di ogni epoca ed estrazione, feste di compleanno faraoniche. La felicità dev’essere ENORME, dev’essere DI PIÙ per riuscire a farsi sentire o a suscitare una reazione.
Io, mio malgrado, appartengo più al partito del cinismo lamentoso. È questione di attitudini. Quello che mi piacerebbe, però, è poter fare a meno sia di una che dell’altra narrazione. Non so che cosa contribuisca, a livello tecnico e formale, a trasmettere quella sensazione posticcia che ti assale quando leggi o ascolti una mamma super cinica o una mamma super orsachiottosa. Non lo capisco, ma lo percepisco. E non ne abbiamo bisogno. Così come non abbiamo bisogno di sviluppare strategie per reagire al compatimento o all’ostilità altrui. I bambini devono piacere a tutti? No. Ma magari noialtre potremmo fare a meno di provare a piacere a chi, esercitando un suo diritto – per quanto discutibile -, la pensa così. E potremmo ricominciare a raccontarci – se ne sentiamo il bisogno -, come ci pare e quanto ci pare. A usare parole vere, che molto più del teatrino che allestiamo sanno trasmettere la bellezza in mezzo alla discreta fatica che ogni tanto facciamo.
Di che parla la gente, alla fin fine?
La gente parla, da sempre, di quello che ama.
Così com’è.




 Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.
Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.