Angela Izzo, io ti riconosco. Sono di Piacenza e a Napoli non possiamo vantare alcun parente, ma ti sento nelle ossa, ti sento nelle orecchie, capisco cosa dev’essere stato passarti davanti. Detestarti è stato bellissimo, in queste pagine. Forse meritavi di peggio, ma “‘o scrittore du’ cazz'” è figlio tuo e io non ho intenzione di intromettermi. Di te, però, devo ammettere d’aver ammirato l’aperta ostilità e la propensione nulla al commento obliquo, ma andiamo con ordine. Chi diavolo è Angela Izzo? Era la mamma di Antonio Franchini, che qui troviamo trasfigurata in personaggio nefasto e nemesi romanzesca, nel mostro che sta al centro del gorgo di famiglia. Angela risucchia tutto e sembra contaminare anche quello che non tocca, perché vastissima è la disapprovazione che proietta e inesauribili sono i debiti di cui è capace di caricarti.
 Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta, furibonda e circostanziata. Nel produrre questo ritratto “mediato” di Angela, Antonio Franchini intreccia piani temporali, registri e ricordi, restituendoci un intero sistema di disvalori, oltre che la parabola biografica di un rapporto di sangue. Angela è difficile da intrappolare e impossibile da neutralizzare, perché non tace mai e sgomita per deformare la realtà. Il suo dominio è lo spazio domestico – prima a Napoli e poi a Milano, dove segue due dei suoi figli ormai diventati adultissimi – ma il dove la si piazzi conta poco, perché Angela è impermeabile al mondo, alle opinioni altrui, all’italiano e alla temperanza.
Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta, furibonda e circostanziata. Nel produrre questo ritratto “mediato” di Angela, Antonio Franchini intreccia piani temporali, registri e ricordi, restituendoci un intero sistema di disvalori, oltre che la parabola biografica di un rapporto di sangue. Angela è difficile da intrappolare e impossibile da neutralizzare, perché non tace mai e sgomita per deformare la realtà. Il suo dominio è lo spazio domestico – prima a Napoli e poi a Milano, dove segue due dei suoi figli ormai diventati adultissimi – ma il dove la si piazzi conta poco, perché Angela è impermeabile al mondo, alle opinioni altrui, all’italiano e alla temperanza.
Angela si esprime per sentenze, anatemi, rivendicazioni, dogmi, furori imprevedibili, sceneggiate interminabili, insulti. È vanagloriosa ma poveretta quando le fa comodo, prepotente ma vittima, sprezzante ma dipendente dagli altri, perché può affermarsi solo per opposizione diretta, in una continua rivendicazione di una superiorità farlocca, basata sul disvalore, sul pregiudizio e sul disprezzo. Le sue arringhe sono confuse e la sua invadenza totale: son tutti coglioni (o zoccole) tranne lei, che non si fida di nessuno e che tutti dovrebbero elevare a esempio supremo, anche se crede a intermittenza solo a quello che potrebbe tornarle utile o, per principio, solo al contrario di quello che pensi tu. Lo stato le deve l’accompagnamento, i suoi figli le devono tutto e noi, che possiamo solo limitarci a leggerla, siamo grati a Franchini per aver fatto da parafulmine.
Il fuoco che ti porti dentro – uscito per Marsilio e finalista al Premio Campiello – è un libro tremendo perché Angela è tremenda, ma Franchini riesce a restituirci quella simpatia immotivata che le conoscenze superficiali possono di tanto in tanto suscitare. Tutti gli amici o i colleghi di Milano che per qualche ragione di sono imbattuti in Angela l’hanno trovata folcloristica, insolita, affascinante e “fortissima”, nella sua inarrestabile follia. Il dramma è lì, in questa capacità di metamorfosi del mostro, ma in questo spazio sta anche l’abilità di scriverne donandoci il comico e il paradossale, senza scadere nella macchietta ma concedendole l’onore delle armi, come andrebbe fatto con ogni valente avversario. La storia di Angela è quella di una famiglia intera, di uno scontro eterno tra Nord e Sud, tra ricchi e zappatori, tra pesce “buono” e schifezze del supermercato, tra madri e figli… che scappano per salvarsi e, per fortuna, decidono a volte di raccontarcelo così.



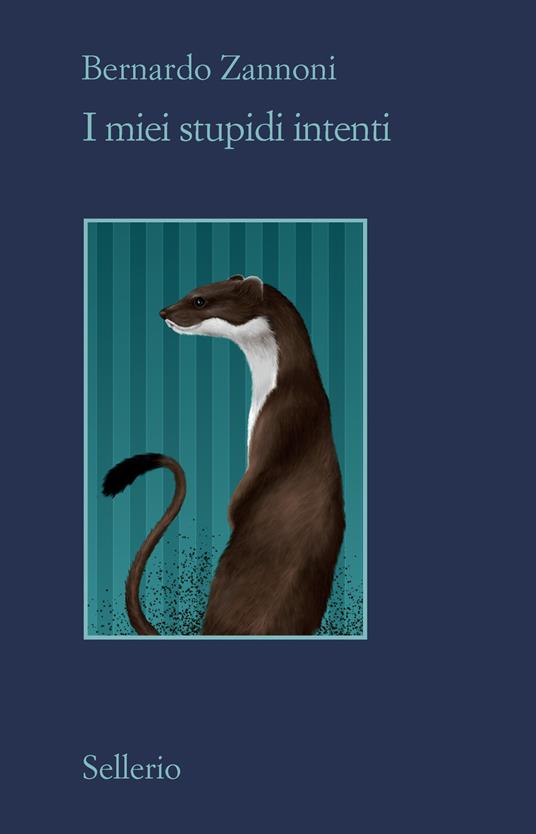 Ho deciso che il modo più efficace per provare
Ho deciso che il modo più efficace per provare