Dunque, William Sidis è esistito davvero. È nato nel 1898 a New York da una coppia di ucraini emigrati (entrambi brillanti medici dal passato impervio se non invalidante) e pare conservi ancora il primato di Persona Più Intelligente Del Pianeta – almeno secondo alcuni criteri “consolidati” di misurazione. Mai capiti, i test del QI, ma utilizziamoli come dato storico che molto dice anche del contesto in cui sono stati architettati. COMUNQUE. Morten Brask trasforma la vita di Sidis in un romanzo – tradotto da Ingrid Basso per Iperborea –, facendo il possibile per renderci partecipi dell’intima visione del mondo di una mente ineguagliabile. Anzi, il binario è doppio. C’è il cervello di Sidis e poi c’è l’individuo Sidis. E il treno deraglia.
 Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?
Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?
La vita perfetta di William Sidis non è un libro memorabile, se dobbiamo dirci “com’è il libro”, ma appartiene alla categoria per me felicissima dei libri che suscitano interrogativi e che utilizzano un “caso” per farci riflettere sulla storia e sulla mutevolezza della fede che epoca dopo epoca decidiamo di riporre in entità più o meno astratte o costrutti disparatissimi.
Per tutta la vita Sidis è stato trattato come una sorta di fenomeno da baraccone e sulle sue prodezze matematiche, linguistiche e nozionistiche sono stati rovesciati fiumi di inchiostro, ma le rotative che tanto aveva alimentato da piccolo con i suoi traguardi fuori dal comune hanno poi finito per triturarlo per la vicinanza e l’attiva adesione, in età meno tenera, alle idee socialiste e al pacifismo. È passato un secolo, ma Sidis è ancora uno degli incubi peggiori del sentire comune: è un talento “sprecato”, un’intelligenza fuori scala che ha scelto deliberatamente di non partecipare, di non lucrare sul suo genio, di non costruirsi un monumento. Sidis potrebbe, ma preferisce di no.
In un mondo – come è ancora il nostro – in cui si trasforma l’assoluta banalità dell’ordinario in qualcosa che dovrebbe ambire alla memorabilità, Sidis zoppica verso una normalità “privata” che gli è sempre stata preclusa. A che serve sapere tutto se è così faticoso esistere in mezzo agli altri? Cosa possiamo aspettarci da un bambino che si trasferisce in un dormitorio di Harvard? Che cos’è l’intelligenza? Immagazzinare all’infinito o sapersi muovere in un piano di realtà?
Brask non ha la più vaga idea – così come non possiamo averla noi – di come “funzionava” davvero Sidis, ma l’onore che gli rende è quello di lasciar affiorare il fardello impossibile di una responsabilità imposta: migliorare un mondo in cui non ci è stato possibile (o concesso) trovare uno specchio o un’isola rassicurante. Sidis è forse percepibile ancora oggi come eroe tragico perché ribalta i nostri assunti radicatissimi sull’ambizione, sull’eccellenza come puntello per l’individualismo, sul “fare” per potersi comunicare migliori e degni, per non svanire senza lasciare traccia del nostro passaggio. Che peccato, direbbero i sempre rumorosi paladini del “se le avessi avute io le tue possibilità!”. Che pace, risponderebbe probabilmente Sidis. Ma che possiamo mai saperne noi, in fondo.

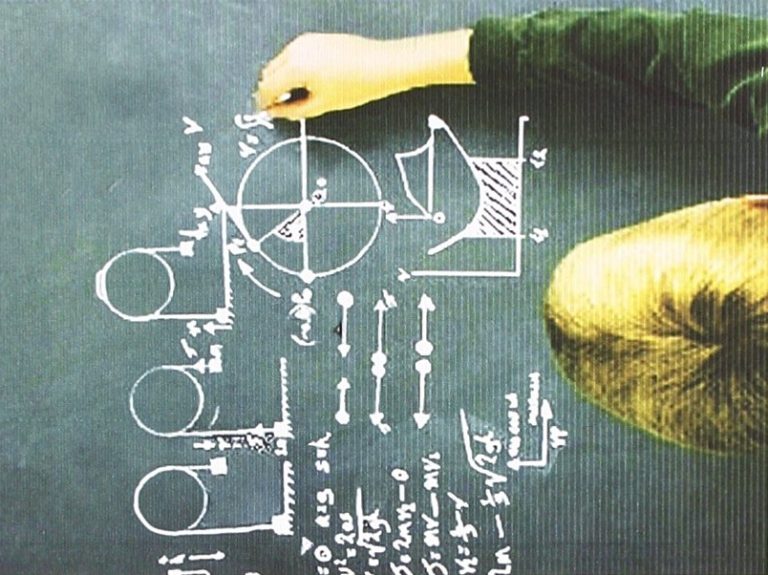

 È bellissimo. Leggetelo.
È bellissimo. Leggetelo.