Qualche premessa situazionale per delimitare il campo. Al centro di Hidden Valley Road di Robert Kolker – illustre firma del giornalismo investigativo statunitense – c’è una famiglia che a lungo ha tentato di uniformarsi ai parametri di successo, armonia e benessere a cui siamo abituati ad associare il sogno americano. Mimi e Don Galvin si conoscono in gioventù, si sposano senza grandi inghippi e si trasferiscono per qualche anno su e giù per il paese seguendo gli impegni lavorativi e accademici del marito. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e vari incarichi al seguito dell’esercito, a Don viene offerto un posto in Colorado dall’Air Force, che fra le rocciosissime montagne stava consolidando le sue basi, con annesse comunità urbane. I piccoli Galvin cominciano a nascere nel 1945 e, nell’arco di vent’anni, diventeranno dodici – dieci maschi e due femmine, le ultime in ordine di apparizione. A sei dei fratelli, più o meno precocemente e con effetti più o meno distruttivi, verrà diagnosticata la schizofrenia, trasformando la famiglia in una sorta di caso clinico senza precedenti. Le potenziali domande sono innumerevoli.
Perché così tanti figli si sono ammalati?
Perché fare COSÌ TANTI FIGLI, anche?
Che cos’è successo davvero in quella casa?
Qual è stato – e continua ad essere – l’impatto sui fratelli sani?
Come sono stati curati i Galvin schizofrenici?
Come stanno ora?
Come diamine è possibile che a gente all’apparenza “normale” sia capitata una cosa simile?
 In questo libro (tradotto per Feltrinelli da Silvia Rota Sperti), Kolker ricostruisce la storia della famiglia Galvin e, in parallelo, ripercorre le tappe salienti della ricerca sulla schizofrenia – un po’ perché i Galvin sono stati effettivamente intercettati da genetisti, psichiatri e specialisti che di schizofrenia si sono occupati a livello accademico e un po’ perché stiamo ancora collettivamente attendendo risposte scientifiche condivise e “solide” su una malattia profondamente invalidante e complessa che persiste nell’eludere i nostri sforzi di mappatura, controllo e cura.
In questo libro (tradotto per Feltrinelli da Silvia Rota Sperti), Kolker ricostruisce la storia della famiglia Galvin e, in parallelo, ripercorre le tappe salienti della ricerca sulla schizofrenia – un po’ perché i Galvin sono stati effettivamente intercettati da genetisti, psichiatri e specialisti che di schizofrenia si sono occupati a livello accademico e un po’ perché stiamo ancora collettivamente attendendo risposte scientifiche condivise e “solide” su una malattia profondamente invalidante e complessa che persiste nell’eludere i nostri sforzi di mappatura, controllo e cura.
Insomma, Hidden Valley Road è sia la cronaca minuziosa della parabola collettiva di una famiglia per parecchi versi lontanissima dall’ordinario, ma anche un approfondimento ramificato e ricco sulla malattia mentale. Questo doppio binario riesce a restituirci la dimensione “personale” dei Galvin, inquadrandoli nell’orizzonte più ampio del mistero clinico.
Che cos’è davvero la schizofrenia? Perché si manifesta in così tanti modi diversi ed è spesso stata diagnosticata con troppa reticenza o, al contrario, eccessiva disinvoltura? Come veniva curata negli anni Settanta – quando i Galvin hanno iniziato ad ammalarsi – e come siamo messi ora? I farmaci aiutano? Cosa può fare la psicoterapia? Siamo finalmente riusciti a risalire alle cause della schizofrenia?
L’ultimo domandone è forse quello in grado di riassumere tutti gli altri. Il grosso del dibattito nella comunità scientifica a proposito della schizofrenia ha gravitato su due poli che per decenni si sono esclusi a vicenda: c’era chi sosteneva che la schizofrenia avesse basi genetiche e chi sosteneva che dipendesse da fattori ambientali. In soldoni: ci sono cervelli strutturalmente predisposti a ospitare la malattia VS la malattia si manifesta in presenza di cause scatenanti che dipendono dal contesto in cui si cresce, dalla gente che abbiamo attorno, dai legami che stringiamo…
È sul filo di questa fondamentale ricerca di senso che si muove Kolker nel presentarci i Galvin innanzitutto come esseri umani e non solo come “pazienti” o casi clinici estremi – per quanto lo siano e per quanto non manchino traumi, abusi ed episodi di irreparabile violenza.

Dai ritratti in perenne divenire dei genitori – entrambi invischiati in una battaglia privata e duratura tra ambizione e realtà concretamente raggiungibili, nonostante un’epoca in cui gli ascensori sociali tendevano ancora a funzionare – alle testimonianze dirette raccolte intervistando Mary e Margaret e i fratelli superstiti, Hidden Valley Road è la cronaca di un trauma collettivo, un reportage psichiatrico e una storia di famiglia.
Tono?
Kolker si sottrae, fortunatamente, sia al pietismo pruriginoso che al gusto per il dettaglio macabro. Non ci sono poetiche riflessioni o voli pindarico-consolatori sul coraggio nella malattia, sull’eroismo dei prestatori di cure e su quanto le difficoltà più atroci ci offrano impagabili lezioni di vita: non c’è sensazionalismo, ma il taglio è fattuale, giornalistico, ordinato. Non c’è quella vena quasi divertita che talvolta si rileva nei testi che illustrano i casi medici “curiosi” o al limite: i Galvin non ci vengono presentati come un grande freakshow psichiatrico.
Sono gente a cui succedono cose inspiegabili, dolorose e distruttive, gente che non trova risposte strutturali ma solo soluzioni temporanee a sintomi ingestibili. Dei Galvin malati conosciamo la traiettoria terapeutica e il terreno comune dell’infanzia, dei sani e dei sopravvissuti impariamo a intravedere le cicatrici inevitabili, perché la malattia mentale di chi ci sta vicino non è qualcosa che accade in un compartimento stagno da cui possiamo dirci immuni.

Tra chi è rimasto e chi si è allontanato, Kolker cerca di restituire rispettosamente valore alle esperienze individuali dei fratelli e di evidenziare il ruolo fondamentale che la loro collaborazione ha giocato nel tentativo della scienza – e di un manipolo di specifici ricercatori – di fornire le risposte che ai Galvin sarebbero tanto servite, senza poterne di fatto beneficiare in tempo utile. La strada per comprendere e curare davvero la schizofrenia è ancora lunga, ma di certo ha incrociato in più di un’occasione la Hidden Valley Road di questa famiglia.



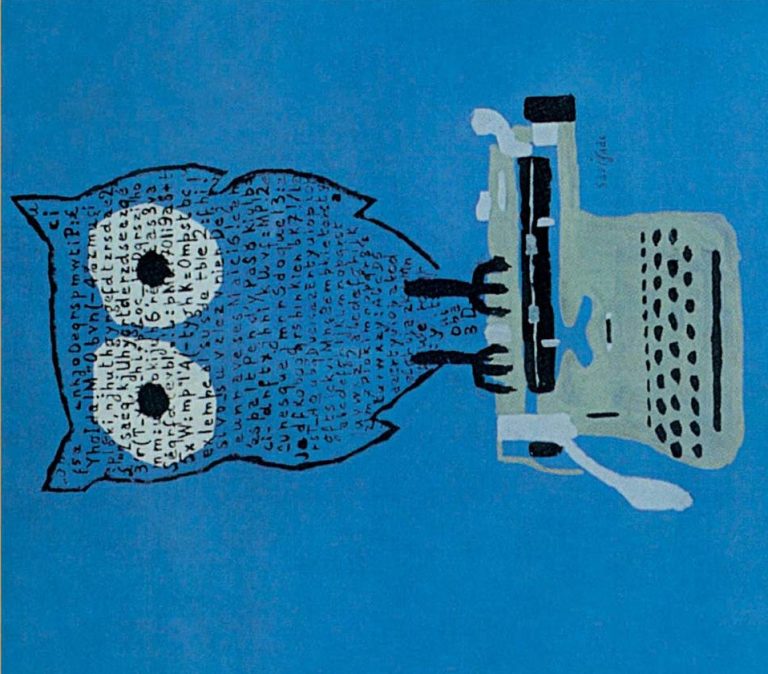

 [Bonus track: un capitolo è dedicato a Norstein e al suo lavoro geniale, che si sviluppa in una sorta di mondo parallelo immune dalle scadenze ma tristemente soggetto alle necessità materiali.
[Bonus track: un capitolo è dedicato a Norstein e al suo lavoro geniale, che si sviluppa in una sorta di mondo parallelo immune dalle scadenze ma tristemente soggetto alle necessità materiali.


