Di gender-gap nelle professioni tecnico-scientifiche e nella ricerca d’ambito STEM si parla in abbondanza ancora oggi, quindi figuriamoci com’era l’andazzo negli anni Sessanta. In Lezioni di chimica – uscito in italiano per Rizzoli con la traduzione di Anna Rusconi – Bonnie Garmus sceglie quell’epoca lì per la sua Elizabeth Zott, chimica autorevolissima e signorina con zero voglia di allinearsi al modello della casalinga suburbana. La storia di Zott è una specie di ripasso delle rivendicazioni femministe di base perché, per quanto la protagonista aborri la condizione di moglie e madre, la platea che più le darà credito sarà proprio quella. Come ci arriva? Con la TV.
 Zott trova un lavoro in un istituto di ricerca popolato da sgobboni e opportunisti che dispone di un unico vero genio. Questo Calvin Harris è un tipo strambo, che socializza poco e ha la fama di legarsi al dito anche il più minuscolo sgarbo. I due, tra un becco Bunsen e l’altro, si innamorano e trovano il modo di essere intelligentissimi insieme. Destano gran scandalo, ovviamente, perché convivono senza essere sposati e lui ha l’ardire di trattarla anche come una collega vera. Creano una famiglia atipica – che riscatta entrambi dal disastro dei loro nuclei di provenienza – , ma nel loro microcosmo tutto funziona….. fino a un cataclisma improvviso. Che ne sarà di Zott? E della figlia che non ha mai voluto ma le è rimasta sul groppone?
Zott trova un lavoro in un istituto di ricerca popolato da sgobboni e opportunisti che dispone di un unico vero genio. Questo Calvin Harris è un tipo strambo, che socializza poco e ha la fama di legarsi al dito anche il più minuscolo sgarbo. I due, tra un becco Bunsen e l’altro, si innamorano e trovano il modo di essere intelligentissimi insieme. Destano gran scandalo, ovviamente, perché convivono senza essere sposati e lui ha l’ardire di trattarla anche come una collega vera. Creano una famiglia atipica – che riscatta entrambi dal disastro dei loro nuclei di provenienza – , ma nel loro microcosmo tutto funziona….. fino a un cataclisma improvviso. Che ne sarà di Zott? E della figlia che non ha mai voluto ma le è rimasta sul groppone?
Di fatto estromessa e scacciata da quei mentecatti dell’istituto, Zott coglierà al balzo un’occasione economicamente redditizia e, dato che è pure bella e magnetica, diventerà la conduttrice di Supper At Six, un programma di cucina di fascia pomeridiana. Il network sperava di aver assunto una rassicurante massaia, ma Zott trasformerà lo show in una lezione di chimica….. e di proto-femminismo.
Allora, l’ho trovato piacevolissimo, nonostante Zott sia un personaggio che risulta paradossalmente statico. Certo, si riadatta agli accidenti e alle opportunità della vita, ma la sua inflessibile fedeltà a una vocazione scientifica e al rifiuto di qualsiasi convenzione o compromesso sembrano far parte del suo patrimonio genetico, prendere o lasciare. È corretto, mi vien da dire, che Zott sia così, proprio perché il contesto a cui appartiene si aspetta femmine docili, obbedienti, prive di opinioni e di ambizioni, decorative e malleabili, ignoranti e inoffensive: Zott non ha la minima intenzione di rispondere alle aspettative, ma si aspetta invece che sia il mondo a cambiare e lo affronta come se toccasse a lei fare da prototipo, mostrando che un’altra strada dovrebbe essere possibile. Certo che è una specie di monolito alieno, perché se si ammorbidisse anche solo di tanto così il bel soufflé che è questo romanzo si sgonfierebbe, rassegnandosi a somigliare al compromesso imperfetto e quasi sempre iniquo dei nostri percorsi “veri”.
Zott prende sul serio le donne che la guarderanno – prima allibite e poi sempre più gasate – alla TV, le tratta come degli esseri umani capaci e autorevoli, le istruisce e le incuriosisce. E lo fa da persona che condivide il medesimo “svantaggio” di partenza e che ha pagato a caro prezzo quell’intransigenza che, almeno da fuori, risulta così d’ispirazione, così “potente”. Zott non cambierà nulla, dalla mattina alla sera, ma nell’improbabile esperimento che è la sua esistenza non c’è spazio per i vecchi dogmi. Chi l’ha detto che non ci arriviamo, che siamo meno brave, che il nostro posto è solo questo? Voi? Sarebbe meglio verificarlo, se non vi dispiace. Forza, il laboratorio è per di qua – sembra una cucina? Guardate meglio.
[Sì, sono consapevole dell’esistenza della serie TV ma non l’ho ancora vista, anche se mi garberebbe molto capire com’è. Il fatto che sia prodotta da AppleTV fa ben sperare.]


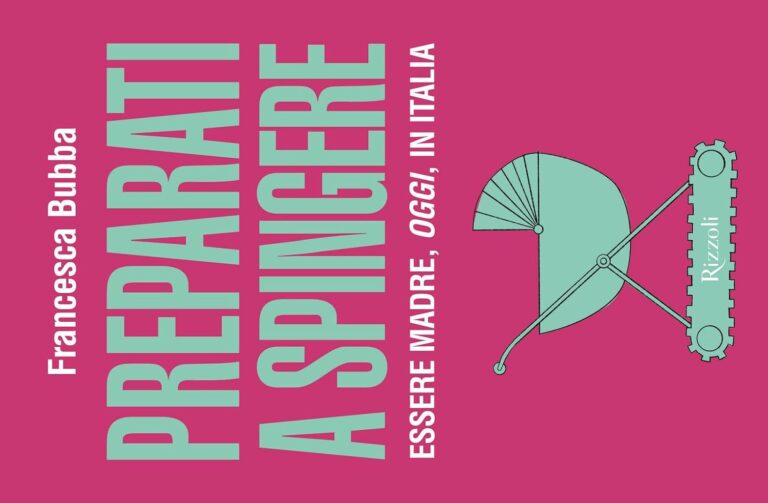

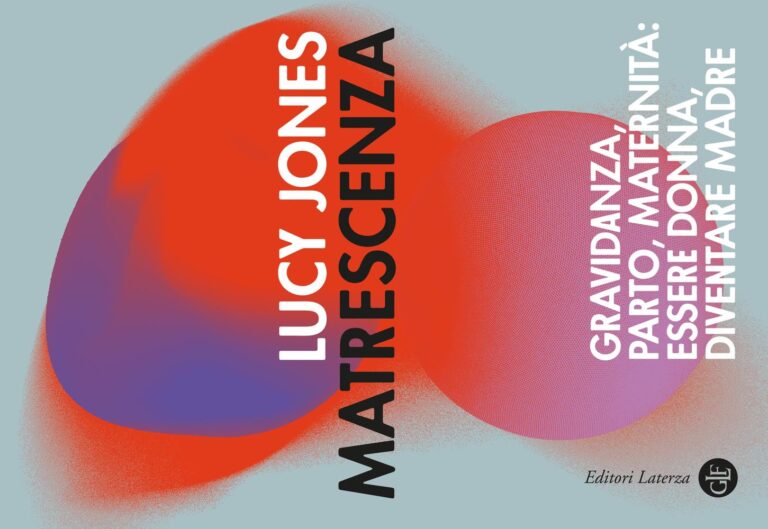


 Ci troviamo in un nebuloso regno marittimo governato da un imperatore teatralissimo e troppo fanciullesco per destare sospetti di particolare pericolosità. Il regno è dotato di una società ordinata, di università e di una popolazione poco incline ai colpi di testa. Non si capisce bene che cosa s’insegni a scuola, però, visto che il regno sembra non conoscere le proprie reali origini. Ci sono miti e filastrocche, ma i testi e i reperti consultabili coprono un arco temporale non troppo remoto e su cosa sia capitato prima c’è ancora del gran mistero. Il Dipartimento di Storia tormenta da anni la costa sabbiosa, cercando non si sa bene quale antenato. Un bel giorno, però, una duna ingiustamente snobbata restituisce una città… e dona un’occasione d’oro all’imperatore. Che si tratti della capitale perduta dei Morgondi, i leggendari avi del nostro popolo? I valorosi guerrieri delle fiabe sono tornati per indicarci la via!
Ci troviamo in un nebuloso regno marittimo governato da un imperatore teatralissimo e troppo fanciullesco per destare sospetti di particolare pericolosità. Il regno è dotato di una società ordinata, di università e di una popolazione poco incline ai colpi di testa. Non si capisce bene che cosa s’insegni a scuola, però, visto che il regno sembra non conoscere le proprie reali origini. Ci sono miti e filastrocche, ma i testi e i reperti consultabili coprono un arco temporale non troppo remoto e su cosa sia capitato prima c’è ancora del gran mistero. Il Dipartimento di Storia tormenta da anni la costa sabbiosa, cercando non si sa bene quale antenato. Un bel giorno, però, una duna ingiustamente snobbata restituisce una città… e dona un’occasione d’oro all’imperatore. Che si tratti della capitale perduta dei Morgondi, i leggendari avi del nostro popolo? I valorosi guerrieri delle fiabe sono tornati per indicarci la via!
 Cosa succede? Una scrittrice incontra per caso per strada l’attrice che una quindicina d’anni prima aveva interpretato il personaggio “scandaloso” del suo libro d’esordio, bestseller lettissimo e chiacchieratissimo. Sia la carriera di Clara T. che della nostra autrice sembrano aver seguito parabole di “contrazione” della fama ipertrofica degli inizi ma, se la scrittrice ha continuato a lavorare e si è costruita una famiglia felice e “regolare”, di Clara T. si sono completamente perse le tracce.
Cosa succede? Una scrittrice incontra per caso per strada l’attrice che una quindicina d’anni prima aveva interpretato il personaggio “scandaloso” del suo libro d’esordio, bestseller lettissimo e chiacchieratissimo. Sia la carriera di Clara T. che della nostra autrice sembrano aver seguito parabole di “contrazione” della fama ipertrofica degli inizi ma, se la scrittrice ha continuato a lavorare e si è costruita una famiglia felice e “regolare”, di Clara T. si sono completamente perse le tracce.


 1950. Valeria Cossati compra un quaderno e comincia a usarlo per registrare gli accadimenti della sua vita. Scrive sentendosi in colpa, nascondendosi e nascondendolo, un po’ perché il tempo che dedica al quaderno è tempo sottratto ai doveri domestici e un po’ perché quello che scopre, scrivendo, è un grumo indigesto e contraddittorio di sincerità fin troppo limpide. Valeria ha di poco superato i quaranta e ha due figli grandi, un lavoro in ufficio e un marito. La famiglia la assorbe e la riassume, la definisce e la mangia, le garantisce un presente solido ma le impedisce di immaginarsi diversa… almeno fino all’arrivo di quel quaderno, comprato d’impulso e destinato a diventare l’unico posto in cui coltivare la solitudine necessaria a rimettere in moto i pensieri. Scrivere nel quaderno diventerà per Valeria un esercizio di identità, un’operazione di auto-smascheramento e di reazione autentica ai tanti urti minimi di una quotidianità fatta di automatismi, conformismi e rospi inghiottiti in silenzio.
1950. Valeria Cossati compra un quaderno e comincia a usarlo per registrare gli accadimenti della sua vita. Scrive sentendosi in colpa, nascondendosi e nascondendolo, un po’ perché il tempo che dedica al quaderno è tempo sottratto ai doveri domestici e un po’ perché quello che scopre, scrivendo, è un grumo indigesto e contraddittorio di sincerità fin troppo limpide. Valeria ha di poco superato i quaranta e ha due figli grandi, un lavoro in ufficio e un marito. La famiglia la assorbe e la riassume, la definisce e la mangia, le garantisce un presente solido ma le impedisce di immaginarsi diversa… almeno fino all’arrivo di quel quaderno, comprato d’impulso e destinato a diventare l’unico posto in cui coltivare la solitudine necessaria a rimettere in moto i pensieri. Scrivere nel quaderno diventerà per Valeria un esercizio di identità, un’operazione di auto-smascheramento e di reazione autentica ai tanti urti minimi di una quotidianità fatta di automatismi, conformismi e rospi inghiottiti in silenzio.
 Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.
Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.


 Dalla gestione domestica all’organizzazione della famiglia, dai compiti di “cura” alle operazioni basilari e ripetitive che garantiscono il buon funzionamento di una casa, con
Dalla gestione domestica all’organizzazione della famiglia, dai compiti di “cura” alle operazioni basilari e ripetitive che garantiscono il buon funzionamento di una casa, con